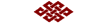Una prospettiva interculturale: pratica buddhista e vocazione cristiana
Una prospettiva interculturale: pratica buddhista e vocazione cristiana
Pochi concetti sono stati così centrali nel definire l’identità dell’uomo della moderna civiltà occidentale come quello di lavoro: tant’è vero che solo alcuni decenni fa pareva ovvio considerarla civiltà del lavoro.
Da allora molto tempo è passato. Tutta un’enfasi che rappresentava l’avventura umana come volta all’edificazione di un mondo autosufficiente, nelle versioni atee, o che imita e prolunga l’opera creatrice di Dio, in quelle religiose, suona irrimediabilmente datata. L’avvento del clima culturale postmoderno ha posto fine all’epoca delle grandi narrazioni; d’altra parte l’affiorare della coscienza ecologica ha gettato più che un velo di sospetto sul fondamentale correlato del lavoro, cioè la tecnica; infine l’automazione, il decentramento produttivo e la finanziarizzazione dell’economia hanno fatto sì che il lavoro si eclissasse dallo spazio sociale delle società di più matura modernizzazione, lasciando un vuoto avvertito come sempre più angoscioso. Il fatto che quello spazio sociale sia stato riempito dal proliferare dei consumi ha generato un’euforia intrisa di angoscia essa stessa, come nel presentimento di un ineluttabile esaurirsi delle risorse a cui si attinge.
Complesso e variamente definito è lo scenario entro cui la crisi in atto si colloca.
Per il pensiero della Decrescita, urge un cambiamento rispetto al paradigma finora dominante negli indirizzi della nostra civiltà: quello dello sviluppo. Bisogna ragionevolmente pensare a ridurre l’impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, a riequilibrare l’uso delle risorse, a uscire da una visione ristretta dell’economia come unilateralmente finalizzata al profitto, tenendo invece conto del complesso delle condizioni sociali, tutt’altro che riducibili a termini monetari, entro cui si svolge la vita degli individui.
Termini diversi, anche se non del tutto contrastanti, usa la riflessione che più è in sintonia con la Dottrina Sociale della Chiesa, secondo cui la crisi deriva dalla distruzione del capitale sociale accumulato nella precedente fase storica, costituito dal tessuto associativo e partecipativo che plasmava il contesto dei rapporti umani e rendeva possibili le relazioni economiche. Ma poiché tale distruzione è frutto di un pensiero, come quello dominante nell’economia capitalistica, orientato a privilegiare le relazioni strumentali, si può uscire dalla crisi riconoscendo, come nell’Economia Civile teorizzata da Zamagni e Bruni, il primato della reciprocità, ovvero di atti che, impegnando gli individui a corrispondere, li coinvolgono nella costruzione di relazioni sociali.
Su un altro piano ancora, ma non senza rilevanti analogie d’ispirazione, è l’utopia tecnologica della Terza Rivoluzione Industriale di Rifkin: cioè il passaggio dalla fase storica delle grandi concentrazioni industriali alimentate dai carburanti fossili, in connessione col sistema dei mass-media quale si è configurato lungo il Novecento, a un nuovo sistema tecnologico e sociale basato sulla combinazione di internet e delle fonti di energia rinnovabile. Ebbene, la nuova fase storica, caratterizzata dal modello della diffusione e dell’interdipendenza piuttosto che da quello della concentrazione e del conflitto, consentirebbe una svolta rispetto al paradigma antropologico finora dominante: anziché l’egoismo come struttura originaria dell’uomo, su cui le istituzioni sociali consentono di esercitare un controllo, l’empatia. Una civiltà mondiale basata sull’empatia è, secondo Rifkin, l’orizzonte che si apre al di là delle angustie attuali.
In ogni caso, quale che sia lo scenario che ci si rappresenta, comune è la percezione di trovarci a una svolta che immette in una forma di convivenza notevolmente diversa da quelle del passato, che chiama perciò a riflettere su cosa l’uomo sia al di là delle contingenze temporali. E, in una riflessione di questo tipo, proprio qualora una nuova e più ampia visione dell’economia si stia preparando, ineludibile è il problema del lavoro, perché è il problema della stessa soggettività umana.
Il fatto che il lavoro si presenti oggi in termini così problematici è spiegabile pensando che si tratta di una questione, prima ancora che sociale, culturale. Il che può essere chiarito a partire da due considerazioni.
La prima è che la nozione di lavoro, intesa come categoria che classifica un ambito separato dal complesso delle attività umane, è tipica della società occidentale e non trova riscontri puntuali in altre culture. Non ha senso ad esempio chiedersi quanto e come lavorasse l’uomo preistorico: semplicemente prendeva parte a varie attività comunitarie, da alcune delle quali traeva i mezzi di sostentamento.
La seconda considerazione è che, nella cultura occidentale a partire dalle sue radici bibliche, il lavoro è connotato in termini contraddittori: da un lato inteso come compito affidato da Dio stesso all’uomo di realizzare, assoggettando la natura, una propria sfera di libertà; dall’altro come maledizione conseguente al peccato: guadagnerai il pane col sudore della fronte… Il che spiega l’ambivalenza di un atteggiamento facilmente riscontrabile, che fa sì che il lavoro sia insieme cercato e fuggito, vissuto come dignità e riscatto e insieme come degradazione. Null’altro può rappresentare questa ambivalenza, spinta oltre il limite del mostruoso, della scritta ‘Il lavoro rende liberi’ collocata all’ingresso di Auschwitz; ma anche l’attuale sparizione del lavoro dall’orizzonte della nostra società, dove è ufficialmente affermato il principio della sua dignità, e il suo rifluire ai margini, nelle aree povere dove si dispiega la realtà della degradazione, è un segno inquietante di un nodo che attende forse ancora di essere risolto. Quel che si vuole qui proporre è un contributo in tale direzione.
Tale contributo non sarebbe possibile se non avessimo oggi un’opportunità per lo più assente in passato: quella di osservare le convinzioni più radicate nella nostra coscienza culturale dal punto di vista di altre culture, che hanno compiuto altri percorsi. È un’opportunità che nella nostra epoca è stata variamente esplorata, con esiti ancora in gran parte da inventariare; e un’esperienza particolarmente significativa in questo contesto è quella compiuta da uno degli autori a cui la riflessione sull’economia oggi non può che ispirarsi: Ernst Friedrich Schumacher, l’autore del famoso libro Piccolo è bello, a suo tempo manifesto della critica dell’economia moderna nel periodo (i primi anni settanta) in cui era all’apice dei suoi trionfi.
In un capitolo di quel libro, intitolato Economia buddhista, Schumacher, sulla base di prolungati soggiorni in Birmania, fa un’affermazione di cui non sono state forse finora colte tutte le implicazioni. La funzione del lavoro, egli dice, è triplice: dare a una persona la possibilità di utilizzare e sviluppare le proprie facoltà; permetterle di superare il proprio innato egocentrismo unendosi agli altri in un compito comune; produrre i beni e i servizi necessari a tutti noi per un’esistenza decente.
È del tutto evidente che l’ordine in cui la triplice funzione viene enunciata ribalta quello che nell’economia moderna è considerato ovvio: cioè il fatto che il lavoro sia innanzitutto finalizzato a produrre condizioni di sussistenza. Anche nella filosofia da cui ci sembra che il lavoro sia maggiormente esaltato, quella di Marx, in quanto attività attraverso cui l’uomo realizza se stesso nella storia, ciò in realtà presuppone una visione materialistica, ovvero la convinzione che il piano della produzione materiale sia quello che fondamentalmente regola la vita umana. Nella visione buddhista invece l’esistenza umana è indirizzata a un fine di purificazione spirituale, ed è comprensibile quindi che anche le attività economiche vi siano subordinate. Il che significa, non solo che esse sono orientate alla limitazione dei bisogni piuttosto che al loro ampliamento, ma che il lavoro assume altre valenze da quelle che ci sono abituali.
In realtà la categoria di ‘economia buddhista’ non esisteva prima che Schumacher la formulasse, ma è notevole che da quel momento sia stata adottata in Oriente nella riflessione e nella prassi di movimenti religiosi e sociali. Hanno avuto luogo convegni internazionali e addirittura sono sorte comunità che hanno inteso il lavoro, soprattutto agricolo, come pratica spirituale contrapposta a quella ‘oziosa’ del monachesimo ufficiale. Ma soprattutto quella categoria rende possibile un termine di confronto per valutare la storia culturale dell’Occidente.
Negli ultimi anni della sua vita Schumacher, convertitosi al cattolicesimo, ribadì infatti la triplice funzione del lavoro, considerandola propria di una saggezza tradizionale i cui insegnamenti hanno da fare col senso della vita molto più dello scientismo materialista dominante.
Potrebbe apparire che questo senso del lavoro enunciato da Schumacher, buddhista o più genericamente tradizionale, non sia lontano da quell’etica del lavoro che ritroviamo nella memoria storica dell’uomo moderno, di cui ci sembra di cogliere le radici nel cristianesimo, nella regola di San Benedetto e poi nella Riforma; tuttavia un’innegabile imbarazzo sorge al riguardo. Troppo intenso è il ricordo della coercizione e dell’alienazione che sono state per lo più tipiche della moderna produzione industriale, perché quell’etica non appaia gravata da sospetto.
D’altra parte innegabile è oggi l’esigenza che il lavoro sia vissuto come servizio, prima ancora che come mezzo di sussistenza, e visibilmente riscontrabile in fenomeni sociali come il volontariato; così come lo è quella di uscire dalle angustie dell’utilitarismo, e riscoprire la soddisfazione del lavoro, non solo la sua triste necessità: ricongiungendosi in questo alla saggezza delle società tradizionali, sia pure al termine di un percorso che è stato tipico dell’Occidente.
Bisogna però allora guardare più in profondità in quel percorso. Si propone, ancorché per pochi cenni, una chiave di lettura.
Proviamo a pensare che il racconto biblico, che rappresenta la condizione umana come corrotta dal peccato, corrisponda a un passaggio antropologico riscontrabile sul piano storico: il passaggio dal sistema delle piccole comunità, in cui la saggezza tradizionale era il principio regolatore, a quello dei grandi imperi, che organizzano vaste popolazioni sulla base del funzionamento della propria macchina militare e produttiva. Pensiamo ancora che, per quanto tale passaggio si sia verificato anche altrove, come in India e in Cina, con l’edificazione di grandi società stratificate, in Occidente abbia inciso con particolare durezza, con l’affermarsi, nel Vicino Oriente e poi in Grecia e a Roma, del sistema schiavistico: cioè un sistema che degrada una parte dell’umanità a puro strumento di produzione.
Non è indifferente che in quel contesto appaia la nozione di lavoro, che in origine designa la fatica degli schiavi; come non lo è che da quella condizione si sia innalzata l’invocazione al Dio biblico, cioè al Signore che libera da un’oppressione materiale e spirituale insieme. Appare anche chiara la collocazione storica dell’evento cristiano, in cui Dio stesso penetra in quel dolore, lo attraversa e lo riscatta: dopo di che il lavoro può diventare affine alla preghiera (Ora et labora), su una via di imitazione di Cristo. Quando poi, alle soglie dell’epoca moderna, la Riforma traduce la vocazione di fede (Beruf) in impegno operoso e responsabile nel proprio contesto sociale, non fa che attingere a un principio costitutivo del Cristianesimo e già almeno implicito nell’Ebraismo: il rovesciamento di un’ingiustizia radicale, per cui altri esseri umani sono ridotti a strumenti, in una riparazione altrettanto radicale, perché basata sul dono completo di sé nel servizio.
E proprio perché l’ombra oscura dello schiavismo non ha mai del tutto abbandonato l’Occidente, assumendo di volta in volta nuove forme, dal lavoro alienato di fabbrica ai campi di concentramento del secolo scorso, il lavoro ha acquistato un ruolo così centrale: perché simbolicamente rappresenta il sottile crinale che divide il riscatto dalla disumanizzazione.
Appare dunque chiaro che anche in Occidente, dietro l’involucro utilitaristico, il lavoro ha essenzialmente un senso morale e spirituale, e rendersi consapevoli di ciò può aiutare a ricostruirne la dimensione sociale.
Noi oggi abbiamo bisogno di uscire dal consumismo e di ritrovare il lavoro; e non solo per la ragione banale che l’assenza di lavoro erode le risorse da devolvere ai consumi; ma per quella più profonda che il consumismo è la forma di schiavitù più raffinata, che paralizza la volontà arrivando a rendersi massimamente desiderabile; mentre il lavoro effettivamente restituisce all’uomo la sua dignità, perché lo pone di fronte a se stesso, agli altri, alle prove, al senso della vita.