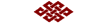Quel che segue non è un lavoro accademico: parlerò di Emanuele Severino rinviando ad altra occasione un confronto puntuale coi testi. Darò qui per scontato che il nucleo del suo pensiero sia sufficientemente noto, e che in tutta la sua produzione scritta, nonché nelle numerose apparizioni pubbliche, l’abbia continuamente esposto e articolato. Tanto più che il suo pensiero egli non ha voluto considerarlo suo, bensì come l’emergere di un sapere inaudito, sconosciuto a ogni precedente tradizione sapienziale.
Quel che segue non è un lavoro accademico: parlerò di Emanuele Severino rinviando ad altra occasione un confronto puntuale coi testi. Darò qui per scontato che il nucleo del suo pensiero sia sufficientemente noto, e che in tutta la sua produzione scritta, nonché nelle numerose apparizioni pubbliche, l’abbia continuamente esposto e articolato. Tanto più che il suo pensiero egli non ha voluto considerarlo suo, bensì come l’emergere di un sapere inaudito, sconosciuto a ogni precedente tradizione sapienziale.
Posta la cosa in questi termini, è d’altronde evidente come il confronto con lui vada ben oltre il piano accademico. Bisogna forse assumersi la responsabilità di pronunciarsi intorno al senso di quel sapere, ed eventualmente al suo rapporto con le tradizioni sapienziali umane.
Sarei tentato di dire che parlerò a nome di una di esse, quella che scaturisce dall’insegnamento del Buddha, ma potrebbe essere una semplificazione. Una tradizione infatti non è un’istituzione e neppure un corpus dottrinario, bensì innanzitutto un’ispirazione profonda che può assumere di volta in volta forme diverse. Potremmo addirittura in questo caso avere la sorpresa di consonanze inaspettate. Il pensiero di Emanuele Severino, o quel che emerge attraverso di esso, potrebbe non solo non essere lontano da ciò in cui io mi trovo inserito, ma, per quanto egli non ne avesse diretta conoscenza – della cosa posso personalmente testimoniare –, inopinatamente dischiuderne una rinnovata comprensione.
Ragioni di perplessità
Mi sia consentita una nota autobiografica.
Colui che per molti anni è stato il mio maestro, un occidentale diventato monaco nella tradizione del Dalai Lama, aveva per Emanuele Severino una grande ammirazione. Riteneva che la sua filosofia fosse molto vicina all’insegnamento buddhista, tant’è vero che mi chiese di mettermi in contatto con lui. Cosa che io lo feci, pur non senza qualche dubbio.
Quel che soprattutto mi lasciava perplesso era l’impressione che l’intera sua visione scaturisse da un semplice argomento logico, che portava alle estreme conseguenze la lettura classica di Parmenide, quella a cui, a partire da Platone e Aristotele, siamo avvezzi. Una lettura che potrebbe anche essere viziata da qualche equivoco[1].
Ma, a prescindere da ciò, posto che sul piano logico sia lecito pensare che l’essere è e non essere non è, e che il divenire - che implica che, quel che è, prima non era e poi non sarà più - possa comportare una mescolanza indebita di essere e non essere; può tutto ciò autorizzare a negarne la realtà, così come l’esperienza comune sembra con ogni evidenza testimoniare? Cioè a negare il carattere perituro delle cose e di noi stessi?
È ben vero che la filosofia non ha il compito di confermare il senso comune, bensì anzi talora lo sovverte; ma è davvero accettabile che ciò possa avvenire in conseguenza di un’argomentazione logica?
Al di là del contenuto specifico di ciò di cui si parla, non potrebbe trattarsi di una violenza che il pensiero astratto compie sull’esperienza, dichiarandola insufficiente a conoscere la realtà?
La questione non è di poco conto. Ci sono stati tempi in cui si riteneva, dal semplice concetto di Dio, di poterne dimostrare l’esistenza. La conseguenza era che non ammetterla sarebbe stato un atto di colpevole irragionevolezza.
Poi argomenti di quel tipo sono caduti in discredito, e hanno contribuito all’atmosfera di sospetto che è venuta addensandosi sulla religione e sulla filosofia stessa. I dati del senso comune hanno così finito per apparire l’unico criterio di verità, dimenticando che il senso comune muove da presupposti di cui è inconsapevole.
È dunque più che comprensibile che nella coscienza profonda del nostro tempo si trovi un disagio diffuso, a cui un pensiero così inattuale come quello di Severino ha dato voce. Il che spiega il sua grande fascino, pur nella sua apparente assurdità.
Ciò a cui ha saputo restituire forma è l’esigenza, insopprimibile nell’uomo, di una visione non banale delle cose. Il che è senz’altro una ragione sufficiente per essere inclini a riconoscerne il valore, ma non ci mette ancora in grado di capirne il senso.
Aspetti di fascino
Ammettiamo che sia tipico della filosofia occidentale la ricerca di uno stabile fondamento a quel che di multiforme ed effimero si mostra nell’esperienza comune, ovvero ciò che Platone identificò nelle forme del pensiero astratto: cioè, come noto, le idee. È in questo orizzonte di pensiero che il piano della realtà in senso proprio ed eminente viene investito di una funzione sovraordinata all’esperienza comune.
È poi tipico della filosofia più a noi vicina sottoporre a critica quel modello, affermando che il suo motore occulto, come Severino afferma, e prima di lui Heidegger, è la volontà di potenza, dapprima implicita nella metafisica antica e poi esplicita nella tecnica moderna.
Aver creato uno schema narrativo che consente una comprensione critica globale dell’intero pensiero occidentale costituisce il grande fascino tanto di Heidegger quanto di Severino. Con la differenza che, mentre il primo attribuisce la deriva dell’Occidente a un originario oblio dell’Essere, cioè la sua riduzione a ente, il secondo la imputa al suo non essersi attenuto alla verità scoperta da Parmenide: che l’essere è e il non essere non è, e quindi non esiste il divenire, perché ammetterlo significa ammettere l’esistenza del nulla.
Nella visione di Severino la folle ammissione dell’esistenza del nulla, cioè il nichilismo, è la radice della tecnica e del suo potere distruttivo. Né sarebbe per lui risolutivo richiamarsi a ciò che è tradizionalmente esente dal divenire, cioè Dio. La credenza che Dio abbia creato il mondo dal nulla mette anzi nella massima evidenza il modello di pensiero a cui la tecnica si collega.
Non resta che l’accettazione radicale di quanto ci pare di cogliere in Parmenide: cioè che esiste solo l’essere. E se non c’è il non essere, quindi non c’è il divenire, noi stessi e ogni cosa, in ogni sua manifestazione, siamo eterni.
Un punto d’arrivo o altro ancora?
Come ho chiaramente detto, per quel che mi riguarda le ragioni di perplessità verso questo tipo di pensiero non dipendevano dal suo contrasto col senso comune, bensì dal fatto che una comprensione della realtà di tale portata venga fatta scaturire da un puro argomento logico. Si tratta di un dubbio che rischia di compromettere il pensiero di Severino alla radice, mostrandolo addirittura in connessione con ciò che denuncia, ovvero la volontà di potenza.
La convinzione più folle è che l’esistenza sorga dal nulla, o non piuttosto che il pensiero logico-discorsivo davvero afferri la realtà?
Avrei appreso successivamente che in quello stesso periodo una obiezione di questo tipo gli venne avanzata da Raimon Panikkar in un celebre confronto avvenuto a Venezia nel 2004, poi trasformato in libro[2].
Si trattò di un confronto in cui però i due interlocutori non andarono davvero a fondo della questione. Severino, come sempre concentrato nell’esporre il suo pensiero, nella convinzione che non fosse propriamente suo, probabilmente non capì l’obiezione che Panikkar gli muoveva. E quest’ultimo da parte sua non la presentò in modo davvero incisivo, né si mostrò più di tanto interessato ad accogliere il senso di ciò che affermava Severino.
Quel mancato incontro non consentì allora di cogliere con chiarezza la strada su cui oso dire si dovrà camminare, e che forse, ancora inconsapevoli, abbiamo già intrapreso. Tanto più che Panikkar non era poi così lontano da Severino, quando parlava di tempiternità: cioè l’attimo che io vivo non ha solo un valore temporale ma si dilata al di là del tempo[3]. Questa mia riflessione, oltre che essere un omaggio a entrambi, intende dunque contribuire a far sì che quella strada inizi davvero a intravedersi.
Tre diverse prospettive
Prima di proseguire, va però osservato che Panikkar, che non ha particolarmente riflettuto sulla storia della filosofia occidentale antica, era anch’egli incline a riconoscere in Parmenide il riferimento decisivo, ma con un’intenzione opposta: quel che bisogna infatti abbandonare è il presupposto dell’identità del pensiero e dell’essere, che a Parmenide si attribuisce[4]. E questo è secondo Panikkar il senso fondamentale dell’incontro odierno dell’Occidente con l’Oriente, e in particolare con l’insegnamento del Buddha[5].
Si osservi poi che tanto Severino quanto Panikkar si collegano a Heidegger e ne accolgono l’ispirazione più feconda: cioè l’interpretazione della crisi dell’Occidente alla luce di un nodo che si trova alla sua origine. Per Heidegger, come noto, si tratta della riduzione dell’Essere a ente; per Panikkar della sua identificazione col pensiero; per Severino dell’attribuzione di realtà al divenire.
Dal punto di vista dei riferimenti, le tre prospettive presentano analogie, ma anche differenze. Diverso è lo sfondo culturale, perché alle spalle di Heidegger c’è la mistica tedesca, Panikkar guarda all’India e il pensiero di Severino scaturisce da un contesto neotomista, nel quale, attraverso un ritorno alla metafisica classica, si cercavano antidoti al soggettivismo dominante in epoca moderna. E, per quanto Severino prenda una direzione propria, che conduce ben lontano da quel contesto, un giudizio sul suo pensiero non dovrebbe prescindere dal rapporto con Platone ed Aristotele.
Diversa è anche la direzione che le tre prospettive dischiudono.
Ad apparire oggi di gran lunga più feconda è la via di Panikkar, che viene a costituire il principale riferimento del grande confronto tra Occidente e Oriente che occupa la scena culturale dei giorni nostri. Quella di Severino sembra invece priva di sbocco. Il suo appare un percorso solitario, che non lascia eredi, e la sua morte potrebbe simbolicamente rappresentare il punto d’arrivo di un pensiero occidentale non più giustificato a considerarsi autosufficiente.
A meno che qualcosa affiori in lui di cui egli stesso non è pienamente consapevole.
Il contenuto oltre il metodo
Ebbene, tornando all’elemento autobiografico, sono dovuto giungere alla conclusione che quel mio maestro, nonostante le mie fondate ragioni di perplessità, avesse ragione.
Intendo dire che, per essere coerenti con la riflessione finora svolta, qualora non sia accettabile ricavare da un semplice argomento logico il valore di verità di una visione del reale, neppure lo è il contrario: cioè che, dalla sua esclusione, quella visione sia confutata. Quell’argomento potrebbe infatti essere null’altro che il pretesto per qualcosa che non ne dipende affatto.
Difficile sapere cosa Severino ne penserebbe, ma nella sua filosofia potrebbe affiorare una verità che è davvero tale anche se non per le ragioni che egli adduce. E, se così fosse, ne conseguirebbe la confutazione del suo metodo, ma non del contenuto del suo pensiero. Che è ciò da cui davvero ci sentiamo interpellati.
Parlo naturalmente dell’affermazione, in radicale contrasto col senso comune e che però apre squarci nella coscienza, dell’eternità delle cose e di noi stessi. Di questo in realtà ci importa, non di Parmenide.
Si potrebbe addirittura pensare che la filosofia di Severino consenta di attribuire un senso nuovo a ciò che caratterizza in profondità il vissuto religioso: cioè la convinzione che la morte non abbia l’ultima parola, quindi, detto in termini cristiani, la fede nella vita eterna.
So bene come Severino non avesse grande stima della fede. La sua figura si trova ancora su una linea che da Platone e Aristotele giunge a Hegel e a Marx e Nietzsche, senza risparmiare neppure Heidegger, lungo la quale in vario modo si ritiene che la filosofia sia oltre la religione. Dobbiamo però attenerci a quel che personalmente egli pensava, o a ciò che, come egli stesso dice, affiorava in lui, e quindi potrebbe anche prescindere dalla comprensione che ne aveva, necessariamente condizionata dal contesto culturale in cui si era formato?
Cosa vieta di pensare che, nonostante egli si sia personalmente allontanato dalla religione, nel suo pensiero si sia manifestato in una forma sotto qualche aspetto nuova quello che è al cuore di ogni tradizione religiosa, cioè l’intuizione che la dimensione temporale non ha un valore assoluto?
Se poi la fede non fosse quel che comunemente si pensa, cioè un credere quel che non può essere dimostrato, bensì, come Panikkar ci invita a pensare, una comprensione più profonda delle cose[6], non finiremmo per vedere Severino in una luce ancora più intensa di quella in cui egli stesso si rappresentava? Non ci apparirebbe come inaspettata via d’accesso a una rinnovata comprensione del nucleo più profondo dell’esperienza di fede?
Sarebbe fargli torto affermare che la verità che affiora in lui, più che un sapere inaudito, sconosciuto a ogni sapienza precedente, riporta a un sapere originario, che ogni sapienza autentica custodisce nei suoi più intimi recessi, e per lo più dissimula e talora oblia, come accaduto in Occidente?
Cosa è la filosofia?
Una possibilità di questo tipo mette evidentemente in discussione ciò che in Occidente si è inteso con filosofia. Si determinerebbe infatti una situazione singolare. L’attività che più di ogni altra dovrebbe esprimere la coscienza razionale umana potrebbe non solo mancare di piena consapevolezza della sua natura e della sua funzione, ma soprattutto non essere chiaramente distinguibile dalla religione, o addirittura contribuire all’occultamento della verità che in essa è contenuta.
La stessa idea di verità non è d’altra parte univoca. La si può intendere in senso formale, come corrispondenza tra un’affermazione e un dato di fatto, ovvero come coerenza interna di un costrutto mentale; oppure come manifestazione di un senso profondo delle cose che normalmente rimane nascosto. E, se la filosofia è ricerca della verità, nel primo caso si avvicina alla scienza, o quanto meno alla logica; nel secondo invece è assai prossima alla religione. Sul piano esistenziale la differenza è che, mentre da un lato si mira semplicemente a conferire ordine al rapporto col reale, dall’altro ci si mette profondamente in gioco. La verità che si cerca, nel secondo caso, è inseparabile da una trasformazione personale.
Non ci vuole molto per capire come tutto il fascino che la filosofia ha esercitato lungo i secoli si debba per lo più a questa seconda possibilità. Chi si avvicina alla filosofia ha certo bisogno di ordine e coerenza nei pensieri, ma soprattutto di aprirsi a qualcosa di più grande. Le sue aspettative non sono dunque così diverse da quelle alimentate dalla religione, per quanto i mezzi paiano esserlo.
Mi sento insomma di proporre che al centro della filosofia di Severino si colga un senso della verità che, sebbene per la forma in cui è presentato paia inclinare nella prima direzione, è interamente proiettato nella seconda. Si tratta di un pensiero che ha la potenza di un’intuizione spirituale, ed è per questo che attrae irresistibilmente, nonostante il contrasto col senso comune e anzi proprio grazie a quello.
La convinzione nell’eternità delle cose non può scaturire da un ragionamento, per quanto se ne possano trovare di supporto e anche migliori di quello attribuito a Parmenide. Anzi, la considerazione che andrebbe fatta è che pensieri di questo tipo neppure sorgerebbero in noi se non avessimo in qualche modo esperienze che vi corrispondono.
È questa in fondo l’unica argomentazione davvero convincente. Non potremmo parlare dell’eternità, né tanto meno averne un’intuizione così intensa come ha Severino, se non ne facessimo esperienza.
Angustie della filosofia come professione
Quando personalmente conobbi Severino, non potei evitare di pensare qualcosa di simile a ciò che a suo tempo si pensò di Schopenhauer, colui attraverso la cui opera per la prima volta l’Oriente fa il suo ingresso nella filosofia occidentale: al quale si poteva ben rimproverare che, avendo formulato una visione il cui esito era una via ascetica di liberazione dalla sofferenza, non si fosse sentito impegnato a intraprenderla personalmente. Ebbene, altrettanto mi accadde di pensare al cospetto di Severino: come è possibile che chi abbia un’intuizione così profonda, come quella dell’eternità delle cose, si limiti a scriverne e a tenere conferenze?
Quel che per lo più ci sfugge, studiando la filosofia antica sui manuali, è che essa aveva un fondamentale carattere di insegnamento di vita. Diventare allievi di Pitagora, oppure degli stoici o di Epicuro, voleva dire assumere una condotta di vita coerente con una visione della realtà. Sicuramente questa era l’intenzione di Platone nel fondare l’Accademia, quali che ne siano poi stati gli esiti; mentre non lo era quella dei sofisti, progenitori degli intellettuali moderni, ma anche per questo accusati da Platone di essere falsi filosofi. Sospendendo il giudizio su Aristotele, che è forse la cerniera tra due mondi, si può senz’altro dire che originariamente la filosofia sia molto vicina ad essere via spirituale, sebbene in rapporti di volta in volta diversi col sistema religioso ufficiale.
È invece tipico dell’Europa moderna, in cui si formano istituzioni del sapere laico in contrapposizione a quelle religiose, che la filosofia perda questo ruolo, diventando piuttosto la professione di coloro che sovrintendono agli orientamenti dell’opinione pubblica, incanalandola in direzioni socialmente convenienti. Questa è la ragione per cui i filosofi moderni scrivono libri e tengono conferenze, mediamente cercando di rispecchiare quel che Hegel chiamava spirito del tempo, che è tutt’altro dalla ricerca spirituale.
Personaggi come Severino e Heidegger sono visti con una certa diffidenza dagli accademici più incalliti, perché si avverte in essi una fastidiosa vocazione al vaticinio; ma non per questo sono venuti meno alla solidarietà con un ceto sociale la cui funzione, nella varietà degli indirizzi, è in fondo rigorosamente delimitata.
Pur avendo vissuto un’esperienza conoscitiva indistinguibile da quella mistica, non si sono concessi di concepirla se non negli angusti confini di un sapere che, per come è venuto definendosi in età moderna, è in fondo autoreferenziale; il cui prestigio è inversamente proporzionale all’effettiva capacità di rivolgersi alla vita degli uomini.
Si avverte in essi – pensiamo a Heidegger, ma ancor più a Nietzsche – la sofferenza di sentirsi imprigionati in una forma sociale inadeguata, di non poter attingere a piene mani all’ispirazione da cui si sentivano chiamati e farsene a buon diritto tramite per il beneficio di tutti.
Ma ora che tutto ciò è lecito pensare volga storicamente al termine, non potrebbe essere il momento del riscatto, in cui anche quella sofferenza venga accolta e riconosciuta nella sua effettiva verità?
In tutt’altra luce
Facciamo un passo indietro in ciò che in termini convenzionali è comunque il tempo, risalendo a circa due millenni e mezzo or sono.
Immaginiamo che, nel cuore della grande civiltà dell’India antica, un certo personaggio, seduto in meditazione ai piedi di un albero, in una notte di luna piena abbia conseguito una comprensione non poi forse così diversa.
Parliamo di un personaggio della cui storicità non abbiamo ragione di dubitare, ma che ci è noto come il protagonista di una narrazione in virtù della quale si trovò a essere innalzato a paradigma della perfezione umana.
Ebbene, in quella notte di luna piena, ci viene narrato di un evento tale che non avrebbe potuto essere in alcun modo comunicato, almeno nei termini in cui si parla delle cose quotidiane, perché su di esse si era aperto tutt’altro sguardo - escludiamo quindi libri e conferenze. Quel che ci viene invece detto è che quel certo personaggio rimase a lungo in silenzio, dubitando di poter mai dire quel che aveva compreso.
Può darsi che fosse consapevole di un problema serio. Non solo le parole sarebbero state inadeguate a esprimere qualcosa di tanto grande, ma lo avrebbero messo a rischio. Coloro che neppure lontanamente avevano vissuto una simile esperienza, riducendo tutto alla propria misura, sarebbero riusciti, anche involontariamente, a banalizzarne e distruggerne il senso.
Si tratta di un problema che chiunque, investito di un certo ruolo, deve essersi posto. Quando si attinga la verità, intesa come il manifestarsi del senso profondo delle cose, prima ancora che annunciarla bisogna custodirla: impedire che venga deturpata e dispersa. Un altro personaggio, vissuto alcuni secoli dopo in Palestina, ammoniva addirittura a non dare perle ai porci.
Per questo le comunicazioni in questi ambiti sono tutt’altro che descrittive. Prevale piuttosto l’enigma: si dice e insieme si nasconde. Oppure il mito, o il racconto immaginifico in genere, o infine l’evento. Quel certo personaggio in Palestina si esprimeva per lo più in parabole, e infine offrì in sacrificio la sua vita. E il simbolo più grande che lasciò ai suoi discepoli, in cui la sua persona interamente si risolse, fu non a caso la Resurrezione: cioè la vittoria sulla morte. Ma nella cornice religiosa entro cui si inseriva, la morte è conseguenza della colpa[7].
Anziché dimostrare, vivere
Ma torniamo in India. Ci è dato supporre che in quel silenzio, che fece seguito alla notte della grande comprensione, sia maturata una decisione ben precisa.
Dire sarebbe stato inutile. Bisognava condurre a vivere quell’esperienza. Chi l’avesse vissuta non avrebbe più avuto bisogno d’altro.
Le parole sarebbero servite a questo, e ancor più l’esempio. Si trattava di proporre a tutti una cornice di senso, in cui la vita in quanto tale fosse cammino di ricerca; e poi un metodo efficace per rendere la ricerca fruttuosa. Ciò intorno a cui si trattava di comunicare non era la verità, bensì il modo per attingerla.
Intorno alla verità infatti il nostro personaggio si mostrò sempre reticente; o meglio, interpellato, rientrava in quel silenzio nel quale certo la considerava meglio custodita. Anzi, insegnò più che altro a coltivare quel silenzio, facendolo diventare lo spazio luminoso in cui la verità si manifesta.
Tutte le parole che usò, diverse a seconda di coloro a cui di volta in volta si rivolgeva, più che aver valore in se stesse, avvicinavano a quel silenzio da cui intimamente non si era mai staccato. Egli era quel silenzio, che ciascun ricercatore, consapevole di esserlo, aspira ad incontrare.
Non è questo il luogo per entrare nel merito di ciò che ne scaturì, se non per dire che, dopo due millenni e mezzo, ancora ci interpella. E, come si è detto, getta una luce significativa su quel che in Occidente si è inteso con filosofia.
Teniamo presente che quest’ultima fiorì all’incirca nella stessa epoca, nella parte occidentale di tutta quella koiné di popoli che parlavano lingue indoeuropee. E che, di quel che originariamente fu, dovremo un giorno ammettere di saper ben poco. Le ricostruzioni che ne abbiamo sono infatti successive, o quanto meno risalgono a quella grande sistemazione del sapere antico che è la filosofia di Aristotele. Nella quale culmina l’aspirazione, destinata a plasmare l’Occidente, a spiegare in modo chiaro e ragionevole ogni cosa. Tutto il contrario dell’India, o almeno di quel suo nucleo profondo che si manifestò in quella notte di luna piena. In Occidente infatti tra il pensiero e l’Essere si volle vedere piena corrispondenza; le parole penetrano la realtà, la ordinano e la strutturano.
Tornando invece all’India, e a quella comprensione forse non così diversa da quella che ebbe Severino, bisogna tuttavia osservare che ben diversa è la comunicazione che ne è scaturita.
Si è assolutamente evitato di parlare di eternità, concentrando addirittura l’attenzione sul suo opposto. Date certe condizioni, ogni cosa ha un inizio; date altre, una fine. Tutto è impermanente.
Parrebbe, come da molti malamente inteso, il trionfo del nichilismo. Ma la mente umana è più complessa di quanto la ragione riesca a concepire. Soprattutto, funziona a più livelli.
Se mi concentro sull’impermanenza, vedendo chiaramente che nulla mai consiste, che le cose e io stesso che le penso siamo presi in un vortice di mutamento, la mia attenzione sarà sull’attimo presente che di continuo sfugge, ma pur tuttavia è l’unica realtà che sia davvero data. E in questo modo, proprio in quanto più che mai immerso nel fluire del tempo, paradossalmente ne sono fuori.
Non posso spiegarlo più di tanto, ma mi è dato quel che è più importante: l’esperienza. Per ragioni che rimarranno misteriose, quell’attimo che continuamente sfugge è la porta che apre sull’eternità.
[1] Ci sono studi, ancora poco conosciuti, che cambiano completamente la prospettiva entro cui leggere le origini della filosofia. Si veda in particolare: Giovanni Ferrero, La via della demone. Per lo studio sulla genesi e la struttura del poema di Parmenide, in Livia Giacardi e Silvia Clara Roero, La matematica delle civiltà arcaiche, Stampatori, Torino 1979
[2] Raimon Panikkar, Emanuele Severino, Parliamo della stessa realtà? Per un dialogo tra Oriente e Occidente, Jaca Book, Milano 2014
[3] Raimon Panikkar, Emanuele Severino, op. cit., p. 36
[4] “… poiché lo stesso è pensare ed essere”, cit. in Plotino, Enn. V, I, 8, in I presocratici, Einaudi, Torino 1976, p. 229
[5] Raimon Panikkar, Il silenzio del Buddha, Mondadori, Milano 2006
[6] Raimon Panikkar, La porta stretta della conoscenza, Rizzoli, Milano 2005, pp. 211-212
[7] Genesi, 3, 19