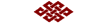Venticinque anni fa, tra le rovine del muro di Berlino, veniva meno dalla scena storica un’ideologia che aveva mosso milioni di persone e condizionato le vicende di due secoli. Il silenzio della riflessione in cui l’anniversario trascorre mostra però la difficoltà a stabilire un giudizio, e le conseguenze potrebbero essere insidiose. Quel che non è stato elaborato è destinato infatti a ripresentarsi, sia pure in forme altre da quelle conosciute.
Venticinque anni fa, tra le rovine del muro di Berlino, veniva meno dalla scena storica un’ideologia che aveva mosso milioni di persone e condizionato le vicende di due secoli. Il silenzio della riflessione in cui l’anniversario trascorre mostra però la difficoltà a stabilire un giudizio, e le conseguenze potrebbero essere insidiose. Quel che non è stato elaborato è destinato infatti a ripresentarsi, sia pure in forme altre da quelle conosciute.
Quel che segue intende essere un contributo, a partire da un’esperienza personale meditata e sofferta. Sono stato comunista in gioventù, condividendo i sentimenti di una parte significativa della mia generazione. Ho poi trascorso il resto della vita cercando le radici di quel che sempre più mi appariva un tragico errore. Quel che dunque dirò, quand’anche non venga condiviso, è la testimonianza di un percorso.
Vorrei muovere da una considerazione che per qualcuno potrà essere scabrosa, ma su cui bisognerà pur trovare il coraggio di parlare.
In un confronto, sempre imbarazzante, tra i costi umani che i diversi tipi di totalitarismo hanno imposto, quello comunista non può essere considerato da meno del suo rivale storico, cioè i fascismi. Tenendo conto della sua maggior durata e dell’enorme consistenza demografica delle aree coinvolte, si dovrebbe anzi dire che le devastazioni prodotte siano di gran lunga le più estese e le più profonde.
Coloro che ne sono stati direttamente segnati non hanno per lo più avuto dubbi in merito, fornendo immagini di un’atroce follia. Così Solzenicyn in Arcipelago Gulag:
L’ideologia! È lei che offre la giustificazione al male che cerchiamo e la duratura fermezza occorrente al malvagio. (…) Grazie all’ideologia è toccato al secolo XX sperimentare una malvagità esercitata su milioni. (…)
Negli anni ’18 e ’20 si sparse la voce che la Ceka [la polizia segreta] di Odessa e di Petrograd non fucilava tutti i suoi condannati ma ne dava alcuni (vivi) in pasto alle belve del giardino zoologico. Non so se sia verità o calunnia, se simili casi siano avvenuti e quanti. Ma nemmeno mi metterei a cercare prove: secondo le usanze delle mostrine celesti [gli organi giudiziari] proporrei loro di dimostrare che la cosa è impossibile. Dove procurare il cibo per un giardino zoologico in quegli anni di carestia? Strapparlo di bocca alla classe lavoratrice? Quei nemici dovevano morire comunque, perché non sostenere con la loro morte l’allevamento delle belve della Repubblica e favorire con ciò un nostro passo verso il futuro? Non è forse conforme al fine?
Ecco il limite che un malvagio shakespeariano non varcherebbe, ma un malvagio armato di ideologia lo varca, e i suoi occhi rimangono sereni.[1]
Nonostante ciò, per chi ha potuto consentirsi di vedere le cose dall’esterno, partecipando quindi delle attese che una certa atmosfera politica aveva suscitato ma senza doversi direttamente confrontare coi suoi esiti, riesce difficile prendere davvero atto di quel che viene testimoniato. Non che si dubiti che si possa esser giunti a tanto; ma quel che emerge è un problema che in psicologia è noto come dissonanza cognitiva. Entrano cioè in contrasto due percezioni. Da un lato il concetto di comunismo si è costretti ad associarlo a gravi efferatezze e comunque a stati di oppressione; dall’altro si continua a collegarlo a premesse di valore positivo. Un’osservazione ricorrente è infatti: peccato, perché i principi sarebbero stati buoni! Molto diverso, sotto questo aspetto, è il discorso che generalmente viene formulato sui fascismi, soprattutto sul nazismo. In questo caso la negatività caratterizza già i principi, quindi il giudizio è indiscutibile, perché tra le premesse e gli esiti sembra esserci perfetta coerenza.
Basterebbe in realtà ben poco per capire quanto ciò sia insufficiente.
Può senz’altro avvenire che gli esiti di un fenomeno siano in contrasto con le sue premesse. In qualche misura ciò accade sempre quando si confronti una realizzazione storico-politica col sistema sovraordinato dei valori. La realtà dei fatti contraddice almeno sotto qualche aspetto i principi da cui si dichiara ispirata. La consapevolezza di ciò è ben presente nelle culture religiose. Nella visione cristiana, come testimoniato nella filosofia della storia di Sant’Agostino, solo alla fine dei tempi il bene e il male saranno nettamente separati: nel frattempo è inevitabile la loro mescolanza. Nella visione hindū, come appare nella Bhagavad Gita, viene dato per scontato che chi detiene il potere non possa seguire l’obbligo della nonviolenza. Laddove in generale l’esistenza umana si svolge nel quadro di un orizzonte trascendente, si dà per scontata una costante inadeguatezza rispetto a ciò che quell’orizzonte prescrive.
Nel caso del comunismo le cose sono però diverse, per almeno due ragioni.
La prima, meno importante ma comunque imprescindibile, è di carattere empirico. Risulta difficile accettare che i risultati siano sempre e totalmente in disaccordo con le attese. Se una volta almeno così non fosse, se un caso fosse riscontrabile in cui si sia data una certa corrispondenza, sarebbe credibile supporre che elementi estranei abbiano deviato il procedere delle cose, determinando una corruzione del processo stesso non imputabile alla sua natura. Il fatto che ciò non si verifichi getta una luce d’incertezza su quel che viene dato per scontato. Siamo davvero sicuri che le premesse siano quelle che riteniamo di conoscere?
La seconda ragione è di carattere filosofico: si tratta di un problema intrinseco alla filosofia di Marx. È tipica di essa, anche in quanto erede della filosofia di Hegel, la critica di ogni trascendenza, e quindi di ogni distinzione tra essere e dover essere. Vi è una razionalità negli eventi umani che gli eventi stessi compiutamente manifestano. Per questo Marx qualificò come scientifico il proprio pensiero, rifiutando in ogni modo di considerarlo utopico. L’edificazione di una società comunista sarebbe scaturita dalle leggi oggettive della storia, non certo dalle aspirazioni e dai sogni umani. Ma ciò che, nel quadro del positivismo ottocentesco, pareva fondare irresistibilmente la forza di un progetto politico, in realtà insinuava in esso una profonda debolezza. In una visione in cui, abolita ogni trascendenza, la storia esibisce una razionalità immanente, il fallimento storico è senza possibilità d’appello. Non c’è un oltre a cui affidare le aspirazioni che non si sono realizzate.
Per capire come mai di questo fallimento non si sia preso atto, bisogna però riflettere su come il marxismo novecentesco abbia per tempo cercato di resuscitare la trascendenza, riabilitando il senso utopico del comunismo. Si veda soprattutto la filosofia di Ernst Bloch, la quale, collocando la trascendenza nella dimensione orizzontale del futuro anziché in quella verticale del rapporto col divino, creava un meccanismo autogiustificativo analogo a quello di cui Marx aveva accusato la religione. Il che comportava due conseguenze, che corrispondono anche a due diversi percorsi.
La prima è che, in quanto il senso delle cose non andava più cercato in una realizzazione storica ma in un non-ancora, insomma nelle aspirazioni rimaste insoddisfatte, il marxismo compiva una metamorfosi che ambiguamente lo riaccostava alla religione. Il principio speranza non vi si contrapponeva più, ma la reinterpretava, con addirittura la pretesa di mostrarne il senso autentico. Mentre dunque in precedenza la religione era stata combattuta come strumento di oppressione, ora vi si poteva vedere un mezzo di liberazione. Non è del resto, tanto più nei monoteismi, centrale il tema della giustizia, a cominciare dalla protezione accordata ai più deboli?
Di qui il tomentoso problema costituito per la Chiesa dalle teologie della liberazione: da un lato era indubbio che cogliessero il cristianesimo in un suo nucleo profondo, l’opzione per i poveri, dall’altro il suo senso veniva snaturato. Una religiosità tutta risolta nell’emancipazione sociale appariva conferire un senso forte all’esperienza spirituale, attualizzandola nel contesto della civiltà moderna, ma finiva anche per svuotarla. Rischiava di essere una forma sottile di secolarizzazione.
La seconda conseguenza è che lo sganciamento del marxismo dall’oggettività storica, come inesorabilmente si mostrava realizzata nei sistemi del socialismo reale, otteneva di porlo preventivamente al riparo dal loro fallimento, lasciando aperta la possibilità di nuovi esiti. Il prezzo era però la rinuncia a tutto ciò che l’aveva storicamente contraddistinto, la sua riduzione a un nucleo quasi impossibile da afferrare e tuttavia tenacemente persistente.
Venuti meno la lotta di classe e il riferimento alla giustizia sociale, una seconda metamorfosi generava infatti sia un diffuso disadattamento sociale, dopo il Sessantotto diventato endemico, sia un’élite disincantata e disincarnata dedita a gestire il cambiamento in quanto tale, come richiesto da una modernizzazione sempre più incalzante, dalla nuova rivoluzione mediatica e dalla finanziarizzazione dell’economia. Si capisce in questa luce come generazioni in vario modo corresponsabili di eventi anche tragici abbiano potuto lasciarseli alle spalle senza elaborazione alcuna, ritenendosene autorizzate dall’azzeramento della propria identità ideologica. O meglio l’ideologia, spogliatasi dei caratteri occasionalmente rivestiti, si mostrava nella sua pura essenza: mezzo inesauribilmente proteiforme di produzione del consenso in una società di massa.
In entrambi i percorsi ora indicati appare chiaro che la difficoltà a fare i conti con il comunismo deriva dal fatto che la sua vicenda è tutt’altro che conclusa.
Un approfondimento dei caratteri dell’ideologia moderna potrebbe spiegare cosa vi sia di vero quando si dice con rammarico che i principi del comunismo sarebbero buoni.
Per un complesso di ragioni su cui non ci si può dilungare, la moderna civiltà occidentale ha attribuito un valore fondante al principio di uguaglianza. Mentre la vecchia società per ceti presupponeva la disuguaglianza dei soggetti, che si trovavano collocati ai diversi livelli della piramide sociale, a un certo punto tutto ciò è stato radicalmente rifiutato.
Le radici di quel rifiuto sono variamente interpretabili. Si ritiene comunemente che il cristianesimo, affermando la pari dignità degli uomini in quanto figli in Cristo dell’unico Padre, abbia contribuito a porre le premesse della nuova visione. Ma forse una memoria ancor più antica, risalente ai piccoli sistemi prestatali, ha tormentato nei secoli le grandi società tradizionali, generando in esse un oscuro disagio di cui talvolta le religioni si sono fatte interpreti. È comunque certo che il successo dei mercanti, già nella Grecia antica ma soprattutto nella moderna Europa, abbia generato una situazione che richiedeva l’abbattimento delle barriere tra gli uomini.
In ogni caso il nuovo principio è venuto affermandosi con altrettanta forza di quella che aveva sorretto il vecchio, sostituendosi a esso nella coscienza collettiva. Soprattutto perché una società secolarizzata, dove è abolita la fondamentale differenza rispetto al trascendente, che consente di accogliere ogni altra differenza che inevitabilmente la vita propone, induce l’ossessione della parità come sigillo della dignità umana. Non si capisce l’orgoglio con cui in ogni rivoluzione ci si dichiara reciprocamente uguali, senza quell’ossessione. Neppure la furia distruttiva contro coloro e tutto ciò che rappresentano il persistere di una qualche significativa differenza.
Sradicata dunque dalle menti degli uomini l’idea della differenza, non si poteva che essere acutamente sensibili a tutto ciò che di fatto limitava l’uguaglianza. Ciò è accaduto innanzitutto per le barriere di ordine economico, le sole che parevano sopravvivere al crollo della società per ceti.
Sotto questo aspetto la filosofia di Marx e il comunismo reinterpretavano il tema della giustizia, presente in tutte le culture religiose, secondo una chiave del tutto nuova. La premessa non era la comune appartenenza degli uomini a un ordinamento cosmico garantito dalla religione stessa, bensì il principio di uguaglianza come universalmente affermato dall’illuminismo. Marx si rende conto dell’astrattezza di quel principio, incapace di abbracciare la concretezza dei rapporti sociali; ma, avendo a sua volta ridotto quei rapporti al piano utilitaristico, si illude che da esso possa venire la soluzione del problema. In realtà non fa che raddoppiare l’astrazione illuministica: venuta meno la disuguaglianza di principio, bisogna abolirla nei fatti, quindi anche nella sfera economica. L’illusione che ciò scaturisca dalla carne e dal sangue della storia ha solo giustificato i tormenti che sarebbero stati inflitti.
Per questo le premesse del comunismo appaiono buone: perché non sono altro che le premesse della modernità portate alle estreme conseguenze. Mentre invece le premesse dei fascismi appaiono cattive perché, riaffermando in vario modo la disuguaglianza tra gli uomini, sembrano contraddire le idee guida della modernità. Soprattutto il nazismo, con la teoria della razza, mostruosamente contravviene ai valori condivisi. Dunque la sua sconfitta, prima di maturare sul piano degli eventi, scaturisce da un rifiuto che è della coscienza.
In realtà il problema è più complesso. I fascismi, quello italiano in primo luogo, sono una reazione al principio egualitario che non mette in discussione il terreno sul quale il problema è posto: cioè quello della secolarizzazione. Ne deriva un’ideologia contrapposta a quella comunista, che nel caso del nazismo si spinge, pur di sradicare l’egualitarismo, a elaborare una visione alternativa della civiltà occidentale, da cui sia divelta la radice biblica.
In effetti il nazismo ha consapevolmente perseguito, nel contesto della moderna società industriale, un’organizzazione schiavistica analoga a quella di Roma antica, che presupponeva, più ancora che la disuguaglianza tra gli uomini, la radicale differenza tra uomini e non-uomini. Si può dire che in Russia e in Cina si sia fatto altrettanto, ma senza prenderne coscienza, ritenendo anzi di estirpare, dal cuore e dalla carne degli uomini, ogni residuo di disuguaglianza. Con la conseguenza che la prima cosa è risultata imperdonabile, mentre la seconda era tanto inconcepibile da venire rimossa.
Per quanto detto è senz’altro vero che quella del comunismo non è una vicenda conclusa. Non lo è perché sono più che mai attive le premesse da cui è sorto. Il fantasma che a metà dell’Ottocento si aggirava per l’Europa è tutt’altro che placato e in altre vesti bussa ancora e forse più che mai alle nostre porte.
Se volessimo seguire le tracce delle due metamorfosi che abbiamo prima indicato, da una parte troveremmo che quel riavvicinamento del marxismo alla religione fino a identificarsi in essa, trasformandola in movimento di liberazione, si è davvero realizzato; sebbene non nella teologia della liberazione cristiana ma nel fondamentalismo islamico.
Due testimonianze sono particolarmente significative. La prima è la conversione alla religione islamica di Roger Garaudy, figura simbolo del marxismo francese. La seconda è la lettera inviata, all’inizio di quello stesso 1989 in cui sarebbe caduto il muro di Berlino, dall’Ayatollah Khomeini a Gorbaciov.
In quella lettera si riconosceva a Gorbaciov “il coraggio che ha posto nella revisione di una ideologia che ha vincolato per anni la gioventù rivoluzionaria del mondo in un busto di ferro”[2]. Tale revisione per essere efficace dovrebbe però evitare la tentazione di guardare all’Occidente, e andare al nucleo profondo di una crisi che riguarda tanto il marxismo quanto il mondo occidentale.
… faccio appello sinceramente a lei perché non resti intrappolato nella prigione dell’Occidente e del Grande Satana dal momento che spezza il sipario d’acciaio dell’ideologia marxista.[3]
La diagnosi è tale da far chiaramente cogliere il senso di un passaggio storico.
Il maggior problema del suo Paese non ha le sue cause nella proprietà privata, nell’economia o nella libertà. In realtà il suo problema nasce dalla mancanza di una profonda credenza nella Divinità, come dire, lo stesso problema che ha trascinato l’Occidente alla decadenza e alla senescenza. Il suo principale problema consiste nella tenace e vana lotta con Dio, che è la causa prima dell’Essere e della Creazione.
Eccellenza: è ben chiaro a tutti che a partire da oggi bisognerebbe porre il comunismo nel museo della storia politica mondiale, perché il marxismo non può dare risposta alle esigenze reali degli uomini. È una filosofia materialista, ma a forza di materialismo non è possibile salvare l’umanità dalla crisi che nasce dalla mancanza di valori spirituali, che a sua volta costituisce l’angoscia più acuta e lacerante di cui soffrono le società tanto dell’Oriente che dell’Occidente. [4]
Possiamo avere dubbi sul fatto che in questi decenni il radicalismo islamico abbia assunto il ruolo che era proprio dei movimenti rivoluzionari, ponendosi come guida delle masse del mondo povero nella lotta contro i poteri dominanti a livello mondiale? E che l’ideologia si sia ampliata fino a includere la religione, ma che in questo modo la religione sia stata attualizzata e insieme snaturata, perché ridotta a ideologia?
D’altra parte, e veniamo alla seconda metamorfosi, cosa è accaduto in Occidente quando la competizione con l’Unione Sovietica è venuta meno?
Le élite intellettuali, che nel marxismo avevano per lo più trovato la loro identità, cessarono di essere considerate un pericolo e vennero rapidamente integrate in un sistema sociale in rapida trasformazione, che richiedeva nuove forme di produzione del consenso. In luogo della lotta di classe, dovettero però cercare nuove forme di espressione della loro vocazione profonda.
Pensiamo a un’élite che ha una storia e uno status suoi propri, nonché un ruolo sociale che, a partire dall’illuminismo, ha preso il posto di quello rivestito a suo tempo dai religiosi. Con la differenza che, mentre questi ultimi si ponevano come custodi di ciò che era socialmente considerato fondante, cioè il rapporto con la trascendenza, i moderni intellettuali si fanno per lo più custodi della sua negazione, prolungandone gli effetti sul piano sociale, cioè dando vita allo spirito della rivoluzione. Il che ha determinato una situazione complessa, per cui il loro ruolo, di guida delle coscienze, si esercita attraverso la conflittualità coi poteri costituiti. Soprattutto il marxismo ne è stata l’incarnazione: i movimenti comunisti sorgono infatti dal conflitto tra élite culturali ed élite economiche, che ha determinato per due secoli l’instabile equilibrio della società occidentale.
Ma ora che la caduta del muro di Berlino poneva fine a tutto ciò, la spinta rivoluzionaria doveva cambiare direzione.
Si può pensare che un evento così complesso come il Sessantotto sia lo spartiacque che separa la rivoluzione economica, di cui si è ormai esaurita la carica propulsiva, da un’incipiente e subito dilagante rivoluzione culturale.
Venuta meno la fiducia che un cambiamento nella struttura economica possa determinare un cambiamento nell’intima disposizione dell’uomo, quest’ultimo torna a essere il diretto soggetto del cambiamento. Il che potrebbe ricongiungere alle matrici religiose, riportando il cambiamento alla conversione del cuore; senonché una nuova irresistibile stagione si apre per l’ideologia col connubio del marxismo e di quell’altra sorgente ispiratrice della mentalità moderna che è la psicanalisi freudiana. Quel che ne scaturisce è un sovvertimento non più dell’ordine sociale, ma della scena personale intima, rappresentata come luogo del conflitto tra la forza inesauribile del desiderio e le strategie di potere che plasmano le strutture psichiche e culturali.
Una simile decostruzione dell’identità non è in realtà priva di contesto né di funzione sociale, se si pensa quanto il consumismo si nutra di masse di soggetti sregolati e desideranti. Ma, essendo che la stessa critica sociale è coinvolta nel sospetto che investe ogni ordinamento culturale, nulla pare più frapporsi a una ricerca di appagamento che ha nella sessualità, anziché nella storia, il suo modello e il suo luogo decisivo. Anzi, la sessualità stessa diventa il terreno su cui si svolge un estremo assalto al baluardo più intimo e profondo della differenza: quella tra uomo e donna. Non si capisce il senso di quel che sta avvenendo nei paesi occidentali, apparentemente privo di significativi riscontri sul piano sociale, se si prescinde dalla portata simbolica della posta in gioco.
Merita di essere osservato che, su entrambi i versanti lungo i quali lo spirito della rivoluzione si è diviso, quello del fondamentalismo islamico e quello della rivoluzione culturale, a farne le spese è l’esperienza religiosa, sottoposta a pressioni destinate a sfociare nella persecuzione aperta.
Nel primo caso, per quanto paradossale appaia, la cosa risponde a una logica ben precisa. La religione ridotta a ideologia rivoluzionaria non può che scatenare la violenza contro la religione stessa, con la stessa foga distruttiva che muoveva a suo tempo i regimi comunisti. Si può pensare infatti che l’ideologia sia antireligiosa in quanto tale, a prescindere dal suo contenuto. Il fatto che quest’ultimo sia desunto dalla religione aggiunge potenza inusitata all’ideologia, ponendola al riparo da ogni fallimento, ma non tutela la religione più di quanto lo abbia fatto l’ateismo di Stato. L’esperienza religiosa in senso proprio infatti, per quanto possa pervadere e dirigere la vita sociale, non ha in essa il suo scopo ed è da essa pericolosamente autonoma.
Nel secondo caso, nella rivoluzione culturale che oggi investe l’Occidente, è inevitabile che la religione sia il nemico dichiarato. Non solo perché non possono più esserlo i poteri economici, coi quali anzi sussiste una ferrea alleanza, ma perché quello di cui la religione è accusata, il controllo dell’intimità, è ciò che inconsapevolmente si persegue.
Un’antireligione irresistibilmente attratta dallo sradicamento dell’umano, anche attraverso la profanazione dei suoi simboli profondi, è l’atmosfera in cui oggi è dato vivere, nonché il fantasma che si aggira per l’Occidente.