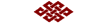A un anno di distanza, non si può certo dire che la pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco sia passata inosservata, come del resto nulla di ciò che lo riguarda. Circa però quello che il testo effettivamente dice, dopo tanto parlare che si è fatto, resta tuttavia l’impressione che il suo nucleo profondo ben poco sia stato toccato.
A un anno di distanza, non si può certo dire che la pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco sia passata inosservata, come del resto nulla di ciò che lo riguarda. Circa però quello che il testo effettivamente dice, dopo tanto parlare che si è fatto, resta tuttavia l’impressione che il suo nucleo profondo ben poco sia stato toccato.
Non potendosi però pensare a una banale difficoltà di comprensione, perché anzi raramente un testo di quel tipo ha parlato più direttamente e con semplicità al cuore e all’intelligenza del lettore, venendo anche incontro a enormi aspettative, è il caso di riflettere su una difficoltà di altro genere: quella di collocarlo in un quadro interpretativo adeguato, che consenta di mettersi in rapporto non solo con singoli aspetti di quel che viene detto, ma col suo senso essenziale. Il che potrebbe a sua volta essere interpretato in due modi.
Da un lato ciò sicuramente mostra una tipica distorsione del circuito mediatico in cui siamo immersi e dell’atteggiamento culturale da cui esso dipende e che a sua volta induce: anziché aprirsi alla comprensione di quel che il testo davvero comunica, ci si è preoccupati di come possa o debba venire inteso, sulla base di categorie abbastanza limitate. Ad esempio: è lecito che il Papa prenda posizione in modo così preciso sul riscaldamento globale? Oppure: l’avrà fatto a sufficienza?
Sotto questo aspetto, chi abbia voluto commentare l’enciclica senza un autentico sforzo di comprensione, ha facilmente trovato riscontri a certe attese, potendo riscontrare che talune affermazioni sono in accordo o in contrasto con posizioni o interessi di questo o quel soggetto; ma senza poter fugare l’impressione che quel che è stato colto non sia che il frammento di un disegno che nel complesso sfugge.
Si potrebbe ancora dire che questo è il disagio tipico di chi si confronta con un testo di carattere spirituale, irriducibile al piano giornalistico in quanto solo parzialmente si lascia interpretare dalle categorie correnti. Ma in questo modo susciteremmo un problema più grande ancora, dal momento che, nella cultura occidentale, da molto tempo il linguaggio religioso viene ridefinito da un altro linguaggio culturalmente dominante, che pretende di spiegarne il senso meglio di quanto esso stesso non sappia fare.
In realtà, su un piano più profondo, l’impaccio che pare aver colto di fronte a questo testo, per nulla criptico e tanto meno reticente, è forse un fatto nuovo.
Potrebbe paradossalmente essere il segnale più eloquente di un mutamento culturale in atto, di cui il testo è parte.
Può darsi che la stessa figura di Papa Francesco, con l’immensa attrazione che esercita e il disorientamento che al tempo stesso suscita, personifichi tale mutamento.
In quel che segue si tornerà a leggere l’enciclica in tale prospettiva: cioè pensando a un testo che, nella sua semplicità talora disarmante, fa emergere un orizzonte realmente nuovo. Ciascuna affermazione di per sé è infatti perfettamente comprensibile al lettore, ma il senso generale potrebbe non esserlo: o quanto meno il lettore è chiamato a non cercare conferme in quel che già conosce, ma a procedere fiduciosamente su un terreno nuovo.
Naturalmente la possibilità di proporre una lettura di tal genere presuppone una particolare affinità o empatia con il testo e col cambiamento con cui è in relazione. Presuppone di aver compiuto un lungo percorso in quella direzione, e di avere un contesto di esperienze, cognizioni e vissuti entro cui accoglierlo, riconoscerlo e riscoprirlo, con stupore più grande ancora.
Introduzione
Interpretare un testo vuol dire cercare, a costo di scomporne l’impianto formale, le chiavi di lettura che consentono di mettere in rapporto quel che è detto con quel che non lo è, ma è presupposto o sottinteso o suggerito; che si deve desumere dal contesto in cui è lecito collocarlo.
Va da sé che, in un testo di una certa complessità, si possono dischiudere diversi livelli di comprensione.
Nela Laudato si’ una prima chiave è quella offerta subito.
La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi.[1]
Ci sono valide ragioni per pensare che si tratti della tesi teologica fondamentale. Può anche essere considerata ovvia, ma non lo è affatto e tanto meno le sue implicazioni. Il suo valore andrà in realtà scoperto.
La seconda chiave è un motivo di continuo ricorrente. Nella formulazione forse più completa e significativa, suona così:
Tutto è connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola…[2]
Il linguaggio è diverso, ma si intuisce che il contenuto è analogo. Ci si potrebbe chiedere in quale rapporto i due linguaggi siano. Il primo è un modo immaginifico di dire quello che il secondo dice con precisione? Oppure il secondo è una semplice traduzione del primo, che si rende necessaria in un contesto in cui il primo potrebbe non essere accettato?
Una terza chiave di lettura, che facilmente può passare inosservata, è contenuta in una sintetica, duplice affermazione che si trova incastonata a un certo punto del testo.
Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli. Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità.[3]
Soffermiamoci con particolare attenzione.
La seconda proposizione definisce il Cristianesimo come una “perenne novità”, in quanto, “mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche”. Questo ripensarsi e riesprimersi non è solo dovuto alla necessità di adeguarsi ai linguaggi delle diverse epoche; bensì consente che venga alla luce, ovvero sbocci, il suo essere più proprio: cioè per l’appunto la perenne novità.
Si tratta di un’affermazione molto forte, che, pur essendo fedele a quel che possiamo intendere come senso profondo dell’annuncio cristiano - in quanto buona novella -, non è affatto scontato nella comune percezione.
La prima proposizione definisce invece l’orizzonte entro cui collocare il ripensamento del Cristianesimo nel nostro tempo: “si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli”. Siccome gli ultimi secoli sono necessariamente quelli che hanno visto l’ascesa del mondo moderno, si vuole segnalare la necessità di una svolta nei suoi confronti. E poiché ciò che lo caratterizza sono “false dialettiche”, cioè opposizioni che evidentemente hanno distolto da una corretta comprensione della realtà, occorre una “nuova sintesi” che la ristabilisca.
Tale sintesi è oggetto di attesa, quindi non si può dire quale forma esattamente la perenne novità cristiana sia destinata ad assumere; tuttavia il fatto stesso di porre la questione segnala una precomprensione dei suoi tratti, e l’intento di contribuire a farli emergere. In particolare è lecito supporre che la nuova sintesi, comportando il superamento di false dialettiche, consista in una più integrata visione della realtà, in cui i vari aspetti coesistano organicamente. Il fatto che l’oggetto dell’enciclica sia l’ambiente induce poi facilmente a intendere che l’opposizione tra uomo e natura sia parte di un modello di pensiero dicotomico, che andrebbe superato: e se ne troverà nel testo ampia conferma. Ma neppure ciò può esaurientemente dire in cosa la nuova sintesi consista.
Suggerisco che, su un piano più profondo, si debba ancora attendere il suo manifestarsi non solo per un fatto banalmente temporale, cioè che è ancora prematuro parlarne, ma per una necessità più intrinseca: perché la novità in quanto tale esclude un possesso intellettivo. Forse l’espressione “novità perenne” vuol dire più di quanto non paia a prima vista. Forse indica una condizione dell’Essere a cui si è chiamati ad aprirsi.
In tale prospettiva, quel che cercherò di fare è proporre una lettura di quanto a mio avviso il testo contiene, in quanto apertura a quella nuova sintesi di cui si avverte il bisogno.
Data la varietà dei temi che esso tratta, mi soffermerò solo su alcuni: quelli che più caratterizzano la sua struttura filosofico-teologica. Trascurerò invece altri, sebbene siano quelli che più hanno attratto l’attenzione: lo sviluppo sostenibile, il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, la questione dell’acqua, gli organismi geneticamente modificati, la sperimentazione su animali e via dicendo. Non perché non siano importanti, ed è anzi significativo che in un testo del magistero ecclesiastico si sia scelto di trattarli; ma perché il senso di ciò rimarrebbe oscuro se non fossero chiarite le linee portanti del testo stesso. Le quali a mio giudizio riguardano quattro questioni fondamentali.
La prima è il ripensamento del Cristianesimo nel senso in cui si diceva: cioè in connessione con quel dialogo col nostro tempo che ne fa emergere la perenne novità. Soprattutto si porrà il problema del Cristianesimo in un orizzonte interculturale e interreligioso, perché questo è ciò da cui il nostro tempo è più visibilmente segnato sul piano spirituale. Di conseguenza proporrò dell’enciclica una lettura interculturale.
La seconda è il confronto con la Modernità e le sue false dialettiche. Ne emergerà una filosofia e una teologia della storia che almeno implicitamente sta orientando il pontificato di Francesco.
La terza è il rinnovamento della Chiesa a partire da quel ripensamento e da quel confronto.
Infine la quarta questione è ciò che si può dire della sintesi emergente; il che circolarmente contribuisce a ridefinire la prima, e di conseguenza anche le altre. Usando la parola che con maggiore proprietà può qualificarla, si parlerà dell’interdipendenza.
Suggerirò una metafora: di pensarli come i quattro pilastri in rapporto a cui Papa Francesco, come il poverello di Assisi di cui ha preso il nome, sta ponendo mano a restaurare la Chiesa.
Ciascuno di essi ha una sua specificità, ovvero comporta problemi suoi propri, ma è interdipendente con gli altri, poiché è la loro connessione che sorregge la complessa architettura dell’insieme.
Un’architettura in cui facilmente si può vedere rappresentata la situazione dell’umanità odierna
Sono in molti a pensare che Francesco si sia trovato alla guida della barca di Pietro in una condizione forse senza paragoni nella storia della Chiesa, se non forse con il tempo delle origini.
Per ragioni non facili da dirsi, se non evocando scenari ultimi, è come se su di essa si abbattessero forze che mirano a distruggerla, di fronte alle quali solo la fede può dire: non praevalebunt. Sicuramente la scelta di assumere il nome di Francesco corrisponde a una precisa consapevolezza della situazione, e della necessità di affrontarla attraverso atti in cui la Chiesa sia radicalmente rinnovata. Come Francesco d’Assisi, in una condizione forse non così estrema, si diede a restaurare la Chiesa facendosi figura cristica, così il nuovo Francesco abbraccia la povertà evangelica per togliere energia alle forze ostili; e così anch’egli procede a restaurare la Chiesa. Del resto nulla potrebbe dall’esterno minacciarla se non fosse indebolita dall’interno; se il male che deve combattere non vi si fosse insinuato minandola.
Riprendendo la metafora dei pilastri, il fatto che siano quattro è indispensabile per la stabilità dell’edificio: sarebbe assurdo pensare a uno solo. Eppure cade in questo assurdo chi pretende che i problemi della Chiesa siano interamente riconducibili a uno, in particolare al suo mancato aggiornamento rispetto alla Modernità. Chi vede così le cose, da un’ottica di tipo illuministico, quand’anche non ne sia consapevole, della Chiesa vorrebbe la rovina: perché obbedire alle leggi del mondo per essa sarebbe il tradimento di se stessa. Ma non meno errato risulterebbe limitarsi a contrastarlo: in entrambi i casi tutta l’attenzione si concentrerebbe su quell’unico pilastro.
Sarebbe risolutivo puntellarlo a ogni costo, mentre magari stanno cedendo gli altri? Non sarebbe più saggio operare a rinsaldarli tutti e quattro, magari cominciando dal più pericolante?
Primo pilastro. Il Cristianesimo e le altre religioni
Stando dunque all’interno della metafora, e facendosene guidare senza perdere di vista che di metafora si tratta, suggerisco che l’idea che il problema principale della Chiesa sia il rapporto con la Modernità è viziata da etnocentrismo: cioè la costringe nei limiti della civiltà occidentale; con la quale ha certo un particolare legame, ma a cui non è lecito ridurla.
In una prospettiva più ampia, che oggi non può essere se non interculturale, ben prima del problema del rapporto con la Modernità, il Cristianesimo ha quello di definirsi rispetto alle altre espressioni della religiosità umana. Ciò in senso storico, perché si pose fin dalle origini, anche se si ripropone con grande forza ed evidenza oggi; ma soprattutto in senso logico: trattandosi di una delle grandi scaturigini di senso della vicenda umana, la coesistenza e il confronto con altre che si pongono allo stesso livello determina problemi le cui conseguenze si riversano sulla storia dei popoli.
Quando ad esempio le prime comunità cristiane decisero che l’annuncio del Vangelo, pur radicandosi nella Legge ebraica, si sarebbe esteso ai popoli che vi erano estranei, si trovarono a definire se stesse in un duplice senso: verso la tradizione ebraica come testimoni di un compimento che essa aveva rifiutato; verso gli altri popoli come portatrici di un contenuto di verità e salvezza di cui essi erano originariamente privi. Il che ha tracciato due frontiere diversamente sensibili.
Quella con gli Ebrei è stata notoriamente travagliata da vicende dolorose, sulla base di un contenzioso però facile da identificare e che oggi può essere elaborato insieme, sulla base del riconoscimento della comune appartenenza. La seconda frontiera sembra invece separare da ciò con cui nessuna comune appartenenza può essere stabilita, con quel puro disvalore che sarà espresso con la categoria di paganesimo.
Paradossalmente anche il rapporto con l’Islam, per quanto lungo i secoli e oggi di nuovo duramente conflittuale, è comunque formulabile sulla base di linguaggi quanto meno affini, mentre così non è con le culture propriamente dell’Oriente, e tanto meno con quelle dell’Africa e dei nativi delle Americhe e dell’Oceania. Di fatto tale estraneità, per lo più vissuta come superiorità, ha alimentato l’ideologia del colonialismo.
Un grave problema oggi del Cristianesimo, prima ancora di quello del rapporto con la Modernità, è dunque separarsi inequivocabilmente da quell’ideologia, che nei fatti ha contribuito a plasmare. Per questo, benché in primo piano sia nelle vicende odierne il nodo del confronto con l’Islam, più profondo è quello che rinvia all’Oriente, soprattutto hinduista e buddhista. Si tratta infatti del paganesimo sopravvissuto alla diffusione dei monoteismi, che interpella oggi la coscienza cristiana rispetto a un chiarimento di vitale importanza per tutti.
Un equivoco profondamente radicato
Potrebbe sembrare che tutto ciò abbia poco da vedere col contenuto dell’enciclica: eppure così non è.
Quando infatti la moderna cultura anticristiana divenne dominante in Occidente, proprio mentre il colonialismo era al culmine del suo sviluppo, l’incontro con le altre culture suggerì argomenti polemici contro il Cristianesimo. Soprattutto l’Oriente divenne in vario modo l’esempio di una spiritualità alternativa, tale da potersi contrapporre a quella ebraico-cristiana. Le ragioni di tale propensione sono soprattutto di due tipi.
La prima è che, seppure equivocando, è possibile pensare che in Oriente l’esperienza spirituale sia intesa come un fatto strettamente umano, senza bisogno di ricorrere alla trascendenza. Questo modo di vedere, a cui ha soprattutto contribuito una discutibile interpretazione del Buddhismo, ha portato a intendere che, accantonato il Cristianesimo, si potesse ritrovare una spiritualità dalle radici antiche, più ancora di quelle bibliche, e al tempo stesso in sintonia con la moderna civiltà della tecnica. Sarà il caso di osservare che una tale suggestione ha fortemente agito sul Nazismo, ed è diffusa oggi soprattutto dal New Age.
La seconda ragione, per cui l’Oriente è diventato un riferimento alternativo alla tradizione ebraico-cristiana, ponendosi talora in esplicita connessione con il paganesimo di ogni epoca e cultura, riguarda proprio la natura.
È un luogo comune ormai diffuso la convinzione che la svolta rappresentata nella storia delle religioni dal monoteismo abbia determinato un allontanamento dall’originaria condizione spirituale dell’umanità, conservatasi invece in Oriente, caratterizzata da un intimo radicamento nell’esperienza cosmica.
Mentre in quella condizione il divino abitava la natura, rendendo sacra ogni forma vivente, si sarebbe determinato uno spostamento dell’attenzione verso il mondo umano della storia e della società.
La natura, disincantata e degradata ad ambito profano, sarebbe così stata resa disponibile all’operare umano, ponendosi in questo modo le premesse del moderno dominio della tecnica.
È del tutto evidente l’impatto che una tale suggestione ha esercitato sull’immaginario collettivo entro cui prendeva forma la coscienza ecologica; intendendo un percorso che, quanto meno tra i ceti colti dell’Occidente, abbraccia l’intero Novecento.
La tradizione ebraico-cristiana veniva a porsi del tutto ovviamente all’origine del movimento di pensiero considerato responsabile del degrado ambientale, oltre che dell’imperialismo economico e culturale che vi è connesso. Non a caso tra coloro che sono oggi più sensibili all’ecologia si fa strada una ricerca di spiritualità che in genere si rivolge all’Oriente, al New Age e addirittura a forme di neopaganesimo, con vissuti tendenzialmente anticristiani.
L’ecologia potrebbe insomma facilmente diventare il terreno su cui la lotta culturale in atto contro il Cristianesimo riesce ad essere sottilmente più efficace.
Potrebbe realizzarsi una nemesi, un capovolgimento dei ruoli rispetto al tempo delle origini. Di fronte alla necessità, universalmente avvertita, di una coscienza intimamente in sintonia con la natura, sarebbe il Cristianesimo a diventare un assoluto disvalore.
L’importanza di chiamarsi Francesco
Può essere dunque altrettanto evidente, sotto questo aspetto, il senso dell’operazione culturale compiuta da Francesco nella sua enciclica, nonché la sua urgenza. Si tratta di mostrare il Cristianesimo in tutt’altra luce, quale è quella che risplende nel Cantico delle creature. È lecito supporre che fin dall’inizio la scelta di chiamarsi Francesco segnalasse tale proposito.
Non è neppure fuori luogo supporre che l’intero testo sottintenda un dialogo con le culture dell’Oriente, finalmente riconosciute nel loro valore intrinseco, nonché con una diffusa e variegata atmosfera spirituale che in Occidente vi si ispira.
L’idea, costantemente ripetuta, che tutto è interconnesso e interdipendente, è con tutta evidenza la ripresa di un principio ben presente in tutte le tradizioni asiatiche. Affermarlo significa gettare ponti tra grandi continenti umani, e superare incomprensioni e diffidenze lungamente sedimentate.
Significa dare seguito all’atto profetico compiuto nel 1986 da Giovanni Paolo II, quando convocò il grande incontro di preghiera interreligioso proprio ad Assisi: assumendo il nome di Francesco, l’attuale Papa non può non esservisi ricollegato.
Da allora, palesemente sotto gli occhi di tutti, il valore di verità del Cristianesimo è indissolubilmente legato a quello delle altre religioni, anziché concepito in opposizione a esse. In un certo senso la Chiesa è uscita una seconda volta dai confini del Giudaismo.
La Creazione e il peccato
Detto ciò, il punto forse teologicamente più decisivo dell’intera enciclica è per l’appunto la confutazione della visione “antiecologica” che del Cristianesimo e in genere dei monoteismi viene coltivata.
Tale visione, per come genericamente è presente nel senso comune, è legata soprattutto a due nodi teologici. Il primo è quello della Creazione; il secondo l’affidamento all’uomo della terra e degli esseri viventi, come affermato nel Genesi: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”[4].
Circa la Creazione, appare oggi verosimile che l’introduzione di tale idea sarebbe connessa, nella storia della coscienza religiosa, a una desacralizzazione della natura.
Quest’ultima è opera di Dio, ma in quanto tale non è più sacra, come invece era in una fase precedente. Il che giustifica il secondo passaggio: non essendo più sacra, è resa disponibile all’uomo. Il teocentrismo dissimula l’antropocentrismo: nell’idea di creazione è già implicito il nichilismo della tecnica.
Scrive ad esempio Umberto Galimberti, uno degli intellettuali che in forma raffinata meglio rispecchiano il senso comune dominante, in un testo di quindici anni fa significativamente intitolato Orme del sacro. Il cristianesimo e la desacralizzazione del sacro:
… la terra, separata dalla volontà di Dio che l’ha posta in essere, non ha in sé alcuna consistenza, nulla che la salvi dalla caducità, per cui è nell’idea stessa di creazione la negazione dell’autosufficienza della terra, e quindi il suo bisogno di salvezza è già iscritto nella sua origine, prima ancora di considerare ciò che accade sulla terra. Separata dall’eterno, la terra appare alla religione (ma non al mito greco), come ciò che perisce, come ciò che non può difendersi dalla rapina del nulla, per cui il nichilismo della terra è iscritto nell’atto stesso della creazione, che per questo e non per altro è ex nihilo, “dal nulla”. [5]
È questa la visione con cui Papa Francesco si confronta: una visione più sottilmente distruttiva di quella banalmente illuministica, perché ha già fatto i conti con la critica dell’Illuminismo, salvo poi riaffermarlo in mancanza di un diverso orizzonte. Una visione consapevole del nichilismo, e che pur tuttavia ne è portatrice su un piano anche più profondo.
Qual è la risposta della Laudato si’? Si trova in un capitolo intitolato Il Vangelo della Creazione.
La questione viene riformulata. Il fatto che la natura sia creata da Dio di per sé ne garantisce il valore, e in tale contesto il ruolo dell’uomo non può essere inteso se non in termini di custodia, perché la terra non appartiene a lui ma solo a Dio. Il problema è però un altro, ed è quello da cui la vicenda umana è segnata: è il problema del peccato.
L’antropocentrismo e il dominio umano sulla natura non sono conseguenza della Creazione e del mandato divino, bensì all’opposto del peccato, che distorce e perverte il piano di Dio.
I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19). [6]
Si potrebbe dire che una certa visione odierna ha parafrasato il mito biblico, creando un mito alternativo e contrapposto: in luogo del peccato c’è il distacco dalla natura e il dominio su di essa.
Diventa questa la grande svolta nella vicenda umana, che contiene le premesse degli sviluppi distruttivi oggi in atto. In tale prospettiva sembra che il racconto biblico interpreti quella svolta promuovendola, e dunque la sua funzione sia da considerarsi radicalmente negativa.
Per questo, nella metafora proposta sopra, il primo pilastro da consolidare, il cui cedimento determinerebbe il crollo più rovinoso, non è quello del rapporto con la Modernità, bensì quello che sorregge il peso delle critiche contro di essa; che sono le più devastanti, perché colpiscono il Cristianesimo rivolgendogli contro in forma rovesciata il suo stesso modello di pensiero.
Per una strana analogia con i miti gnostici, il Dio ebraico-cristiano assume il ruolo del principio malvagio.
In questa luce rivendicare le radici cristiane dell’Occidente, per quanto storicamente e spiritualmente corretto, potrebbe essere irrilevante. Non è forse lontano il tempo in cui sarà la salvezza della terra a richiedere che esse vengano estirpate.
Quello che invece Francesco dice è che il racconto biblico, correttamente inteso, è già la chiave interpretativa della condizione attuale. Ogni mito alternativo ne dipende. Si trova dunque in esso la spiegazione di quel che si è prodotto, e anche la soluzione.
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future. In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto essa contiene» (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23).[7]
È un messaggio da cui non si potrà prescindere.
Secondo pilastro. Il Cristianesimo e la Modernità
Aver posto inequivocabilmente nel peccato le radici del degrado ambientale ha conseguenze enormi per la Chiesa, ma anche per il mondo circostante, che così spesso alla Chiesa è ostile.
Per quanto già Giovanni Paolo II parlasse di conversione ecologica[8], e anche Benedetto XVI avesse considerato la difesa dell’ambiente come teologicamente rilevante, è chiaro che con Francesco la questione assume un ruolo decisivo. Citando peraltro Giovanni Paolo II, afferma che la difesa dell’ambiente è parte della professione di fede.
Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, « i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede».[9]
Ciò può indurre perplessità in una parte del mondo cattolico, che vede la Chiesa minacciata su fronti in apparenza assai diversi.
La natura è anche umana?
Non è un segreto per nessuno che le società occidentali siano da qualche tempo dilaniate da uno scontro culturale senza precedenti su ciò che vi è di più intimo nell’uomo, come la sessualità, la famiglia, il nascere e il morire; nel quale sembra decidersi il futuro della stessa condizione umana, proiettata entro scenari del tutto impensabili in passato.
L’ideologia dei diritti individuali spinta alle estreme conseguenze induce addirittura a emanciparsi dai condizionamenti di identità sessuali precostituite, facendo dipendere la natura dall’indiscriminato arbitrio dei singoli, che possono così diventare docili strumenti di un totalitarismo tecnocratico.
Di tutto ciò non sembra a prima vista che l’enciclica tenga sufficientemente conto, come troppo cauto appare a molti Francesco stesso, per quanto inequivocabili siano alcuni interventi.
Più in generale, l’immagine coltivata a livello mediatico di un Papa che finalmente rompe col passato, se da un lato viene incontro ad attese enormi di cambiamento, dall’altro suscita inquietudine e timori.
Mentre da parte della cultura che si definisce laica si auspica che Francesco sia colui che finalmente sa condurre la Chiesa a superare il confine che la separa dalla Modernità, all’interno della Chiesa alcuni temono un suo snaturamento, che avrebbe effetti catastrofici sui destini dell’umanità. A essi la centralità attribuita alla questione dell’ambiente appare un segno tutt’altro che chiaro, tale anzi da accrescere l’inquietudine.
L’ampio consenso che vi si può ottenere è forse trasferibile sugli altri temi? Quanti ecologisti sono disposti a battersi contro l’aborto o l’eutanasia? Non sono per lo più invece in sintonia col fronte avverso, tutelando la natura in ogni aspetto tranne che nell’uomo?
Questioni certo molto serie, che scuotono la Chiesa. Quella Modernità che si è affermata per lo più in ostilità a essa, con cui essa però ha voluto, soprattutto col Concilio, riconciliarsi, riconoscendone alcune aspirazioni profonde, nei suoi esiti estremi pare non lasciare spazio ad alcuna mediazione.
La Chiesa torna a essere il nemico da distruggere, sebbene in forme nuove. Essa è posta di fronte a una prova dove la posta in gioco è, ben al di là della sopravvivenza istituzionale, la sua connessione con la Salvezza.
Nei vissuti profondi dei fedeli l’abdicazione di Benedetto XVI ha rappresentato il segno di quanto forte sia tale prova. Eppure nell’elezione di Francesco, in quel momento che è apparso al balcone, tutti hanno avvertito il respiro della speranza. Forse neppure il mondo che combatte la Chiesa può davvero fino in fondo desiderare di vincere.
Bisogna allora avere la fiducia di pensare che, proprio assumendo radicalmente il tema della natura, Francesco abbia trovato il modo di sciogliere quel nodo del rapporto della Chiesa con la Modernità. Potrebbe anzi aver posto premesse entro cui esso può essere ridefinito nel modo più ampio e più profondo. Se così è, e si cercherà di mostrarlo, stando alla nostra metafora ha consolidato il secondo pilastro più di quanto ci si avveda.
Critica della volontà di potenza
Sotto un certo aspetto l’ecologia è un valore tipico del mondo laico, quello che anzi meglio di ogni altro può oggi esprimerne l’etica: la sopravvivenza della vita sulla terra rappresenta una ragione più che sufficiente per impegnare interamente la propria vita, senza richiedere alcun riferimento al piano religioso. Eppure di quel mondo rappresenta anche il segno di contraddizione, dal momento che entra in crisi il mito che più di ogni altro l’ha guidata: quello del progresso.
Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza.[10]
Si noti la sottile parodia del linguaggio dell’età dei Lumi e del Positivismo. La fiducia nel progresso è stata irrazionale: proprio ciò di cui da secoli è accusata di essere la fede religiosa. Ecco però che “una parte della società”, quella che evidentemente non si rassegna a rimanere in quella condizione, “sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza”.
Si aggiunga che la possibilità che non si dia futuro dischiude, piaccia o meno, un orizzonte di tipo metafisico; così come la riflessione sulle cause del degrado pone un problema che quasi infallibilmente rinvia a quello del peccato. Se così è, ridefinirlo apertamente come tale pone dunque la Chiesa nella condizione di mobilitare le coscienze nella stessa direzione della cultura laica, ma con più forza, richiamandosi con ben maggior coerenza alle strutture profonde che essa, voglia o meno, condivide.
Il problema infatti della Modernità è che essa presuppone un tipo di coscienza in cui il nodo del peccato è stato rimosso.
Le grandi costruzioni ideologiche sorte in sostituzione del Cristianesimo, dall’Illuminismo in poi, hanno ridefinito le sofferenze umane in rapporto a condizioni soprattutto di tipo sociale, promettendo che cambiamenti su quel piano le avrebbero eliminate. Il loro fallimento è più che evidente; ma proprio la questione ecologica mostra chiaramente l’insufficienza di quell’approccio.
Per quanto il degrado ambientale sia sicuramente in relazione con certi ordinamenti, essi a loro volta dipendono da un orientamento della civiltà che in ultima istanza non può essere valutato se non in termini morali. Il dominio sulla natura, sicuramente connesso col dominio su altri uomini, s’incarna di volta in volta in strutture sociali, ma a nessuna di esse può venire attribuita la responsabilità di un processo che sfugge interamente al loro controllo. Si può pensare retrospettivamente a quale ruolo abbia avuto il capitalismo, quale il socialismo, quale la società schiavistica antica, quale l’ordinamento indiano per caste; ma nessuna considerazione al riguardo consentirà davvero di cogliere la radice del problema, né tanto meno di prospettare una soluzione.
La filosofia che si è spinta più in là su questa strada è stata quella di Heidegger, per il quale il dominio della tecnica è in connessione con la volontà di potenza: ma cos’è quest’ultima, seppure pensata come struttura sottostante alla storia dell’Occidente, dapprima nascosta poi pienamente manifesta, se non in fondo il peccato? Cioè il sostituirsi dell’uomo a Dio?
Lasciamo per ora sullo sfondo il fatto che per Heidegger il Dio dell’antica metafisica sia già implicitamente volontà di potenza; ma cosa impedisce di vedere in controluce il racconto biblico? Non sarà che Heidegger aderì al Nazismo per non averlo voluto vedere? Perché non comprendere che l’idea ebraico-cristiana (e islamica) della Creazione costituisce il mondo naturale come ordine di realtà in cui l’uomo è inserito, che non deve essere sovvertito attraverso il dominio tecnologico?
L’antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al di sopra della realtà, perché questo essere umano «non sente più la natura né come norma valida, né come vivente rifugio. La vede senza ipotesi, obiettivamente, come spazio e materia in cui realizzare un’opera nella quale gettarsi tutto, e non importa che cosa ne risulterà». In tal modo, si sminuisce il valore intrinseco del mondo.[11]
Francesco quindi si è limitato a offrire all’uomo odierno, rispetto a ciò che indubbiamente costituisce la sua maggiore angoscia - e soprattutto all’uomo della moderna società occidentale -, la chiave di lettura che più profondamente interpreta la sua condizione: ed è la stessa del racconto biblico. Anziché essere all’origine della rovina, se correttamente inteso, quel racconto dischiude la via della salvezza. Quando Heidegger, in una nota intervista del 1966, disse: Ormai solo un Dio ci può salvare, restituiva, al di là delle sue stesse intenzioni, alla parola “salvezza” un senso che l’uomo d’oggi può ben concretamente cogliere.
Dice Francesco:
Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei momenti difficili contemplando il Dio potente che ha creato l’universo. (…) Nella Bibbia, il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l’universo…[12]
Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite.[13]
Si tratta di un passaggio che, nella sua semplicità, ha implicazioni enormi.
Se, rispetto a una questione così cruciale come il degrado ambientale, la Chiesa è in grado di interpretare la condizione dell’uomo d’oggi meglio di quanto facciano gli ecologisti, perché può collegarsi a una struttura di senso che la cultura laica moderna ha scelto di rimuovere, la quale però oggi, riproposta in questi termini, riacquista tutta la sua forza esplicativa; se tutto ciò è vero, i rapporti tra la Chiesa e il mondo moderno inevitabilmente cambiano, fino a rovesciarsi. Non è più la Chiesa bisognosa di colmare un ritardo culturale, bensì la Modernità a dover uscire da una crisi che è innanzitutto di senso.
L’ecologia integrale
Detto ciò, il resto viene di conseguenza. Innanzitutto, avendo con tale decisione assunto la questione dell’ambiente, Francesco acquista il diritto di chiedere all’ecologia di non porsi indebite limitazioni: di essere ecologia integrale[14].
La prima e fondamentale conseguenza è il recupero della dimensione sociale. La sofferenza della terra è inseparabile da quella dei poveri.
… ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati.[15]
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.[16]
L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta…[17]
… oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.[18]
Merita osservare che storicamente il grande sviluppo dei movimenti ecologisti in Occidente avvenne, a partire dagli anni ottanta del Novecento, in concomitanza col declino dei movimenti politici a carattere sociale derivanti soprattutto dal Sessantotto e prima ancora dalla tradizione marxista. Spesso vi fu un diretto travaso di militanti dagli uni agli altri, e comunque almeno in linea di principio i due aspetti rimasero uniti, come si rivide poi nei successivi movimenti no-global. Nei fatti però si separarono. I movimenti ecologisti rimasero espressione di élite culturali e sociali con una forte influenza sull’opinione pubblica ma con ben scarsi legami con i poveri del pianeta. Questi ultimi, venuto meno il richiamo del Marxismo, sarebbero stati soprattutto reclutati dai fondamentalismi religiosi. Riunificando i due aspetti, la Chiesa di Francesco si fa portatrice di una proposta globale che riconduce la crisi ecologica alla crisi etica, culturale e spirituale della Modernità, dal momento che le sue radici sono nell’antropologia che essa ha coltivato.
Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali.[19]
… non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia.[20]
La seconda conseguenza dell’ecologia integrale è che la difesa della vita sulla terra non può escludere aspetti di difesa della vita su cui invece la cultura laica è indifferente o addirittura ostile. Ad esempio le questione dell’aborto[21] e della sperimentazione sugli embrioni[22]. Francesco, citando Benedetto XVI, ricorda che “«il libro della natura è uno e indivisibile» e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti”[23]. E sottolinea la natura inscritta nella corporeità, innanzitutto nella differenza sessuale.
Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa». [24]
Terzo pilastro. Il rinnovamento della Chiesa
Il terzo pilastro riguarda la visione della Chiesa e della sua missione come può oggi essere presentata al mondo dei fedeli. Parliamo ovviamente della Chiesa Cattolica, anche se nell’enciclica è tutt’altro che assente la dimensione dell’ecumenismo. Soprattutto vi sono significativi riferimenti al mondo ortodosso.
Qui la domanda è precisa. Dato per evidente a tutti che Francesco sta sospingendo la Chiesa a un profondo rinnovamento, di cosa davvero si tratta?
Quel che è sotto gli occhi di tutti è che forse mai un capo della Chiesa ha ottenuto un consenso così grande, anche e talora soprattutto al di fuori della Chiesa. Il che però può essere variamente interpretato, e anche suscitare comprensibili apprensioni.
Rinnovamento non è progresso
La lettura più consueta, al di fuori della Chiesa ma purtroppo anche al suo interno, è che si sia aperta una nuova fase, forse decisiva, dello scontro che oppone da lungo tempo conservatori e progressisti. Si tratta di una lettura dotata di forte suggestione, ma profondamente sbagliata: per la semplice ragione che applica alle dinamiche interne alla Chiesa categorie che sono tipiche, dalla Rivoluzione Francese in poi, dell’ambito politico. Va peraltro osservato che in quello stesso ambito esse non sono più negli ultimi decenni unanimemente accettate, e proprio la nascita dei movimenti ecologisti ha contribuito a metterle in crisi.
Come si deve considerare l’ecologia? Progressista o conservatrice? È probabile che per lo più si propenda per la prima risposta, ma immediatamente appare l’incoerenza. Il valore fondamentale è infatti la conservazione dell’ambiente, mentre ciò che va messo in discussione è proprio l’ideologia del progresso. Da ciò non si sono ancora state tratte le debite conseguenze; ma oggi i tempi sarebbero maturi per un paradigma politico di tipo nuovo.
In ogni caso tali categorie sono del tutto fuorvianti nell’interpretazione della vita della Chiesa: un’indebita assunzione delle “false dialettiche degli ultimi secoli”. Bisogna invece davvero pensare che essa viva in un rapporto inscindibile tra fedeltà alle origini e, come si diceva, perenne novità. Il rapporto è inscindibile, e non solo perché l’eliminazione di uno dei due termini condurrebbe a uno sbilanciamento in una o nell’altra direzione: non è solo un problema di equilibrio. Il punto è che il rinnovamento è altra cosa dal progresso.
Il progresso di per sé è cambiamento che si lascia semplicemente alle spalle il passato, avendo la presunzione di sapere che esso non ha valore. In realtà neppure il presente lo ha, e si è immediatamente disposti a sacrificarlo in nome del futuro. Il progresso dunque è nichilista: divora implacabilmente se stesso, e gli uomini e le risorse della terra.
Il rinnovamento invece non si dà se non in rapporto all’origine. È rinnovamento dell’origine, in una condizione in cui è diventato problematico il rapporto con essa. Può essere sua riproposizione in una forma diversa da quella usuale, ma solo perché quest’ultima si è svuotata, ridotta a puro involucro. Ogni autentico rinnovamento è l’origine che torna a vivere.
Il progresso ha talvolta assunto le vesti del rinnovamento, e certo così è stato vissuto da moltitudini immense che hanno sacrificato se stesse per l’edificazione di una società futura immaginata più giusta. Quella giustizia era infatti presupposta come un bene che gli uomini originariamente conoscono, che devono quindi riportare alla luce da una condizione in cui è disconosciuta, tradita, violata. Una condizione che a un certo momento è stata pensata come alienazione: cioè estraniamento dell’uomo da se stesso. Ciò è accaduto soprattutto quando, nella visione marxista, l’ideologia del progresso si è nutrita dell’escatologia cristiana. Ma, mentre per quest’ultima il futuro del compimento dei tempi è una piena rivelazione dell’origine completamente riscattata dal peccato, altrettanto non può essere per una visione che rifiuta un fondamento spirituale della vita. Il suo futuro si mostrerà a un certo momento proiezione illusoria, e allora il passato resterà irredento e il presente desolatamente vuoto di senso.
Bisognerebbe smettere di dire che la tradizione biblica instaura il tempo lineare, abbandonando il tempo ciclico delle precedenti tradizioni: in questo modo si giustifica il progresso e si mina alle radici l’esperienza religiosa. Se il tempo fosse solo lineare, Cristo non potrebbe essere nell’Eucaristia, e il Vangelo si ridurrebbe a semplice ricordo di un passato che sempre meno si ha ragione di evocare. Il tempo della coscienza spirituale è circolare, come anche quello della natura. Aver cercato di piegare la natura a una visione lineare ha voluto dire farle violenza.
Detto ciò, si mostra d’altra parte chiaro che la fedeltà alle origini non può solo essere conservazione della forma in cui è stata trasmessa. I cosiddetti tradizionalisti dovrebbero sempre ricordare che una tradizione è tale in quanto è viva, cioè ogni giorno si è in grado di rinnovarla: altrimenti, per usare parole evangeliche, si trova in essa la lettera ma non lo Spirito. La violenta accusa che Gesù rivolse alla società ebraica del suo tempo non mirava, come noto, a sostituire la Legge, bensì a completarla[25]: cioè realizzare quanto era contenuto nelle Scritture quale senso e compimento della Legge stessa.
Gesù non è progressista, perché, annunciandosi come il Cristo, cioè il Messia che gli Ebrei attendevano, porta alla luce un contenuto profondo della sua tradizione e lo restaura nella sua persona. Addirittura si ricollega alla scena biblica primaria: alla bontà della Creazione e alla corruzione introdotta dal peccato. Egli è colui nel quale il peccato è riscattato, avendone preso i frutti su di sé, come annunciato dai profeti, ed è il nuovo Adamo nel quale la bontà della Creazione è ristabilita.
Neppure però Gesù è conservatore, perché non si limita ad avvalorare la tradizione nella forma in cui il suo tempo l’ha definita, che è il risultato di equilibri raggiunti tra le diverse forze che, come solitamente avviene, si disputano il potere. Anzi: mette la società del tempo in conflitto con se stessa, smascherando le strategie di potere sottostanti a costo di indurle, venendo alla luce, a scatenarsi distruttivamente su di lui. Ma, di fronte a tale gesto estremo, ciascuno è costretto ad assumersi apertamente le sue responsabilità, e a scegliere quale scopo davvero intende perseguire e quale prezzo è disposto a pagare. La redenzione è innanzitutto questo mettere ciascuno chiaramente di fronte a se stesso, e alla decisione per il bene o per il male.
Coloro che saranno chiamati Cristiani, da allora in poi, sono chiamati a fare altrettanto. Ciò che innanzitutto li qualifica, prima di ogni altra cosa, è la testimonianza. Per questo non possono essere conservatori. Devono sapere che le forme in cui il Cristianesimo stesso si tramanda nel loro tempo sono preziose, ma per il fatto che attraverso esse ciascuno, con una continua mediazione personale, può ricollegarsi con l’origine. Qualora tale mediazione non fosse più possibile, e quelle forme venissero percepite come ostacolo, bisognerebbe assumersi la responsabilità di cambiarle.
La Chiesa che esce da se stessa
Alla luce di tutto ciò non dovrebbe destare così seria preoccupazione il fatto che Francesco dia talora l’impressione di essere più amato che non la Chiesa. Ciò non significa necessariamente che il suo linguaggio sia troppo consono al mondo e che quest’ultimo stia cercando di strumentalizzarlo, opponendolo alla Chiesa stessa. Quand’anche questo fosse, e in qualche misura lo è, non direbbe ancora nulla sulle intenzioni di Francesco, ovvero su quello che lo guida.
Sarebbe ben più utile pensare che la Chiesa, in quanto realtà calata nel tempo e nella storia, stia davvero vivendo una profonda difficoltà. La consapevolezza che ciò sia dovuto innanzitutto, più che agli errori di cui è di continuo accusata, agli attacchi che da secoli subisce e al crescere intorno a lei di un mondo sempre più ostile, non modifica la situazione. Fatto è che in Occidente, cioè nella civiltà che la Chiesa ha contribuito a plasmare, ricavandone d’altra parte le categorie culturali attraverso cui il Cristianesimo è stato finora interpretato, essa è diventata estranea alla gran parte della popolazione. Abitudini culturali sedimentate attraverso secoli stanno da tempo e sempre più irrimediabilmente venendo meno. La caduta delle ideologie antireligiose, soprattutto del Marxismo, non ha prodotto un ritorno alla fede se non di piccole minoranze. La grande maggioranza, quando alla Chiesa non è apertamente ostile, vive come se essa non esistesse.
Ciò non significa che non sia avvertito un diffuso bisogno di spiritualità: ma facilmente prende altre direzioni. A parte le conversioni all’Islam, o la pratica buddhista e hinduista o altro, che di nuovo riguardano ristrette minoranze, merita segnalare che in Italia un quarto della popolazione crede nella reincarnazione, e ancor più tra i giovani. Questi ultimi nella stragrande maggioranza sono del tutto estranei al linguaggio, alle pratiche e all’etica della Chiesa, che considerano piuttosto tipici delle persone anziane. Si aggiunga la caduta delle vocazioni e si avrà l’immagine di una società con cui la Chiesa ha rapporti sempre più labili.
Di fatto, complici le dinamiche demografiche, il Cristianesimo è ormai in larga misura una religione non occidentale. Non solo i Cristiani degli altri continenti sono più numerosi di quelli dell’Europa e del Nordamerica, ma senz’altro più viva è la loro fede. Soprattutto le comunità perseguitate dell’Africa e dell’Asia stanno oggi producendo, nel sangue dei martiri, una nuova semina per la Chiesa del futuro. Si tratta però di mondi le cui radici culturali sono altre rispetto all’Occidente, la cui fede richiede altre categorie attraverso cui interpretarsi.
Mettendo insieme tutto ciò, si dovrebbe capire abbastanza facilmente il sentimento e le attese immediatamente sorti verso questo Papa, il primo non a caso a non venire dall’Europa, sebbene l’Argentina sia il più “europeo” tra i paesi dell’America Latina. Come se immense moltitudini gli chiedessero di parlare una lingua diversa da quella finora parlata, con cui potersi finalmente porre in comunicazione.
Il timore che invece Francesco suscita, tra coloro che presidiano la cittadella sotto assedio, è che egli possa indebolire ciò che costituisce la sua principale difesa: la Dottrina. Soprattutto temono che un appello all’amore e alla misericordia, sganciato da un riferimento rigoroso alla dottrina della Chiesa, possa esporla al pericolo, tanto più nell’ora in cui l’attacco è virulento.
Ovviamente costoro ben sanno che nel fondamento della dottrina stessa il comandamento più grande è quello dell’amore[26], e che la carità è addirittura più importante della fede e della speranza[27]. Altrettanto però conoscono come le ideologie moderne abbiano separato l’amore per gli uomini da quello verso Dio, e che il primo senza il secondo si è inaridito. Il loro timore insomma è comprensibile.
Ma Francesco sa che limitarsi alla difesa rende la sconfitta inevitabile; che bisogna rompere l’assedio attaccando a sorpresa. Vuole una Chiesa che esca da se stessa, che vada verso, usando l’espressione che gli è cara, le periferie esistenziali. Per questo rischiano di capirlo più gli altri che non i suoi: lo capisce chi in quelle periferie abita, ne conosce la desolazione, è grato a chi le visita, scopre di avere fame e sete di quel che manca.
Gesù è il medico che sta con i malati, non coi sani. E mostra che la fede dei malati può essere più grande di quella dei sani. Vuole che tutti noi ci consideriamo malati, non che abbiamo la presunzione di esser sani. E Francesco stesso si dichiara un malato, cioè un peccatore a cui Gesù ha rivolto il suo sguardo.
In quanto istituzione, la Chiesa non è diversa da qualsiasi altra: tende a essere autoreferenziale e a produrre strategie di autolegittimazione. Di conseguenza il consenso che suscita non è facilmente distinguibile dal reale bisogno a cui viene incontro. Fino a che si produce una crisi e i due aspetti si separano: il bisogno cerca soddisfazione altrove e il consenso, riconosciuto apertamente come tale, subisce un crollo.
Per questo Francesco vuole una Chiesa come ospedale da campo: cioè una struttura leggera e provvisoria, che prenda forma in risposta a un bisogno e non pretenda di sopravvivergli. L’idea che la Chiesa abbia a durare fino alla fine dei tempi non si riferisce all’assetto istituzionale, ma al compito spirituale.
La Chiesa, fondata da Gesù Cristo, durerà fino a quando la malattia del peccato non sarà del tutto guarita. Le forme organizzative e l’autocoscienza culturale che assumerà in futuro potrebbero anche divergere da quelle del presente, le quali già sono diverse dai secoli passati. A determinarle, in fondo, è il diverso modo in cui nelle varie epoche la malattia si manifesta.
Tutto ciò va detto, non perché sia scritto letteralmente nell’enciclica, ma perché è presupposto. Si ricava da quello che Francesco dice e fa, dalle reazioni che suscita, dal contesto più ampio in cui si muove e che è all’origine delle sue scelte. Si può intendere però anche da un’attenta meditazione dell’enciclica, che sappia vedere in essa quello che è peraltro evidente, cioè una lettura dei segni dei tempi.
Si può dunque senz’altro dire, in quella luce, che nella nostra epoca i frutti del peccato stiano maturando fino a minacciare apertamente la Creazione.
… oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura.[28]
Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. [29]
Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto.[30]
Resistenza al paradigma tecnocratico
Il problema fondamentale è costituito dal paradigma tecnocratico: cioè un modello di pensiero basato sull’appropriazione della realtà, il quale, avendo subordinato a sé l’economia e la politica, ha generato l’idea di una crescita illimitata come se illimitate fossero le risorse della terra.
Il problema fondamentale è … il modo in cui di fatto l’umanità ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale. In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite.[31]
Il suo correlato nella coscienza collettiva è il consumismo, che getta gli uomini nell’estrema confusione rispetto al loro bene più intimo: la libertà. Infatti essi finiscono per identificarla col consumo stesso, rendendosi in questo modo succubi di coloro che detengono il potere economico. In mancanza di una cultura che consenta di elaborare tale condizione, essi vivono con smarrimento il contrasto tra l’imponente abbondanza di mezzi e l’inconsistenza dei fini. Così non sanno più chi sono, e ciò li precipita nella più profonda angoscia.
Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico. (…) Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione, l’umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di sé stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini. [32]
Il consumismo svuota spiritualmente gli individui, isolandoli e alimentando in essi l’avidità. L’atteggiamento appropriativo che è alla base del paradigma dominante si riproduce così in loro, unitamente alla distruttività che vi è connessa, che può facilmente tradursi in violenza. Essi non riconoscono più infatti alcun fine comune, né regola condivisa, né limite a ciò che considerano importante per sé.
Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non contraddicano le proprie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché l’ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca.[33]
Rispetto a tale situazione, parlare di conversione ecologica vuol dire fare appello a un cambiamento che ha vaste implicazioni nell’ordinamento della società e dei mezzi di cui dispone, ma il cui nucleo è fondamentalmente spirituale. Il paradigma che è alla base della distruzione della natura è infatti ormai radicato nel cuore dell’uomo, anche perché, nel linguaggio della teologia cristiana, la sua radice è nel peccato. Occorre dunque impegnare tutte le energie per venirne a capo.
La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata.[34]
La conversione ecologica entra a far parte di un vasto cambiamento che ha diversi aspetti: politici, culturali, educativi e spirituali. Francesco lo qualifica come “resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico”. Viene da pensare che la missione che egli assegna alla Chiesa sia fortemente connotata in tal senso. D’altra parte un filosofo cattolico come Giuseppe Riconda afferma da tempo che la resistenza contro il dominio della ragione strumentale deve oggi essere il luogo d’incontro delle diverse religioni[35].
Siccome qui però tocchiamo un punto molto delicato, sia consentita una pausa di chiarimento.
Parola e azione
Del rinnovamento della Chiesa in realtà nell’enciclica non si parla, come in genere non ne parla Francesco, benché tutti lo colleghino innanzitutto proprio a ciò. Questo per la semplice ragione che del rinnovamento non si deve parlare: lo si fa. Quel che si dice è in funzione dell’agire, o le parole stesse sono azione: cioè producono cambiamento. Si osservi l’uso che delle parole fa Gesù, come è riportato nei Vangeli.
Il fatto di parlare di rinnovamento in questa sede, come tutto il resto del discorso, viene semplicemente incontro al bisogno di capire, affinché chi scrive possa aiutare, se non altri se stesso, a non cadere in fraintendimenti; giacché nulla è più facile in questi casi, quando i riferimenti abituali si fanno incerti. Mi sono dunque permesso di offrire con questa parola, che tutti in genere abbiamo in mente pensando a Francesco, un’interpretazione plausibile di ciò che egli sta facendo, pur sapendo che la parola, anche quella che meglio esprime il dinamismo intrinseco della vita, come appunto “rinnovamento”, non può interamente esprimerlo.
Detto ciò, qualora dunque Francesco avesse quale suo effettivo e consapevole proposito quello che tutti gli attribuiscono, cioè rinnovare la Chiesa, o anzi meglio se ne sentisse esplicitamente chiamato, non ne parlerebbe in forma diretta, ma farebbe altro: disseminerebbe indizi affinché chi vuole possa intendere il senso di quel che sta accadendo. Quel che si cerca di fare qui è infatti raccogliere quegli indizi e collegarli, in modo che le cose si mostrino da sé.
Dunque nell’enciclica non si parla del rinnovamento della Chiesa, bensì di qualcosa che peraltro non può non avere attinenza: del rinnovamento dell’umanità. Se ne parla per l’appunto a proposito della conversione ecologica. Si dice che tutto il patrimonio della spiritualità cristiana può contribuire “allo sforzo di rinnovare l’umanità”.
La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli di esperienze personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare l’umanità.[36]
Ma quale rapporto sussiste tra la Chiesa e l’umanità? Se si pensa alla Chiesa come istituzione, si tratta di due cose ben distinte. Se invece si pensa al suo senso spirituale, il discorso cambia: la Chiesa non è altro che l’umanità che si converte, in cui sta operando la redenzione di Cristo. Cioè l’umanità rinnovata.
Tutta “la grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli di esperienze personali e comunitarie”, è pensata come “un magnifico contributo da offrire”. Cioè il passato ha un immenso valore, ma il valore è davvero tale per il fatto di poter essere offerto. È sottinteso che, se non lo fosse, se venisse semplicemente conservato, decadrebbe.
Viene da pensare alla parabola dei talenti[37]: ai servitori buoni e fedeli, che reinvestono e fanno fruttare quel che hanno ricevuto, e a quello che lo sotterra per paura di perderlo. Ma al cuore del Cristianesimo c’è Dio stesso che si offre in sacrificio e dono: quale dubbio o timore si può ancora avere?
La spiritualità ecologica
Si sta parlando di “conversione ecologica”, e qualcuno potrebbe ancora intendere che non si parli della vita spirituale se non per analogia. Alcuni Cristiani “impegnati e dediti alla preghiera” potrebbero addirittura farsi beffe delle preoccupazioni per l’ambiente[38]. Ma l’analogia penetra la realtà più profondamente di quanto comunemente non si immagini, e in ogni caso Francesco non lascia possibilità di equivoco:
Manca loro (…) una conversione ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana.[39]
La mancanza di conversione ecologica impedisce che l’incontro con Gesù faccia emergere le sue conseguenze nelle relazioni con il mondo. Non si nega che l’incontro sia avvenuto, ma si afferma che le sue conseguenze rimangono confinate nell’interiorità. Il che è un impoverimento.
In un altro punto, in un capitolo intitolato Educazione e spiritualità ecologica, Francesco dice:
L’ideale non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità per scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose, come insegnava san Bonaventura: « La contemplazione è tanto più elevata quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre creature ».[40]
Tornando infatti alla conversione ecologica, è chiaro che Francesco la pensa in senso proprio come un’esperienza spirituale, anzi addirittura come una mistica.
Infatti non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto con delle dottrine, senza una mistica che ci animi…[41]
Ma si parla di una mistica che ha un’ispirazione ben precisa: Francesco d’Assisi. E a questo punto le cose si chiariscono.
Papa Francesco ha fin dall’inizio assunto un modello che ha un significato enorme per la Chiesa. Paradossalmente ciò scaturisce dalla sua radicale lontananza da ogni aspetto istituzionale, il che lo rende universalmente amato, anche al di fuori del mondo cristiano. La sua altrettanto radicale aderenza al creato ne fa oggi inoltre il simbolo stesso della conversione ecologica.
Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. (…) Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso.[42]
Nella sua esperienza spirituale sembra sanata la rottura introdotta nella Creazione dal peccato.
… è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature sia stata interpretata come una guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la riconciliazione universale con tutte le creature in qualche modo Francesco era riportato allo stato di innocenza originaria.[43]
Moltissimi, e soprattutto coloro che abitano le periferie, non avrebbero a questo punto dubbi: la Chiesa che vogliono è questa. Perché esclusi, quindi propensi, a ragione o a torto, ad accusare di ciò l’istituzione in quanto tale; ma anche per una ragione più profonda.
La condizione che vivono, quando ne siano coscienti e non prendano la strada del risentimento, proprio annullando in loro qualsiasi presunzione li pone più vicini all’innocenza originaria. Ecco perché Gesù considerò beati gli ultimi[44], facendosi ultimo egli stesso. E Francesco, mentre iniziavano a porsi le condizioni che avrebbero condotto al mondo moderno, con tutta la sua potenza e la sua ricchezza, considerò farsi ultimo la cosa più bella.
La spiritualità di Francesco, a cui l’enciclica si richiama fin dal nome, è una lode continua alla Creazione. Il nuovo Francesco ne fa il fondamento della spiritualità ecologica. Significativo che lo faccia citando Giovanni Paolo II.
Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell’universo». [45]
Possiamo dire che «accanto alla rivelazione propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel calare della notte». Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature: «Io mi esprimo esprimendo il mondo; io esploro la mia sacralità decifrando quella del mondo».[46]
Qualcuno potrebbe ovviamente dire che un conto è essere il poverello di Assisi, tutt’altro essere il capo della Chiesa istituzionale: sono ruoli ben diversi e al secondo non è consentita la felice libertà del primo. Bisogna però rispondere che il Francesco di allora non pensò ad altro che ad imitare lo stile di vita di Gesù Cristo, pur non avendone certo il ruolo, il quale è il fondatore e il vero capo della Chiesa. Il Francesco di adesso ha dunque sentito, attraverso quell’altro, di doversi ricollegare più direttamente a Gesù Cristo. Anche per una ragione che potrebbe essere facilmente riconosciuta in sede storica.
Lo Spirito e il potere
I rinnovamenti religiosi, riportando alla luce un senso originario in qualche misura non più compreso, implicano sempre una presa di distanza dall’istituzione. Ciò può avvenire in modo non traumatico, come del resto avvenne a suo tempo col Francesco di allora, e addirittura per impulso del vertice dell’istituzione stessa. In questo secondo caso, e parliamo del Francesco di adesso, potrebbe venire risparmiata una frattura dalle conseguenze imprevedibili.
Il problema infatti è che un’istituzione è necessariamente, al suo interno e in rapporto al mondo circostante, implicata in rapporti di potere. Tuttavia l’esperienza religiosa in quanto tale si colloca in un’altra sfera rispetto a quella del potere. Si può anche a lungo tollerare che le due sfere non siano chiaramente distinte, ma giungono momenti in cui ciò non è più possibile. Accade dunque che Gesù dica di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
Il moderno laicismo ha frainteso la questione. Ritiene in genere che le due sfere si debbano separare perché altrimenti la sfera religiosa rischia di soffocare l’altra. Ciò può avere un’apparenza di verità guardando le cose dal punto di vista di un potere statale che non vuole esser sottoposto ad alcuna limitazione: che rivendica una sovranità illimitata e autoreferenziale. Ciò contiene però i germi del totalitarismo, che è quando la sfera del potere ingloba tutto il resto.
Il problema è un altro. È che, per un ordinamento che è insito nella coscienza umana, la sfera spirituale è sovraordinata a quella del potere. Non nel senso di un potere che sia o debba essere superiore, ma di un’autorità morale da cui il potere sia regolato e limitato.
Chi pensasse a un ideale teocratico sarebbe fuori strada. In realtà una figura religiosa ha tanta più autorità quanto più sa svincolarsi dai rapporti di potere. Chi per ruolo lo esercita è in genere disposto a riconoscerla, anche perché non vede in essa un concorrente che lo incalzi sul suo stesso piano; a meno che si insinui l’ostilità di altre figure religiose o comunque importanti sul piano culturale, che allora ingaggiano una lotta per la supremazia.
Pilato avrebbe evitato di mettere a morte Gesù, se non fosse stato per le pressioni dell’establishment religioso, che vedeva in lui un pericoloso rivale. I poteri dello Stato moderno non avrebbero intrapreso una via così radicalmente avversa alla Chiesa se non vi fossero stati indotti dalle élite culturali emergenti e bisognose di autoaffermazione.
Ecco perché, insomma, Papa Francesco è oggi più popolare della Chiesa istituzionale: senza escludere le strumentalizzazioni, per una ragione in larga misura sincera. Coloro che combattono la Chiesa si sentono infatti legittimati a vedere in essa una concentrazione di potere in competizione con il loro, quindi un nemico da sconfiggere. Francesco è visto invece come qualcuno che è al di sopra dei giochi, che spontaneamente si può stimare e addirittura amare, e di cui comunque si teme il giudizio. Si ricordi ad esempio la deferenza avuta per lui da Obama, la cui politica è su importanti questioni in conflitto con la Chiesa.
Difficile dire altro intorno a questo terzo pilastro, che ha dovuto evidentemente essere curato con particolare attenzione. In un certo senso, quel che la Chiesa debba essere, Francesco l’ha lasciato dire al Patriarca Bartolomeo.
Bartolomeo … ci ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che «significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inoltre, siamo chiamati ad «accettare il mondo come sacramento di comunione, come modo di condividere con Dio e con il prossimo in una scala globale. È nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta».[47]
Quarto pilastro. L’interdipendenza
C’è un motivo che nell’enciclica ritorna costantemente.
Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri.[48]
… essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile.[49]
Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle subatomiche si possono considerare separatamente. Come i diversi componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere.[50]
E facendo riferimento al Genesi, alle vicende da Caino e Abele a Noè:
In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri.[51]
Qualcuno potrebbe esprimere sorpresa nel vedere come una visione ecosistemica della realtà, basata sull’universale interconnessione e interdipendenza, venga così radicalmente connessa con il Cristianesimo. Eppure ciò è stato riconosciuto dallo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica:
Questo insegna il Catechismo: «L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre».[52]
Si ha tuttavia ragione di pensare che le cose non siano così ovvie.
Genealogia del paradigma ecosistemico
In generale ciò che intendiamo con ecologia nasce in ambienti strettamente scientifici ancora nell’Ottocento e poi via via diventa movimento d’opinione sempre più diffuso, soprattutto a partire dagli anni settanta del Novecento. Si può senz’altro dire che in Occidente il tema dell’ecologia, insieme a quello della pace, abbia nel patrimonio delle idealità “laiche” preso il posto di quello della giustizia sociale, compromesso dalla crisi del Marxismo.
Il segnale di quel passaggio, al livello più alto della cultura filosofica, fu fornito soprattutto nel 1979 da un testo di Hans Jonas, che era stato allievo di Heidegger, dal titolo Il principio responsabilità[53]: un titolo che si poneva in rapporto con quello di un importante testo, scritto molti anni prima, del filosofo marxista Ernst Bloch: cioè Il principio speranza[54].
Il discorso su Bloch sarebbe lungo, ma sia sufficiente dire che nel suo pensiero il Marxismo si era confrontato con la sua matrice religiosa occulta, cioè il messianismo ebraico e l’escatologia cristiana, e aveva fatto del futuro un fondamento ontologico in cui collocare la piena realizzazione di ciò di cui le religioni sono state lungo i secoli promessa. Il passaggio che Jonas voleva segnalare era dunque drastico: l’inaudito sviluppo del potere distruttivo della tecnica pone per la prima volta gli uomini di fronte alla possibilità che il futuro non si dia. Anziché continuare a proiettarvi il compimento delle aspirazioni umane, si tratta di stabilire un’etica il cui principio sia di renderlo possibile.
In realtà però il testo di Jonas non incise più di tanto in una coscienza collettiva, che attingeva altrove i suoi riferimenti. L’idea che la vita sulla terra sia minacciata dalla tecnica sorge senz’altro negli ambienti della filosofia tedesca, a cominciare da Heidegger, ma le sue fondamentali categorie vengono elaborate in altri contesti.
Su un piano intermedio merita senz’altro di essere ricordata l’ecologia profonda del filosofo norvegese Arne Naess[55], che mette in discussione l’antropocentrismo, cioè l’idea che il valore della vita degli altri esseri viventi vada subordinato all’uomo. Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza nella cultura del nostro tempo, che l’enciclica recepisce pienamente riconducendolo al principio della Creazione e dell’universale destinazione di tutti gli esseri all’incontro con Dio.
Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. (…)Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.[56]
I fondamentali riferimenti culturali dell’ecologia sono comunque forniti da un modello di pensiero variamente articolato, noto come ecosistemico, o della complessità o dell’interdipendenza, che ha preso forma intorno alla metà del Novecento in certi ambiti della cultura scientifica, nei quali talora agivano suggestioni provenienti dall’Oriente. È ben vero che non era del tutto assente una connessione con la filosofia tedesca e, attraverso essa, con la mistica cristiana e prima ancora neoplatonica; ma si tratta di legami tanto sottili da non essere avvertiti.
Sul piano della comunicazione più diffusa, per merito soprattutto di autori come Fritjof Capra o Edgar Morin, l’idea che prese forma è che, nella nostra epoca, stia avvenendo all’interno della scienza un mutamento di paradigma[57] le cui conseguenze sociali sono molto ampie. Si passerebbe cioè da un modello riduzionista e meccanicista, basato sulla segmentazione della realtà in entità separati e sequenze lineari, a un modello complesso e olistico, basato invece sull’interdipendenza dei piani e su sequenze circolari.
Il contesto culturale in cui tali idee si delinearono era visibilmente determinato da due eventi.
Il primo è una rivoluzione in ambito tecnologico, costituita dall’avvento dell’informatica. La vecchia tecnologia basata sulla potenza, tipica della prima e della seconda Rivoluzione Industriale, era in procinto di venire sostituita da una nuova basata sull’informazione: ciò avrebbe comportato una riorganizzazione delle forme della vita sociale e la crisi presente doveva intendersi come il travaglio inevitabile che accompagna il passaggio. Recentemente Jeremy Rifkin, parlando di Terza Rivoluzione Industriale, esito del connubio di internet ed energie rinnovabili, ha rilanciato quel tipo di prospettiva[58].
Bisogna pensare che nel secondo dopoguerra, mentre il clima culturale europeo era ancora collocabile nella cornice della filosofia tradizionale, quello degli Stati Uniti esplorava territori nuovi. Due movimenti soprattutto vennero a convergere: la Cibernetica, cioè la nuova scienza della comunicazione direttamente legata agli sviluppi tecno-scientifici, dove le ricerche sull’intelligenza artificiale comportavano ricadute inarrestabili sul modo di concepire la mente umana e il mondo delle relazioni, e la Teoria Generale dei Sistemi. Quest’ultima, a cui lavorava già dagli anni trenta il biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy, si pose l’ambizioso compito di unificare tutti gli ambiti del sapere sulla base di un unico concetto: quello di sistema. Ogni realtà, naturale e sociale, doveva essere pensata come sistema: cioè come struttura organizzata di elementi e funzioni interdipendenti, che comprende al suo interno sottosistemi ed è a sua volta collocata entro un sistema di livello superiore: l’ecosistema. È facilmente intuibile come tale visione fosse destinata a incontrarsi con la preesistente ma ancora poco nota nozione di ecologia, fornendole un fondamento teorico di notevole rilievo.
La convergenza dei due filoni determinò comunque in genere una propensione a leggere la realtà in termini di processi comunicativi e di organizzazione, sviluppando una particolare attenzione al cambiamento. Ogni sistema tende a realizzare un equilibrio, il quale però in fondo è sempre instabile e può mutare anche radicalmente in presenza di particolari condizioni. Prevedere o anche provocare il cambiamento, entro realtà per definizione complesse, divenne sempre più esplicitamente l’obiettivo comune di ingegneri, fisici, biologi, medici, sociologi, psicologi.
A Gregory Bateson si deve in particolare una rivoluzionaria teoria antropologica, che ebbe ricadute soprattutto in ambito psicoterapeutico.
Intendendo la comunicazione tra esseri umani come un fatto di portata generale, non limitato cioè a quel che essi dicono o fanno intenzionalmente, ma insito in ogni loro comportamento in quanto determina effetti sul sistema delle relazioni, ebbe l’intuizione che la comunicazione avvenisse simultaneamente a diversi livelli. Ogni messaggio comunicativo è accompagnato insomma da una metacomunicazione, cioè una comunicazione di livello superiore, generalmente non verbale, che ridefinisce la relazione in cui si trovano i soggetti comunicanti, contribuendo a precisare il senso del messaggio di primo livello. Ad esempio, dato un certo contenuto verbale, è il tono di voce a precisare se quel che viene detto va inteso come comando, richiesta o altro.
Dal punto di vista psicoterapeutico tale visione parve immediatamente interessante pensando a situazioni in cui si determina una ricorrente incongruenza tra i due livelli comunicativi. Tipico caso è quello della madre che a parole comunica affetto al proprio bambino ma col tono di voce e la gestualità trasmette invece distacco. Venne così formulata dallo stesso Bateson la teoria del doppio legame nella genesi della malattia mentale[59], dando così inizio alla scuola di terapia sistemica, il cui maggior teorico fu Paul Watzslawick[60].
Poiché la situazione di sofferenza veniva considerata conseguenza di problemi comunicativi che caratterizzano il sistema delle relazioni, soprattutto familiari, ci si poneva il problema di produrre un cambiamento nel funzionamento del sistema. Ciò a sua volta, al di là delle tecniche specifiche, dischiudeva da una prospettiva inedita il problema esistenziale del senso della vita. La condizione patologica è una condizione di mancanza di senso, perché il soggetto ha interiorizzato un’incongruenza tra il piano della consapevolezza e quello dei vissuti profondi; la guarigione, reintegrando i due piani, comporta un cambiamento che è una vera e propria conversione della persona.
Le implicazioni di tale teoria rispetto all’educazione, all’apprendimento e all’interpretazione del cammino personale sono enormi, ma ancora quasi interamente da esplorare.
Il secondo evento che contribuì alla diffusione del paradigma ecosistemico è già costituito dall’esplodere della consapevolezza della crisi ambientale. Il vecchio paradigma ne era considerato responsabile: essendo basato sull’idea del dominio sulla natura, quindi incapace di vedere in essa l’ecosistema che accoglie la vicenda umana, aveva operato distruttivamente su di essa, come se le conseguenze potessero non ricadere sull’uomo.
La questione ecologica veniva quindi ricondotta al cambiamento di paradigma. Si trattava in ogni ambito di passare dalla causalità lineare a quella circolare, dal riduzionismo alla complessità, dall’isolamento alla relazione. L’ecologia della mente, usando la celebre espressione di Bateson, doveva accompagnare il cambiamento sociale e tecnologico.
Radici nell’Oriente
Tutto ciò ebbe a suo tempo scarso ascolto nel mondo cattolico, lacerato da tutt’altri problemi, per quanto le psicoterapie sistemiche apparissero fin da subito congeniali, sviluppandosi non a caso come terapie della famiglia anziché dell’individuo. Troppo forte era all’epoca l’estraneità culturale, e anche il sospetto.
Quel clima, notevolmente diffuso tra le élite intellettuali occidentali tra gli anni sessanta e ottanta del Novecento, oltre a ispirare i movimenti ecologisti e no-global, ebbe infatti a livello di massa un ruolo non secondario nello sviluppo della cultura New Age. Anche perché alcuni dei suoi protagonisti avevano un profondo legame con l’Oriente.
Bisogna dunque pensare che alla genesi e alla diffusione del paradigma ecosistemico abbia concorso anche un terzo evento, per quanto non sempre chiaramente sotto gli occhi di tutti: l’emergere sul piano internazionale delle grandi culture asiatiche. Come scrisse il celebre orientalista Giuseppe Tucci: “L’avvenimento maggiore al quale oggi assistiamo è l’ingresso dell’Asia nella storia”[61].
Si tratta di un avvenimento, come già segnalato, già in preparazione da lungo tempo, fin dall’epoca del colonialismo.
Nello sviluppo della moderna cultura occidentale, l’Oriente è diventato lo specchio entro cui si riflettono le sue diverse tendenze. La Cina piaceva agli Illuministi, che vedevano in essa il modello di una società che da sempre sapeva governarsi senza bisogno di trascendenza. Per i Romantici invece, che per primi diedero voce al disagio di un mondo secolarizzato, era l’India oggetto di attrazione, in quanto patria originaria della spiritualità umana.
Lungo il Novecento, mentre il dominio mondiale è conteso tra potenze ancora in fondo occidentali, sono le vicende asiatiche a riempire sempre più la scena. L’Oriente non è più un luogo solo dell’immaginario, ma una presenza sempre più importante sotto ogni aspetto. Sul piano culturale ci si avvede che tutta un’idea della civiltà di cui l’Occidente è portatore non è che una tra le possibili, e che altre visioni della vita sono concepibili.
Il Sessantotto guarda alla Cina in senso politico, all’India in senso esistenziale, cercando in entrambi i casi una via nuova e antica insieme. In generale, l’Oriente è il luogo in cui l’uomo non è più racchiuso entro i suoi confini individuali, ma si integra in realtà più ampie, per un verso rigorose e disciplinate, per l’altro fluide. Mentre l’Occidente è fissato alle categorie astratte attraverso cui ha plasmato la sua visione della realtà, in Oriente ogni cosa pare immersa nello scorrere della vita.
Secondo Fritjof Capra gli scenari più sorprendenti della fisica contemporanea non sono più interpretabili con le categorie della filosofia occidentale, bensì mostrano affinità con le visioni hinduiste, buddhiste e taoiste[62]. Vari illustri scienziati, tra cui Francisco Varela, intraprendono uno stabile confronto con il Dalai Lama, dando luogo a simposi che sono tra le maggiori esperienze intellettuali del nostro tempo[63].
Nella visione buddhista, “interdipendenza” è la traduzione più opportuna di ciò che risulta dal convergere, nel contesto Mahayana, delle tradizionali nozioni di “mancanza di sé”, (anatman) e “originazione dipendente” (pratityasamutpada) con quella tipicamente Mahayana di “vacuità” (shunyata)[64].
Riassumendo il senso di complesse questioni dottrinali, si tratta di pensare che quel che comunemente appare, cioè l’interagire di entità originariamente dotate di esistenza indipendente, non corrisponda alla reale natura delle cose, che deve essere pensata come radicalmente relazionale: il darsi di un certo stato dipende da cause e condizioni che lo determinano, venendo meno le quali esso viene meno. Sono le necessità di tipo pratico della vita a comportare che un certo stato sia isolato dal flusso dell’esperienza e gli venga attribuito, mediante l’applicazione di un concetto, un’esistenza indipendente. La quale peraltro, a un’attenta analisi, non può essere accertata: nulla infatti può essere detto che non rinvii a cause e condizioni e soprattutto al soggetto cognitivo responsabile della designazione.
Attenzione. Tale concezione viene solitamente contrapposta al sostanzialismo tipico della filosofia occidentale, che sembra venire incontro alla visione cristiana dell’unità della persona. Si pongono quindi delicate questioni di tipo ontologico. Il timore è soprattutto che vada disgregandosi quell’unità, insieme a ogni autonoma consistenza del reale, e che si tratti dunque di una visione nichilistica: nulla esiste se non ciò che un soggetto designa come tale, isolando alcuni aspetti per lui rilevanti in un flusso indifferenziato di esperienza. Ciò condurrebbe a un radicale soggettivismo, che non riconosce alcuna realtà se non quella che il soggetto stesso viene definendo. Non è il caso di dilungarci su quanto una tale visione sia pericolosa, soprattutto oggi.
Bisogna però dire che tale esito non è affatto necessario, e anzi sarebbe contraddittorio, in quanto paradossalmente attribuirebbe realtà affermativa alla negazione, entificando il nulla. Si tratta dunque di altro. Non di pensare che le apparenti realtà dell’esperienza non esistano, ma che non esistono come le pensiamo, nel senso che il pensiero non può coglierle, se non nei due modi indicati.
Il primo, corrispondente al senso comune, consiste nell’attuare un inconsapevole processo di reificazione, ovvero trasformare in cose, dotate di precisi confini spazio-temporali, ciò che a un’attenta analisi mostra una ben maggiore e forse inesauribile complessità. Il secondo, frutto dell’analisi, è la constatazione dell’irriducibile interdipendenza di ogni supposto oggetto, e anche dello stesso soggetto conoscente, quindi la confutazione dell’autonoma realtà di entrambi. Il che però a sua volta non significa che essa non esista, ma che il pensiero non la può conoscere.
Tale visione paradossalmente, anziché dissolvere ogni realtà trascendente il pensiero, la salva nella sua trascendenza, proprio dichiarandola irraggiungibile. Se fosse raggiungibile, in realtà ne dipenderebbe.
La filosofia buddhista ha quindi fatto i conti fino in fondo con ciò di cui quella occidentale non è solitamente consapevole, cioè il carattere appropriativo di quel che comunemente si intende con conoscenza: ovvero il fatto che gli oggetti non siano semplicemente scoperti, bensì definiti, e in ampia misura costruiti, sulla base di esigenze pratiche ed esistenziali. Concentrare l’attenzione su ciò però vuol dire liberarsene: rendere possibile un terzo livello di conoscenza non più concettuale, traducibile nell’esperienza propriamente spirituale o, come si dice, nell’apertura del terzo occhio.
Ecologia e Cristianesimo
Detto ciò, e sottolineando che siamo propriamente sul terreno di quel che in Occidente si intende con filosofia, è ovvia la domanda su quale rapporto tale visione possa intrattenere con il Cristianesimo. Il quale invece sembra chiaramente porsi su tutt’altro terreno, anche se tra i due non mancano contatti.
Storicamente il Vangelo viene annunciato in un contesto diverso da quello in cui era nata la filosofia greca, anche se fin da subito ne tiene conto nella sua diffusione, soprattutto varcando i confini del mondo ebraico e rivolgendosi alle élite ellenizzate. In particolare sarà il Platonismo a offrire per molti secoli la fondamentale mediazione culturale, come poi l’Aristotelismo. Naturalmente né Platone né Aristotele erano stati cristiani, ma il loro pensiero evidentemente consentiva quella sintesi di cui la novità cristiana aveva bisogno allora. In questo modo il Cristianesimo assunse la forma culturale entro cui ci è pervenuto, plasmando d’altra parte la civiltà occidentale.
Ebbene, è possibile che quella forma oggi non sia più riproponibile, per una ragione che meglio di ogni altro ha messo in luce Raimon Panikkar, in un libro meditato lungo quarant’anni che significativamente si intitola Il silenzio del Buddha[65].
Al centro della filosofia greca c’è un modello di pensiero in un certo senso analogo a quello buddhista, ma con un esito rovesciato. Le cose non sono come appaiono, ma sono come le mostra il pensiero. E poiché quest’ultimo è in grado di rivelarne la natura, tra pensiero ed Essere c’è coincidenza.
Questa è la visione entro cui è stato possibile pensare Dio come fondamento razionale della realtà, ma è anche la stessa della scienza; tant’è vero che in epoca moderna Dio viene meno, lasciando alla scienza l’intero campo. Aggiungiamo che il dominio della tecnica si fonda sul presupposto originario dell’identità di pensiero ed Essere, che vuol dire che l’Essere si riduce al pensiero umano che se ne appropria. Direbbe Heidegger, la struttura originaria è già quella della volontà di potenza.
Secondo Panikkar ritrovare la fede comporta rinunciare a quell’identità di pensiero ed Essere, cioè al pensiero appropriativo, compiendo quindi oggi una svolta analoga a quella rappresentata dal Buddha nell’India antica.
È possibile che una tale svolta sia oggi effettivamente in atto?
Cosa implica l’incontro del Cristianesimo con il paradigma ecosistemico e con l’interdipendenza, di cui l’enciclica Laudato si’ è testimonianza più che evidente?
Su quali basi tale incontro avviene?
Si possono formulare due risposte.
La prima, di ordine strettamente filosofico, è che, nel corso della storia, la Chiesa ha compiuto in epoche diverse scelte filosofiche diverse, tenendo però sempre conto di un’esigenza evidentemente imprescindibile: salvaguardare un senso della realtà che i soggettivismi e i relativismi pongono di volta in volta in discussione. Con tutto un atteggiamento culturale che lungo i secoli viene riproponendosi in forme varie, dalla Sofistica al Postmoderno, non c’è mai stata possibilità di conciliazione.
Già a suo tempo le ragioni che indussero il Cristianesimo a incontrare il Platonismo vanno valutate in questa luce. Si tratta infatti di un orientamento di pensiero che non solo propone chiaramente una visione spirituale della vita, ma soprattutto fonda su di essa un’apertura alla realtà concepita come indipendente dal soggetto conoscente.
Nella prospettiva platonica si circoscrive l’ambito del relativo a quello dell’esperienza dei sensi: in cui il soggetto non può avere conoscenza delle cose se non sulla base della sua interazione con esse. Ma, scrutando più profondamente dentro di sé, può riconoscere quel che a prima vista sfugge: vale a dire che la conoscenza delle cose presuppone delle forme che le classifichino, che il soggetto è indotto a considerare indipendenti da sé. Parliamo ovviamente delle idee. La parola deriva dalla radice id del verbo greco orào, che vuol dire vedere. L’idea è dunque ciò che si vede, ma non certo con gli occhi del corpo bensì con quelli dell’anima: ovvero ciò che il soggetto coglie nella dimensione spirituale sua propria
La realtà è stata quindi concepita, nel suo fondamento di verità e quindi al di là dell’apparenza, come una struttura razionale soggiacente all’esperienza dei sensi.
Come noto, ciò ha posto delicati problemi circa il rapporto tra la dimensione materiale e quella immateriale, ovvero tra il corpo e la mente. La filosofia di Aristotele può sotto questo aspetto intendersi come la proposta di un sorta di interdipendenza tra le due sfere, pur mantenendo una delle due la supremazia rispetto all’altra. La visione di Dio come motore immobile ha una forte suggestione sul piano religioso perché esprime in forma dinamica la convinzione che il mondo naturale si strutturi in forme di complessità crescente perché guidato dal principio ultimo, che è pura realtà intellettiva. Oggi si direbbe che la natura è progetto intelligente.
In ogni caso la visione platonica, di una struttura razionale soggiacente all’esperienza dei sensi, ha costituito lungo l’intero arco della civiltà occidentale il presupposto, per lo più inconsapevole, di quel che intendiamo con scienza. Gli scienziati, anche in piena epoca moderna e in qualche modo tutt’oggi, hanno la convinzione di andare alla ricerca delle leggi, dotate di esistenza oggettiva, che regolano la natura al di là dell’esperienza sensibile. La natura, nella struttura delle leggi che la ordinano, viene tacitamente intesa come un universo normativo che l’uomo riconosce, essendone egli stesso parte.
Ciò entra però in conflitto con un diverso principio, che sempre più emerge in epoca moderna.
La crescente importanza della tecnica nella vita sociale induce a concepire la natura come oggetto di sfruttamento e manipolazione, rendendo così problematico riconoscerne la funzione normativa. Ciò a sua volta produce un movimento di pensiero, caratterizzante la filosofia moderna, che implacabilmente sovverte il Platonismo. Si fa strada il sospetto che la struttura razionale, che il soggetto scopre in sé come presupposto della conoscenza, non sia davvero indipendente da lui.
Già nel nominalismo tardo-medievale l’intera scienza è ridotta a sistema di segni linguistici, che ordinano entità puramente individuali. Così anche nel moderno Empirismo. Nella filosofia di Kant la Modernità raggiunge una posizione di equilibrio: la struttura razionale è insita normativamente nel soggetto, ed egli non può ordinare la realtà se non nel modo in cui lo fa. È però evidente che il soggetto, seppure in modo non arbitrario, se ne è posto a fondamento.
Il resto viene di conseguenza. Nella seconda metà dell’Ottocento la crisi dei fondamenti della scienza mostra che questi ultimi, anziché appartenere intrinsecamente alla realtà, sono costrutti concettuali che possono anche essere cambiati. Le geometrie non euclidee dischiudono infatti nuove visioni dello spazio, di cui la fisica novecentesca si avvarrà. Contemporaneamente Nietzsche scaglia il suo atto d’accusa contro il platonismo implicito nella scienza e in tutta la civiltà occidentale, a cui il Cristianesimo ha assicurato diffusione tra le masse: si tratta della costruzione di un “mondo dietro il mondo”, una menzogna che ha avuto la funzione di assicurare l’ordine morale. Ora che però si verifica la morte di Dio, la distinzione tra il vero e il falso e quella tra il bene e il male vengono parallelamente meno. Le cose non hanno più né senso né struttura, se non ciò che viene loro attribuito. Fondamento di tutta la realtà non è altro che la Volontà di Potenza.
Quando Benedetto XVI inaugurò il suo pontificato all’insegna della lotta contro la dittatura del relativismo, aveva dunque ben presente che la situazione attuale è frutto di un corso di pensiero che viene da lontano. Ricercando tra l’altro il dialogo con gli uomini di scienza, egli volle in ogni modo riaffermare la razionalità del Cristianesimo, cioè il suo fondarsi su un ordine della realtà che è quello stesso di cui la scienza è in cerca, cioè quell’eterno Logos di cui Cristo è l’incarnazione. Le cose erano però ormai andate troppo avanti. Il clima sociale in Occidente è dominato da una concezione radicalmente soggettivistica, al punto che la sua estrema manifestazione, cioè l’ideologia del gender, fa dipendere dall’arbitrio individuale la stessa identità sessuale. Il Platonismo vive insomma un irrimediabile discredito.
D’altra parte, riflettendo su Nietzsche, Heidegger era arrivato a pensare la Volontà di Potenza come il principio che fin da Platone domina, dapprima implicitamente e inconsapevolmente, l’Occidente. Ciò che egli chiama riduzione dell’Essere a ente è quello che Panikkar traduce come riduzione dell’Essere al pensiero. Proprio perché definito concettualmente, l’Essere è imprigionato entro le griglie della razionalità. Sotto questo aspetto il moderno dominio della tecnica non fa che portare allo scoperto ciò che nell’antica metafisica era nascosto. Non è quindi tornando a essa che si trova la soluzione, bensì cercando oltre.
Come Francesco osserva incidentalmente, riferendosi al dialogo con i diversi soggetti che interagiscono sull’emergenza ambientale e citando l’Evangelii gaudium, “la realtà è superiore all’idea”[66].
Il paradigma ecosistemico formula una visione della realtà in cui non la si pretende indipendente dal soggetto che la pensa. Sono inevitabilmente le categorie di cui quest’ultimo si avvale a definirne i tratti. Altrettanto però non si pretende che l’ordine che il soggetto attribuisce alla realtà sia semplicemente sua proiezione. Il contesto in cui veniamo al mondo ci preesiste e noi ne dipendiamo. Nell’enciclica questo appare chiaramente.
Come ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto di essere una creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di organismi in uno spazio determinato, che funziona come un sistema. Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la nostra stessa esistenza.[67]
Si può senz’altro intendere che la conoscenza sia un sistema di concetti e parole, dotato di regole sue proprie, che entra in comunicazione con altri sistemi; i quali a prescindere dal primo non sono direttamente attingibili, ma a cui non abbiamo diritto di negare un proprio ordinamento intrinseco, seppure sulla base di codici che rispetto alle nostre concettualizzazione presentano soltanto analogie. Possiamo ad esempio pensare che una specie animale sia senz’altro da noi definita sulla base della zoologia, che è una costruzione teorica sempre in qualche modo falsificabile; il che però non impedisce ai suoi membri di riconoscersi tra loro del tutto indipendentemente. Il nominalismo ha insomma valide ragioni, ma non in assoluto.
Pensando all’ideologia del gender, è senz’altro vero che l’identità di genere è culturalmente definita: cioè quello che comporta essere uomo o donna dipende da vari condizionamenti socio-culturali. Tuttavia essere uomo o donna è innanzitutto una realtà che si radica in sistemi prelinguistici e preconcettuali, da cui le realtà socio-culturali sono a loro volta condizionate. Ovvero si può senz’altro dire che la realtà è superiore all’idea. In una visione ecosistemica la natura è insomma in ogni suo aspetto il contesto-ambiente a cui innanzitutto apparteniamo.
Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati.[68]
Essere parte della natura esclude che la si possa osservare dall’esterno: quindi la conoscenza non può essere oggettiva, se a questo termine si attribuisce il significato di un rispecchiamento a cui sia estraneo ogni coinvolgimento del soggetto; non può però neppure essere soggettiva, se si intende che la natura non abbia leggi se non quelle che il soggetto le attribuisce. La prima posizione potrebbe dirsi ingenua, la seconda delirante. Soggetto e oggetto nella conoscenza sono interdipendenti, in quanto inclusi in un sistema di ordine superiore.
L’idea poi che l’uomo possa realmente dominare sulla natura, dal momento che ne è parte, mostra palesemente una grave sconnessione dei piani logici dell’esperienza. Può senz’altro paragonarsi alla condizione patologica, come risulta dall’analisi di Bateson.
Piuttosto, l’apertura e la comunicazione dei sistemi, nonché il rapporto gerarchico di inclusione, può indurci a pensare la natura nel suo insieme come sistema aperto alla trascendenza.
In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa.[69]
Interdipendenza, Incarnazione e Trinità
La seconda ragione per l’incontro odierno tra il Cristianesimo e il paradigma dell’interdipendenza riguarda propriamente il piano teologico.
Al centro del Cristianesimo è l’Incarnazione. Come si dice nel prologo di San Giovanni, “il Logos si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”[70]. Nello stesso Vangelo, Gesù dice: “Dio nessuno l’ha mai visto; il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui ce l’ha rivelato”[71].
La filosofia platonica non ha mai potuto fornire un modello concettuale davvero in sintonia con l’Incarnazione. La realtà sensibile è sempre stata pensata come drasticamente subordinata al sovrasensibile. Come noto per Platone il corpo era prigione dell’anima. In genere il Platonismo nelle sue varie forme concepisce la dimensione spirituale, per lo più coincidente con quella razionale, come superiore alla materia e bisognosa di separarsi da essa e dalle sue contaminazioni. La vita corporea è quindi esilio, da cui si aspira a fare ritorno.
Tutto ciò non è a rigore conciliabile con l’Incarnazione, e neppure con la Creazione. Tant’è vero che in alcune visioni gnostiche la Creazione è opera di un principio malvagio. Pur tenendo conto che, parlando di Platonismo, si deve intendere un fenomeno complesso, il suo nucleo originario non è purtroppo estraneo all’idea del dominio sulla natura, che potrebbe addirittura esserne l’esito secolarizzato.
Bisogna pensare invece che nel Cristianesimo lo Spirito né coincide con la razionalità né si contrappone alla materia, bensì va inteso come un’unità più profonda che entrambe le comprende. A questo riguardo bisogna uscire da equivoci che hanno pesantemente condizionato la percezione del Cristianesimo.
Gesù viveva una piena armonia con la creazione, e gli altri ne rimanevano stupiti: « Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono? » (Mt 8,27). Non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a sé stesso affermava: « È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone” » (Mt 11,19). Era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo. Tuttavia, questi dualismi malsani hanno avuto un notevole influsso su alcuni pensatori cristiani nel corso della storia e hanno deformato il Vangelo. [72]
Bisogna pensare che nel Cristianesimo la realtà cosmica non è dunque per nulla estranea a Dio. Il che ci rimanda a un senso della Creazione non ancora forse del tutto compreso.
Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione universale.[73]
Questo senso della Creazione si radica nel cuore del Cristianesimo, che è la Trinità.
Il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento amoroso e comunicativo di quanto esiste. Il Figlio, che lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si unì a questa terra quando prese forma nel seno di Maria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente nel cuore dell’universo animando e suscitando nuovi cammini. Il mondo è stato creato dalle tre Persone come unico principio divino, ma ognuna di loro realizza questa opera comune secondo la propria identità personale. Per questo, «quando contempliamo con ammirazione l’universo nella sua grandezza e bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità».
Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comunione trinitaria porta a pensare che tutta la realtà contiene in sé un’impronta propriamente trinitaria.[74]
Raimon Panikkar, che spiritualmente era profondamente radicato nell’esperienza trinitaria, ha sviluppato una visione, detta cosmoteandrica, in cui Dio, in quanto concepito nella sua trascendenza, è una dimensione di realtà che coesiste con altre due: l’Uomo e il Cosmo. Tutta la storia delle religioni, e in genere la storia culturale, è data dalla preminenza di volta in volta avuta da ciascuna di esse. Sicuramente l’epoca in cui la dimensione cosmica era preminente è la più antica nella vicenda umana, ma ciò non vuol dire che essa non continui a essere presente nella coscienza religiosa successiva.
Nel Cristianesimo essa è particolarmente connessa coi Sacramenti.
I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbracciare il mondo su un piano diverso. L’acqua, l’olio, il fuoco e i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica e si incorporano nella lode. La mano che benedice è strumento dell’amore di Dio e riflesso della vicinanza di Cristo che è venuto ad accompagnarci nel cammino della vita. L’acqua che si versa sul corpo del bambino che viene battezzato è segno di vita nuova. Non fuggiamo dal mondo né neghiamo la natura quando vogliamo incontrarci con Dio. Questo si può percepire specialmente nella spiritualità dell’Oriente cristiano: «La bellezza, che in Oriente è uno dei nomi con cui più frequentemente si suole esprimere la divina armonia e il modello dell’umanità trasfigurata, si mostra dovunque: nelle forme del tempio, nei suoni, nei colori, nelle luci e nei profumi». Per l’esperienza cristiana, tutte le creature dell’universo materiale trovano il loro vero senso nel Verbo incarnato, perché il Figlio di Dio ha incorporato nella sua persona parte dell’universo materiale, dove ha introdotto un germe di trasformazione definitiva: «Il Cristianesimo non rifiuta la materia, la corporeità; al contrario, la valorizza pienamente nell’atto liturgico, nel quale il corpo umano mostra la propria natura intima di tempio dello Spirito e arriva a unirsi al Signore Gesù, anche Lui fatto corpo per la salvezza del mondo».[75]
Questa connessione con l’esperienza cosmica si trova soprattutto nell’Eucaristia. In essa cielo e terra si uniscono e il mistero dell’Incarnazione ci compenetra profondamente, in modo che, non dall’alto ma da dentro, ci facciamo atto d’amore cosmico.
Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende a manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell’Incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell’Eucaristia è già realizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell’universo, il centro traboccante di amore e di vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie a Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore cosmico: «Sì, cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo». L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eucaristico «la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore stesso». Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato.[76]
Merita osservare che il sì cosmico che Francesco riprende da Giovanni Paolo II vuole cancellare secolari equivoci accumulati intorno al Cristianesimo e alla sua pretesa negazione della natura. Viene da pensare al suo più estremo accusatore, Nietzsche, il quale oppose la fedeltà alla terra alle sovraterrene speranze. Ma non era forse quell’opposizione il sintomo più eloquente della malattia che egli denunciava? Dal momento che, superati gli equivoci, un’autentica esperienza religiosa è anche un’esperienza cosmica, non sarà che un’autentica esperienza cosmica è anche un’esperienza religiosa?
La struttura trinitaria della realtà è infine il vero fondamento teologico dell’interdipendenza. Poiché la relazione è insita in Dio stesso, necessariamente la si ritrova nel mondo. In questa luce si deve anche concepire il senso del cammino personale di ciascuno, orientato a una realizzazione che è comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature.
Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale che in seno all’universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità.[77]
Contemplare il mondo dall’interno
Attenzione.
Quel cammino di uscita da sé per vivere in comunione, attraversi cui si cresce, si matura e ci si santifica, non è mai fuga dal mondo ma più profonda aderenza a esso. È vivere pienamente nel presente, anziché proiettarsi vanamente nel futuro[78]. È lavoro, che è cosa ben diversa dalla tecnica[79]. È ritorno a un’economia reale[80], e a un’imprenditoria che crei lavoro[81]. È comunità[82]. È sobrietà[83]. È attenzione alle piccole cose, oltre che alle grandi scelte, secondo l’esempio di Teresa di Lisieux[84]. È bellezza[85].
Se il cammino ha poi il suo fondamento nell’esperienza contemplativa, essa viene ridefinita in modo da non suscitare equivoci. Si tratta di contemplare il mondo non da fuori ma da dentro, riconoscendo i legami che uniscono a tutti gli esseri.
Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri.[86]
L’idea di poter contemplare il mondo dall’esterno è tipica di quell’atteggiamento appropriativo, che è all’origine del paradigma tecnocratico, la cui radice ultima, in termini cristiani, è il peccato. La condizione che all’uomo è data, che può intendere come volontà di Dio o realtà comunque delle cose, è di appartenere al mondo: qualunque diverso pensiero, per quanti vantaggi abbia a promettere, conduce in errore. Dal che si ricava che il peccato consiste anche proprio in un errore logico: quello di concepirsi esterni a ciò di cui si è invece parte.
La scelta di Francesco d’Assisi, e di tutti i santi, gli asceti e i rinuncianti, è sotto questo aspetto chiara. Ciò a cui si rinuncia è la pretesa, variamente connotata, a quello sguardo esterno. La rinuncia al mondo, erroneamente pensata come chiusura a esso, è in verità un’apertura più profonda, essendo rinuncia allo sguardo appropriatore. E poiché l’io stesso si è costituito in quell’appropriazione, è rinuncia all’io. Quel che resta è la gioia della liberazione, il ritrovamento dell’innocenza. Per colui che fiduciosamente contempla il mondo nell’unico modo in cui esso davvero si mostra, cioè dall’interno, la natura è luogo della presenza di Dio.
… tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito vivificante che ci chiama a una relazione con Lui.[87]
[1] Laudato si’, 2
[2] Op. cit., 117.
[3] Ibidem, 121.
[4] Gen 1,28, testo CEI74
[5] Umberto Galimberti, Orme del sacro. Il cristianesimo e la desacralizzazione del sacro, Feltrinelli, Milano 2000, pp. 67-68
[6] Laudato si’, 66
[7] Op. cit., 67.
[8] Ibidem, 5.
[9]Ibidem , 64. Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 15: AAS 82 (1990), 156.
[10] Ibidem, 19.
[11] Ibidem, 115. Citazione di Romano Guardini, La fine del mondo moderno, pp.57-58.
[12] Ibidem, 73.
[13] Ibidem, 75.
[14] Ibidem, 137.
[15] Ibidem, 93.
[16] Ibidem, 139.
[17] Ibidem, 48.
[18] Ibidem, 49.
[19] Ibidem, 119.
[20] Ibidem, 118.
[21] Ibidem, 120.
[22] Ibidem, 136.
[23] Ibidem, 6.
[24] Ibidem, 155. Citato: Catechesi (15 aprile 2015): L’Osservatore Romano, 16 aprile 2015, p. 8.
[25] Mt 5,17
[26] Mt 22, 35-40; Mc 12, 28-31.
[27] Corinzi I, 13,1.
[28] Laudato si’, 66.
[29] Op. cit., 161.
[30] Ibidem, 33.
[31] Ibidem, 106.
[32] Ibidem, 203.
[33] Ibidem, 204.
[34] Ibidem, 111.
[35] Giuseppe Riconda, Un’ermeneutica dell’esperienza religiosa, in Interdipendenza n. 2, febbraio-marzo 2006.
[36] Ibidem, 216.
[37] Mt 25,14-30.
[38] Laudato si’, 217.
[39] Op. cit., 217.
[40] Ibidem, 233. Citazione da S. Bonaventura, In II Sent., 23, 2, 3.
[41] Ibidem, 216.
[42] Ibidem, 10.
[43] Ibidem, 66. Cfr Legenda Maior, VIII, 1: FF 1134.
[44] Mt 5,1-12.
[45] Laudato si’, 85. Citato Giovanni Paolo II, Catechesi (30 gennaio 2002), 6: Insegnamenti 25/1 (2002), 140.
[46] Op. cit., 85. Citato Giovanni Paolo II, Catechesi (26 gennaio 2000), 5: Insegnamenti 23/1 (2000), 123. Id., Catechesi (2 agosto 2000), 3: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
[47] Ibidem, 9. Conferenza al Monastero di Utstein, Norvegia (23 giugno 2003). Discorso «Global Responsibility and Ecological Sustainability: Closing Remarks», I Vertice di Halki, Istanbul (20 giugno 2012).
[48] Ibidem, 42.
[49] Ibidem, 89.
[50] Ibidem, 138.
[51] Ibidem, 70.
[52] Ibidem, 86. Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 340.
[53] Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt/M., 1979, trad. it. Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2002.
[54] Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde, 1954–1959, trad. it. Il principio speranza, Garzanti, Milano 2005.
[55] Arne Næss, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary (1973), in Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol. 16, n° 1-4, 1973, pp. 95-100, tradotto in italiano in A. Næss, Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. Una sintesi (1973), in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 143-149.
[56] Laudato si’, 83-84.
[57] L’idea è mutuata dalla teoria delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn.
[58] Jeremy Rifkin, The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World, 2011, trad. it. La terza rivoluzione industriale. Come il “potere laterale” sta trasformando l’energia, l’economia e il mondo, Milano, Mondadori, 2011.
[59] Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, 1972, trad. it. Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano 1977.
[60] Watzslawick, Beavin, Jackson, Pragmatics of Human Communication, 1967, trad. it. Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, Roma 1971
[61] Giuseppe Tucci, Storia della filosofia indiana, Laterza, Roma-Bari 1977; TEA, Firenze 1992, p. 3.
[62] Fritjof Capra, The Tao of Fhysics, 1975, trad. it. Il Tao della fisica, Adelphi, Milano 1982.
[63] Ci si riferisce agli incontri Mind and Life, tenutisi soprattutto a Daharamsala, in India, a partire dal 1987.
[64] Un’utile lettura è quella di Paul Williams, Buddhist Thought. A complete Introduction to the Indian Tradition, 2000, trad. it. Il Buddhismo dell’India. Un’introduzione completa alla tradizione indiana, Astrolabio-Ubaldini, Roma 2002.
[65] Mondadori, Milano 2006
[66] Laudato si’, 201. Riferimento all’Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 231: p. 1114.
[67] Op. cit., 140.
[68] Ibidem, 139.
[69] Ibidem, 79.
[70] Gv 1,14.
[71] Gv 1,18.
[72] Laudato si’, 98.
[73] Op. cit., 76.
[74] Ibidem, 238-239. Citato Giovanni Paolo II, Catechesi (2 agosto 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
[75] Ibidem, 235. Citazioni da Giovanni Paolo II, Lett. ap. Orientale lumen (2 maggio 1995), 11: AAS 87 (1995), 757.
[76] Ibidem, 236. Citazioni da Giovanni Paolo II, Lett. enc. Ecclesia de Eucharistia (17 aprile 2003), 8: AAS 95 (2003), 438, e Benedetto XVI, Omelia nella Messa del Corpus Domini (15 giugno 2006): AAS 98 (2006), 513.
[77] Ibidem, 240.
[78] Ibidem, 226.
[79] Ibidem, 98.
[80] Ibidem, 189.
[81] Ibidem, 129.
[82] Ibidem, 219.
[83] Ibidem, 223.
[84] Ibidem, 230.
[85] Ibidem, 235.
[86] Ibidem, 220.
[87] Ibidem, 88.