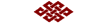Il nostro mondo sta perdendo la verità. Ciò che emerge è lo spettacolo di una giostra fuori comando, come nei film dell’orrore, che gira sempre più veloce su se stessa e non va da nessuna parte se non al suo proprio collasso.
La metafora può essere utile: la giostra è divertente proprio perché non ci allontana da dove siamo, eppure ci dà l’ebbrezza del movimento con tutto il brivido della velocità e della forza centrifuga da compensare, sollecitando in noi la piacevolezza dell’abbandono e insieme l’eccitazione della vigilanza autoconservativa. Se si tratta di un gioco tutto va bene, ma se diviene la forma della vita stessa allora si schiude il dramma, perché il movimento della vita vera è sempre caratterizzato da un verso dove, da un andare, magari ritornare, errabondare, smarrire e ritrovare, percorrere e cercare il cammino.
Contiene insomma, accanto alla circolarità dei cicli, la linearità di una direzione che spinge oltre, come lo stesso trascorrere del tempo ci segnala. Il lume di questo cammino, la fonte di orientamento è la Verità. Conosciuta, ignorata, cercata, bramata, disattesa, negata, fa lo stesso. Essa è comunque la fonte dell’orientamento, a monte anche di ogni disorientamento, è la scaturigine di ogni possibile distinzione, la luce che permette di discernere (e anche sbagliare), la luce, come direbbe Cusano, che porta in atto la vista, la quale è sì una nostra facoltà propria e intrinseca, ma sarebbe inerte, mera possibilità, senza il chiarore che le viene incontro e la desta.
Dunque la verità è la luce? No, direbbe Cusano dopo averlo affermato, essa non è più luce che tenebra. Allora è luce e tenebra insieme? Cusano negherebbe ancora. Non è né luce, né tenebra, né tutte e due? Nemmeno ciò, ci risponderebbe. Forse che la verità è ineffabile, impensabile, inesprimibile? No. Allora al contrario è conoscibile e dicibile? Nemmeno questo.
E così, spiazzando ogni attesa possibile, il grande filosofo del Quattrocento ci condurrebbe socraticamente a quella buona confusione in cui si sgretolano le certezze dalla dubbia origine che caratterizzano il nostro comune pensiero; scrostate le nostre domande dei presupposti e dei pregiudizi con cui le avanziamo, ripulite degli impliciti, restiamo per un buon momento nella sana confusione che ci fa riconoscere noi stessi per quel che siamo: ignoranti, e per ciò stesso bisognosi di sapienza; vuoti, e per ciò stesso capaci di essere ricolmati; assetati e dunque testimoni viventi del nostro complemento: l’acqua viva di cui non potremmo avere il desiderio se non ne presentissimo la realtà. E non si tratta di giochi di parole, di semplici tecniche per aprire la mente, bensì di un modo di condurre l’interlocutore davvero alla risposta, lungo il cammino della dereificazione.
Sia al tempo di Cusano, di Platone, di Adamo ed Eva dopo la scelta del peccato, sia massimamente oggi, il pensiero umano è tentato da una doppia inerzia: 1) intendere la configurazione della realtà secondo la dicotomia soggetto-oggetto, 2) appiattirla alla dimensione di ciò che si conosce coi sensi, compresi tutti i loro prolungamenti artificiali, e con la mente strumentale. Vale a dire in fondo che non si riesce a decentrare la conoscenza dall’immediatezza dell’io, percepito sì anche come strumento, ma soprattutto come fonte di conoscenza; in secondo luogo, che ci abituiamo a chiamare realtà solo l’ambito delle cose (o dei fenomeni che ci sforziamo di spiegare ricorrendo a cose e al loro movimento, o di ciò che sfuggendocene ora la natura, presumiamo con fede più o meno cieca che riusciremo un giorno a spiegarci, nuovamente in termini reificati). Dicotomia e riduzionismo dunque sono il letto di Procuste a cui l’orgoglio e la frenesia d’indipendenza incatenano l’uomo che disprezza l’unità e la trascendenza come scaturigine di comunione e immanenza.
Rispetto a questo stato di cose, su cui si basa tutta la dominanza scientifica che il nostro tempo subisce, ogni bambino prima dei tre anni (proprio quando la sua attività di conoscenza del mondo è attiva al massimo grado) è istintivamente sapiente, perché totalmente decentrato da un io che ancora non lo affligge con la sua tirannia. Non per nulla Gesù ci ammonisce a ritornare come bambini, se vogliamo entrare nel Regno dei Cieli.
Non solo il bambino apprende proprio perché libero dal fardello dell’io, ma anche si stupisce di tutto ciò che man mano individua e che anzi fa emergere da un’unità meravigliosa che continua a palpitare viva e presente negli oggetti primigeniamente identificati. Egli conosce nella meraviglia, cioè secondo la duplice dimensione del visibile che si schiude nel cuore dell’invisibile che lo sostiene. Questa è la dimensione del meraviglioso (che, per inciso, noi oggi ci affrettiamo a rigettare nel piano manipolabile del fantastico) da cui, nell’età adulta, germina la ricerca filosofica, l’amore maturo per la verità, come appassionatamente dice Platone. E ancora ci viene incontro la parola di Gesù quando dice: “Ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli”[1]. O, come dice Pareyson: “Il filosofo è il ‘dotto’ che, lungi dall’ammantarsi nella sua ‘boria’, non fa se non recuperare con le parole e col pensiero ciò che l’uomo più semplice sa già e che l’uomo comune può dire solo con la vita, dimostrando con opportuna evidenza ciò che Pascal ha profondamente enunciato e proposito delle ‘scienze che hanno due estremi che si toccano’, nel senso che ‘le grandi anime, avendo percorso tutto lo scibile’, ritornano dottamente a quell’ignoranza gravida di sapere donde erano partite”[2].
Data questa premessa, veniamo allo svolgimento del tema di cui ci è stata data la collocazione: tra Cusano e Pareyson, e che io ho voluto individuare in quello che mi pare essenziale: la Verità.
La domanda sulla verità non è mai esaurita né è esauribile, anche quando si cerca di escluderla dal nostro orizzonte; eppure non è facile parlarne, per quel suo carattere evanescente che la rende inafferrabile proprio quando ci si concentra su di essa. Tuttavia permane quale esigenza ineludibile in qualsivoglia discorso, anche del più scettico e relativista. Parlare per essere creduti, parlare con convinzione, ma anche parlare per ingannare o addirittura per abbrutirsi in un mare di sciocchezze, sempre presuppone il riferimento alla verità. Come sinteticamente attestato nel famoso paradosso del mentitore che dice: “Io mento sempre”.
La verità ce l’aspettiamo quanto meno nei rapporti personali, vale a dire che necessitiamo di sincerità, affidabilità; vogliamo che 1) ci si dica la verità per 2) poter riporre fiducia e 3) non essere giocati nel proprio mettersi in gioco.
Da quest’esigenza tutta pratica e spontanea discende un primo criterio di verità, di tipo soggettivo: la coerenza tra pensiero parola e azione.
Qui la verità coincide con la sincerità, ma questo spostamento soggettivo non rimuove il principio: perché infatti apprezziamo, esigiamo sincerità? Solo per l’utile? O non piuttosto per un’istintiva adesione alla positività come preferibile e opposta alla negatività? Perché sentiamo che la positività è affine all’essere e la sua negazione ce lo allontana. Sincerità rinvia perciò a verità. Ma ne ricaviamo anche un’osservazione che ritroveremo in seguito: la verità ha un aspetto pratico, oltre che teorico.
Un secondo criterio di verità è la classica corrispondenza tra l’affermazione (o giudizio) e il dato di realtà.
Questo sembra il criterio più ovvio, ed è anche proprio della nostra scienza: è vero quel che si constata essere vero. Si tratta di una tautologia che assume la realtà empirica (detta anche oggettiva) come criterio, metro e riferimento. Essa pare inoppugnabile, ma invece sorgono diverse questioni, che possiamo raggruppare così:
1) definire la realtà, su cui ora si sposta il problema della verità;
2) la realtà oggettiva purtroppo si rivela solo attraverso quella soggettiva (questione che già dall’antichità mina la certezza del giudizio richiesto dalla scienza. Anche in epoca moderna, con la critica interna all’empirismo appena affermatosi nel Settecento, la risorgenza antiscientista dell’empiriocriticismo nell’Ottocento, e la sequela di smottamenti seguiti alla smobilitazione della fisica newtoniana nel Novecento, la scienza non ha mai finito di cercare i suoi fondamenti, con buona pace dello scientismo tutt’ora imperante, che volgarmente ignora la questione, forte della sua egemonia ideologica).
Ma proseguiamo, accennando ai dubbi più semplici da esporre: l’oggettività che ricaviamo non passa solo attraverso i sensi, ma anche per la mente: come questa e quelli interagiscono? La mente accoglie quello che sta fuori di essa, come? Oppure riconosce all’esterno ciò che già conteneva? La realtà esterna è allora una costruzione mentale? O il frutto di un accordo tra menti, visto che tutti riconosciamo più o meno le stesse cose, una specie di convenzione?
Insomma, la pretesa di verità della scienza si fa sempre più problematica, specie alla luce delle dimensioni massime e minime che trascendono e sovvertono le condizioni di stabilità e uniformità sia dei fenomeni, sia delle nostre percezioni, al punto che spazio e tempo perdono le loro caratteristiche classiche e si contraggono in un’unica realtà elastica e bifronte, così che fenomeni simultanei avvengono in particelle divise e separate da migliaia di chilometri, senza che possiamo spiegare come avvenga la comunicazione … Vi sono scienziati che rinunciano del tutto al classico criterio di oggettività e universalità di una conoscenza necessaria, pensiamo al “Tutto va bene “ di Feyerabend.
Tutto questo dà luogo a interpretazioni filosofiche di vario tipo, che riassumerei secondo due direzioni fondamentali:
- 1)la spirituale, che scorge nella dimensione materiale una radice immateriale; che vede, nell’immensità e insondabile varietà cosmica, e poi in ogni aspetto naturale, nel massimo come nel minimo, vede la manifestazione di una Potenza che sempre la trascende, e su tale Potenza non cessa di interrogarsi;
- 2)la relativistica, che per così dire azzera la domanda sulle cause, limitandosi ad accreditare l’instabilità del reale e dei punti di vista su di esso, rinunciando a un criterio di giudizio ultimo, ed accettandoli - almeno in via teorica - tutti come egualmente validi, proprio perché validi solo soggettivamente.
Mi sono dilungata su queste premesse per sgombrare il campo a una trattazione decisamente metafisica della verità; metafisica, cioè che accoglie la complessità e l’irriducibilità della domanda, tale da scavalcare sempre daccapo ogni barriera storica di errore e di ideologia, e da riproporsi perennemente sorgiva nel cuore dell’uomo di ogni tempo ed età. Domanda che richiede, secondo ogni tradizione, intelletto vigile, cuore fiducioso, atteggiamento coraggioso.
Purtroppo le teorie deboli sulla verità (molto di moda dalla metà del ‘900) hanno adottato il modello del contratto, cioè dell’accordo tra contraenti, come se la verità fosse pattuibile, con un atto molto grave di rinuncia alla razionalità, cioè la capacità del soggetto a capire in proprio secondo l’universale, che tra l’altro è l’unica condizione per la realizzazione di autentico dialogo.
Ma se la ragione rinuncia ad orientarsi al vero, resta di più in più invischiata nelle mediocri ragioni dell’io e della contingenza. Il risultato non può che essere lo scadimento morale. La morale non può che avere la sua radice nella verità, che la ragione si sforza di portare alla luce. La ragione non è fondativa né dell’una né dell’altra, ma ne dispiega e illumina il legame e l’articolazione.
Altrimenti assistiamo a una ragione che, svincolatasi, demolisce i suoi riferimenti (vero e buono), per affermare di volta in volta ciò che si impone nei fatti, una ragione che si asservisce alla mutevole prassi e che rinuncia al suo più alto compito, quello di vigilare criticamente sui fenomeni, segnalandone eventuali storture, mistificazioni e scorrettezze, ma anche la bellezza e il bene che viene dalla loro conformità alla verità.
Questa è una critica molto seria che Pareyson muove al pensiero ideologico, oggi così dispiegato da promuovere anche in alcune menti, pur non corrotte, la rinuncia, se non proprio il rifiuto, della filosofia. Egli dice: “Il pensiero e la libertà dell’uomo scadono alla neutralità d’una ragione puramente strumentale o d’una mera tecnica del comportamento se non attingono vigore dalla loro originaria radicazione ontologica”[3].
Ma veniamo a una terza posizione riguardo la verità, posizione né soggettiva, né oggettiva, né trascendente, né immanente, né teorica né pratica, né una né molteplice, ma tutto questo insieme, e tuttavia senza ambiguità. Perché il tema così generico assegnatomi, tra Cusano e Pareyson, lo interpreto come esemplare riflessione, sempre viva, dell’Occidente in merito alla verità, scevra da riduzionismi, totalitarismi e scetticismi, la riflessione che attiene alla nostra cultura e che, essa davvero, merita di esporsi al dialogo, o, meglio mi parrebbe dire, continuare il colloquio che le è connaturale nelle sedi interculturali del nostro tempo.
Mi pare che la difficoltà fondamentale risieda nell’uso, ormai da secoli dominante, di una ragione mutilata, spogliata delle sue facoltà di com-prensione, ridotta alla pura funzione strumentale. Il che riguarda purtroppo tanto la filosofia, cioè le sfere più altamente consapevoli del pensiero, quanto il senso comune: l’uomo comune ha rinunciato all’accoglimento dei tesori della tradizione, all’elaborazione dell’esperienza personale, alla sintesi dei diversi piani di realtà cui necessariamente conduce la vita stessa, per consegnarsi al modello dei pensieri specifici, funzionali a settori tra loro irrelati, un pensiero incapace di cogliere l’unità dei fenomeni esterni ed interni, e perciò povero e banale. Un pensiero generalmente inautentico, correlato di un modo di vivere altrettanto inautentico.
Più che mai è necessario oggi parlare di verità, ripristinare il senso proprio della filosofia, ma per farlo occorre uno sforzo maggiore di cattura della sapienza così pervicacemente rimossa, occorre disporsi interiormente a muoversi con un pensiero non rigido, non unilaterale, non oppositivo, ma fiducioso, inclusivo, capace di tenere insieme simultaneamente le due prospettive: orizzontale e verticale; così come gli apparenti paradossi di Cusano ci suggerivano, oppure, secondo la metafora suggerita da Bateson, della visione binoculare, che ci consente di cogliere la profondità dello spazio e la tridimensionalità degli oggetti a partire dai differenti punti di vista dei due occhi, i quali insieme concorrono a una giusta percezione visiva.
Ma che tipo di conoscenza è quella della verità? È una conoscenza che si sviluppa tra opposti, perché unisce in sé il piano verticale d’immanente e trascendente, visibile e invisibile, e quello orizzontale di soggetto e oggetto. Non basta: è una conoscenza che va percepita, è un vedere che è tutt’uno col sentire, è un’intelligenza a cui si dischiude non solo la mente intellettiva, ma tutto il nostro essere: è l’intelligenza del cuore.
Proverò a mostrare queste affermazioni attraverso i nostri due Autori, articolando il tema secondo tre questioni:
1) la verità non è conoscibile come un oggetto, o una somma di dati, che sia poi in quanto tale fruibile e trasmissibile, pur essendo concreta;
2) la verità non è colta con uno sforzo di astrazione al di là delle forme della realtà, ma in esse si rivela, Pareyson dice inesauribilmente, pur essendo una;
3) la verità non può prescindere dal soggetto, meglio dalla persona, a cui si dischiude, pur essendo universale.
Prima questione. La verità non è oggettivabile
Cusano ci dice: “Tutta la nostra intelligenza … consiste nella partecipazione all’attualità divina in una varietà potenziale. Poter intender in atto la verità stessa così come è conviene alle menti create, come conviene al nostro Dio che il suo atto sia diversamente partecipato in potenza nelle menti create. Quanto più l’intelligenza è simile a Dio, tanto più la sua potenza è prossima all’atto così come è”[4]. Continua dicendo che la verità non è inaccessibile, ma inattingibile così com’è, similmente al tempo che tende all’eterno senza mai identificarsi con esso.
L’idea di Cusano è quella di partecipazione (la metessi platonica), per cui c’è infinita somiglianza o meglio analogia tra il pensiero che anela alla verità e la Verità in se stessa, pure quest’ultima non si fa afferrare, benché incessantemente si riveli in gradi differenti nel pensiero che la cerca e l’esprime, vedremo, attraverso le sue congetture.
Pareyson dice: “Per un verso … se la verità non si offre se non all’interno di una prospettiva personale che già la interpreta e la determina, è impossibile un raffronto tra la verità in sé e la formulazione che se ne dà: per noi la verità è inseparabile dall’interpretazione personale che ne diamo non meno di quanto noi stessi siamo inseparabili dalla prospettiva in cui la cogliamo: noi non possiamo uscire dal nostro punto di vista per coglierla in una presunta indipendenza che valga a farne un criterio con cui misurare dall’esterno la nostra formulazione di essa. Per l’altro verso, se la verità non può essere colta che come inesauribile, essa più che oggetto e risultato è origine e impulso, e il pensiero, più che parlarne come se fosse un tutto concluso, deve contenerla e muoverne e alimentarsene, trovandovi lo slancio del proprio corso, la fonte dei propri contenuti, la misura del proprio esercizio, e nel pensiero essa risiede come una presenza tanto più attiva ed efficace quanto meno configurabile e definibile”[5].
L’idea di Pareyson è quella di interpretazione, come nell’esecuzione di un’opera d’arte o nella ricostruzione di un evento storico, “ove a tal segno l’esecuzione vuol rendere l’opera nella pienezza della sua realtà sensibile e la ricostruzione storica vuol dare l’evento qual esso realmente fu, ch’esse stesse ‘sono’ il loro oggetto, e non una copia di esso, sì che manca la possibilità del confronto fra la realtà da interpretare e l’interpretazione stessa, perché tanto l’opera per l’esecutore, quanto l’evento per lo storico non s’offrono fuor dell’interpretazione ch’essi ne danno”[6].
Ricaviamo dunque dai due Autori che la verità, lungi dall’essere un oggetto di conquista, che si renda disponibile all’uso, è piuttosto un’apertura della coscienza alla fonte, all’origine stessa del pensiero che pensa, ciò che illumina e guida il suo svolgimento.
E si badi bene che non si tratta di autoreferenzialità, ma piuttosto di un dono gratuito che investe il pensiero e lo illumina e ne alimenta l’azione e in questa si manifesta. Come la luce del sole, è accessibile, ma non è attingibile. E così come viene intimamente partecipata, può comunicarsi ad altri, ma non nella sua astrazione concettuale, bensì nell’opera (azione, pensiero) in cui si dona e che ne risplende (se si hanno gli occhi per tale luce, beninteso).
Seconda questione. La verità non è colta con uno sforzo di astrazione al di là delle forme della realtà, ma in esse si rivela, inesauribilmente, pur essendo una
Cusano, nella sua straordinaria opera gnoseologica Le congetture, parte dall’unità, presupposto di ogni distinzione e alterità, così come l’essere è presupposto di ogni dubbio. Leggiamo: “È chiaro che l’unità divina precede e complica tutto. Venendo prima di ogni molteplicità, essa è anteriore anche a ogni diversità, alterità, opposizione, ineguaglianza, divisione e a tutto ciò che va insieme alla molteplicità”.[7] Qui Cusano, che prima ha introdotto il numero come esemplare simbolico delle cose (“il numero è un principio naturale, germinante, dell’edificio razionale”[8]), chiarisce la differenza tra l’unità e i numeri che da essa conseguono: “L’unità non è né il 2, né il 3 e così via, sebbene sia tutto ciò che sono il 3, il 4 e gli altri numeri. Se le specie delle cose si distinguono come i numeri, l’unità assoluta è di nessuna specie, di nessuna forma, di nessuna figura, sebbene sia tutto in tutto”[9].
Inoltre dice: “Ogni mente che cerca e indaga esige la luce di questa unità e non c’è questione che non la presupponga”[10]. Come a dire che la mente raziocinante, che si mantenga vigile sui suoi procedimenti e presupposti, sempre può avvertire in atto la fonte che sostiene e alimenta ogni ragionamento, ogni vedere.
“La questione ‘se è’ presuppone l’entità; la questione ‘che cos’è’, la quiddità; la questione ‘perché’, la causa, e quella del ‘per qual cosa’, il fine. Ciò che si presuppone in ogni dubbio è, di necessità, l’essere certissimo. Non si può, dunque, mettere in dubbio l’unità assoluta, perché è l’entità di tutti gli enti, la quiddità di tutte le quiddità, la causa di tutte le cause e il fine di ogni fine. La molteplicità dei dubbi viene, invece, dopo di essa”[11].
Mi sono dilungata su questo impianto per attirare l’attenzione sulla compresenza ineliminabile, dalla nostra vita e intelligenza creaturale, di due livelli non disgiungibili e però non riducibili: quello del molteplice e delle innumerevoli figure in cui ci è dato il mondo, e il metalivello dell’unità in sé ineffabile che di quella molteplicità è l’inesauribile fonte, e anche l’orizzonte.
Proprio questo impianto dischiude a Cusano la felicità e la libertà del congetturare, cioè del cogliere e rappresentare in vari modi e gradi possibili la verità, attività umana per eccellenza. Una verità che si dischiude però solo se preceduta da una scienza negativa, da una radicale esperienza del limite costitutivo del dispiegarsi mondano del principio di alterità, rispetto a cui “l’unità è l’identità incomunicabile, inesplicabile e irraggiungibile così com’è”[12]. Ma pure “tale scienza negativa ti dà la precisione inattingibile della verità … Tanto grande è … la forza della semplice natura intellettuale da abbracciare tutto ciò che la ragione divide come opposto”[13]. Ecco allora preparato il campo per la giusta comprensione della conoscenza congetturale: non ipotesi debole (incerta e precaria) sulla verità, ma rappresentazione efficace con cui sempre la verità più o meno si attualizza, pur restando sempre ulteriore – direbbe Pareyson - a ogni formulazione.
Dice Cusano: “L’attualità della nostra intelligenza esiste nella partecipazione all’intelletto divino”[14]. Ma posta la sorgente viva e inesauribile del nostro essere e capire, ci dice per converso che “questa forza attualissima non può essere ricevuta che nella varietà dell’alterità”[15]. Ne consegue che ogni conoscenza è sì congetturale, in quanto non attinge alla sorgente (“Vedi, ora, che le affermazioni positive dei dotti non sono che congetture”[16]), ma pure ne è costantemente alimentata, per cui “la congettura è … una asserzione positiva che partecipa, nell’alterità, della verità così come è”[17].
Ora veniamo a Pareyson, il quale muovendo da un’angolatura di tipo esistenziale, pur senza sminuire l’aspetto metafisico, accentua maggiormente l’aspetto esperienziale. Ciò lo porta a ribadire con forza l’indissolubilità del rivelarsi dell’essere dalle forme storiche in cui esso s’incarna, pur risultandone sempre ulteriore. Da qui l’affermazione di un’ontologia dell’inesauribile come fondamento della presenza dell’essere nelle forme storiche e queste come interpretazioni dell’essere.
Su questa base Pareyson rigetta le ontologie dell’ineffabilità e del nascondimento dell’essere, quasi che l’essere ondeggiasse al di sopra dell’esistente e insieme ne rifuggisse. “Inoltre l’essere non è presente nella storia con una determinazione sua propria, in una forma che sia riconoscibile come unica e definitiva, e che quindi serva come termine di confronto di tutte le forme storiche”[18]. Anche qui il discorso sulla verità rifugge dalle dicotomie, e dalla speculazione che, di fronte alle difficoltà del bilico su un duplice livello (una vera e propria via di mezzo), di fronte a tale difficoltà si faccia negativa, vuoi in senso misticheggiante, vuoi in senso nichilistico. La soluzione è nuovamente paradossale: “Non ci può essere presenza dell’essere che non sia storicamente configurata”[19], e qui attenzione a non appiattire semplicemente l’essere sull’esistente là dove continua: “né l’essere ha altro modo di apparire o altro luogo in cui risiedere che le forme storiche”[20]. Infatti il rischio è semplicemente l’oblio dell’essere se non ci facciamo incalzare dalla domanda sul come si dà questa presenza dell’essere nelle forme storiche. “In esse risiede - ci dice Pareyson – nella sua ‘inesauribilità’, cioè per un verso con una ‘presenza’ che fa di esse l’unico suo modo di apparire, e per l’altro verso con l’ulteriorità che non permette a nessuna di esse di contenerlo in modo esclusivo; vi risiede insomma in modo ch’esso da un lato si consegna alle forme capaci di rivelarlo al punto da esserne inseparabile, e dall’altro lato non si risolve mai in una forma storica, pur nell’atto di consegnarlesi … L’essere risiede nelle forme storiche con una presenza sempre ulteriore, in tutta l’incontenibile forza della sua inesauribilità“[21].
Insomma, non si può distinguere in una configurazione storica ciò che è rivelazione e ciò che è temporale, perché le due dimensioni coesistono, vorrei dire, l’una per l’altra, così come l’esecuzione di un’opera musicale è tutt’uno con l’opera che in essa si rivela, per quanto senza in quella esaurirsi.
Anzi, nel concetto di interpretazione, dice Pareyson, “si attua la solidarietà originaria dell’uomo con la verità. Anche l’interpretazione è al tempo stesso rivelativa e storica … Anche l’interpretazione della verità è il possesso di un infinito: la verità si offre solo all’interno della formulazione che se ne dà, ed è inseparabile da essa … e quella formulazione, pur non monopolizzando la verità, che come inesauribile, è in grado di suscitare infinite altre formulazioni, ‘è la verità stessa’ come personalmente posseduta, e non altro da essa, o una sua immagine o deformazione o sostituzione”[22].
Pareyson poi sottolinea con cura che proprio il fatto che l’interpretazione nasca come “rivelativa e plurale insieme”[23], per ciò stesso si sottrae all’accusa di relativismo, perché la verità non è l’oggetto di una convinzione, ma è la fonte dell’interpretazione che la rivela senza mai esaurirla. Il rimando ad altre interpretazioni, cioè, “lungi dal disperdere la verità in un serie di formulazioni indifferenti, la svela piuttosto nella sua inesauribile ricchezza”[24]. Come a dire che la singolarità irriducibile di ogni manifestazione, non porta nella direzione dell’indifferenza, bensì in quella opposta di una meravigliosa sovrabbondanza. “L’eliminazione definitiva del relativismo è possibile non appena si colga la natura al tempo stesso rivelativa e plurale dell’interpretazione, … si comprenda … come … l’aspetto rivelativo sia inseparabile dall’aspetto storico … Per un verso la verità s’identifica con la sua formulazione sì da permetterle di possederla in modo rivelativo, ma non al punto da autorizzarla a presentarsi come esclusiva e completa, anzi unica e definitiva, che in tal caso non sarebbe più interpretazione, ma surrogazione della verità, cioè una delle tante formulazioni storiche che pretende di assolutizzarsi e di mettersi al posto della verità. Per l’altro verso la verità è sempre ulteriore rispetto alla sua formulazione, e non nel senso di una sua assoluta ineffabilità, di fronte alla quale tutte le formulazioni resterebbero fatalmente inadeguate e irrimediabilmente insignificanti, in una comune e rassegnata equivalenza e indifferenza, come appunto vorrebbe il relativismo, non lasciando altra via d’uscita che una scelta arbitraria e prassistica”[25].
Terza questione. La verità non può prescindere dal soggetto,
meglio dalla persona, a cui si dischiude, pur essendo universale
Nel caso di Cusano e di tutti coloro che muovono lo sguardo sulla verità a partire dalla fede, è ovvio il coinvolgimento personale che fa dell’aspirazione a conoscere tutt’uno con la scelta pratica e con la consapevolezza dell’indirizzo che si vuol dare alla propria vita.
“Tutti i nostri predecessori sono d’accordo nell’affermare che la fede è l’inizio della conoscenza intellettuale. In ogni facoltà dobbiamo presupporre, infatti, alcuni principi primi, appresi solo con la fede, dai quali si ricava l’intelligenza di ciò che si discute. Chi desidera elevarsi al sapere, deve credere in queste verità senza le quali non può procedere. Disse infatti Isaia: ‘se non crederete, non comprenderete’. La fede complica in sé ogni intelligibile. L’intelletto è l’esplicazione della fede”[26].
Fin qui possiamo pensare che sia tutto chiaro e forse liquidabile. Del resto abbiamo appreso dall’Illuminismo una totale autonomia della ragione conoscitiva dalla sfera morale con cui rassicuriamo la nostra libertà e semmai riteniamo di vigilare su un male della conoscenza che viene dopo, in sue applicazioni scorrette, ma, riteniamo, il sapere come tale va difeso nella sua indipendenza. Ma è poi davvero così? Il sapere e la ragione muovono davvero da se stessi e danno a se stessi la norma e il fine?
Tante obiezioni - abbiamo già accennato all’inizio - confutano tali pretese, che pur tuttavia restano dominanti. Tali obiezioni riconducono tutte, in un modo o nell’altro, ai presupposti più o meno impliciti nell’atto conoscitivo. Per farla breve, ogni conoscenza (teorica o esperienziale che si voglia) avviene all’interno di un quadro di attese preesistente, il quale è fatto di un tessuto di pre-nozioni, pre-giudizi, strutture psicologiche eccetera. Dunque non è mai libera nel senso di indipendente, non avviene cioè nel vuoto di una tabula rasa. A questo punto, l’appello alla fede dei religiosi, come inizio della conoscenza, più che un atto retrivo, appare come un’accettazione consapevole e, a questo punto sì, liberamente accettata e orientata di una precondizione inevitabile.
Al contrario, vengono i brividi al pensiero di un’intera civiltà consegnata nelle mani dissennate di adulti-adolescenti ignari e indifferenti alle premesse nascoste che ne guidano azioni e pensieri, con i quali si organizzano colossali macchine sociali.
Ma per venire alla nostra questione, dobbiamo osservare che la difficoltà a stabilire un punto di inizio o, il che è lo stesso, una netta distinzione tra il soggetto e l’oggetto che sempre si precondizionano vicendevolmente, tale difficoltà ci incoraggia a cambiare la nostra visione della realtà banalmente rettilinea e oppositiva, in una circolare e implicativa. Vale a dire che siamo sempre coinvolti in processi di condizionamento reciproco, per lo più inconsapevoli, sempre soggetti e oggetti d’interazioni incessanti ai più svariati livelli. Siamo perciò partecipi della realtà al di là di ogni nostra intenzione, come ogni altro essere. Ma ulteriormente a ciò, noi uomini siamo capaci di consapevolezza, e dunque possiamo in misura variabile renderci conto del tessuto di condizioni di cui siamo parte. È a questo punto che entra in gioco la facoltà che tanto apprezziamo: la libertà.
La libertà di cogliere creativamente nelle condizioni date altrettante occasioni; la libertà di orientare la nostra volontà oltre e diversamente dalla spinta ‘meccanica’ degli eventi esterni ed interni. Solo da qui si inizia a realizzare l’umanità che è in noi, e solo da qui può iniziare una ricerca di verità. Dopo, come appunto dice Cusano, aver fatto scienza della nostra ignoranza.
Dunque, un circolo dinamico include morale e sapere, prassi e teoria, né si può negare un termine senza ledere il suo correlato, senza ridurre la persona che ne è la sintesi.
Sul concetto di persona insiste molto Pareyson facendone il centro dell’attività interpretativa (Cusano direbbe congetturale) con cui in forme sempre varie continuamente si rinnova il rivelarsi della verità nel tempo. Ma “ciò dipende dal modo con cui l’uomo liberamente … prospetta la propria situazione. Egli può prospettarla come collocazione soltanto storica o come collocazione anzitutto metafisica, come semplice confine dell’esistenza o come apertura all’essere, come limitazione inevitabile e fatale o come via d’accesso alla verità: da quest’alternativa deriva alla persona la possibilità di ridursi a mero prodotto storico o farsi prospettiva vivente sulla verità, e al pensiero la possibilità d’essere una semplice espressione del tempo o una rivelazione personale del vero”[27].
Tutto dipende insomma, non dal grado d’istruzione, dalla fortuna delle condizioni, dalla quantità di talenti in dotazione, ma dalla scelta di una vita autentica o inautentica, scelta che si compie esclusivamente nell’interiorità della persona.
Quanto all’interpretazione, essa è, secondo Pareyson, l’unica conoscenza adeguata della verità, “intesa come forma di conoscenza storica e personale, in cui la singola personalità e la situazione storica, lungi dall’essere impedimento o anche soltanto limite del conoscere, ne sono la sola condizione possibile e l’unico organo adatto”[28].
Insomma, interpretativo è il carattere originario di ogni relazione umana: dice Pareyson che l’interpretazione “qualifica quel rapporto con l’essere in cui risiede l’essere stesso dell’uomo; in essa si attua la primigenia solidarietà dell’uomo con la verità”[29].
Quell’essere dell’uomo ‘apertura all’essere’ è originariamente anche rivelazione dell’essere nell’uomo, essere che nel pensiero è inteso come verità. È come dire che la verità si manifesta in quella persona e che quella persona la interpreta. Dice Pareyson: “… della verità non c’è che interpretazione e … non c’è interpretazione che della verità. Nell’interpretazione l’originalità che deriva dalla novità della persona e del tempo e l’originarietà che proviene dal primitivo rapporto ontologico sono indivisibili e coessenziali. L’interpretazione è quella forma di conoscenza ch’è insieme e inseparabilmente veritativa e storica, ontologica e personale, rivelativa ed espressiva”[30].
Ne derivano una conseguenza e una condizione.
La conseguenza è la pluralità delle interpretazioni che “lungi dall’essere un difetto o uno svantaggio, è il segno più sicuro della ricchezza del pensiero umano … il regno dell’interpretabile si basa sull’impossibilità d’una conoscenza univoca e diretta in cui tutti si troverebbero d’accordo senza contestazione e senza dialogo; presuppone piuttosto che non c’è altra forma di conoscenza genuina che l’interpretazione, la quale è di per sé storica e personale e quindi costitutivamente molteplice e non definitiva … [perché] … la verità è accessibile e attingibile in molti modi, e nessuno di questi … [ può pretendere] … di possedere la verità in maniera esclusiva”[31].
La condizione che ne deriva e s’impone è la vigilanza della persona a impedire che personalità e storicità prendano il sopravvento sull’interpretazione, senza peraltro spersonalizzarsi, “ma proprio per raggiungere questo scopo bisogna approfondire la situazione storica e orientare la sostanza della persona al punto di farne un apparato di sintonizzazione e un organo di penetrazione della verità”[32].
Quanto all’azione nella storia, specie quella politica, dice Pareyson: “Ciò che è necessario non è l’impegno ideologico, ma l’impegno morale, sia che si tratti di un impegno etico-religioso, sia che si tratti di un impegno etico-politico … [a cui non]… è necessaria l’ideologia: ciò che è necessario … è la verità, non le ‘idee’, il pensiero rivelativo e ontologico, non il pensiero tecnico e strumentale, la testimonianza dell’essere, non la familiarità con gli enti”[33].
Ma attenzione che non stiamo parlando solo per i filosofi. “Se la filosofia non è che la traduzione ‘verbale’ e ‘speculativa’ del pensiero rivelativo e ontologico, il compito è di rivendicare il carattere rivelativo e ontologico che ogni attività umana, anche l’azione pratica, può avere di per sé. Si tratta, in fondo, di operare quella rivendicazione non ‘buonsensistica’ e non semplicistica, bensì ampiamente umana, del senso comune … giacché il pensiero rivelativo e ontologico è alla portata di tutti, anche se non nella sua formulazione filosofica, ma ciò che è estremamente difficile è restarvi fedeli e non disperderlo nell’oblio dell’essere e nella tecnicizzazione del pensiero: l’uomo si trova di fronte a un’alternativa per cui o tutto si riduce a tecnica, anche la filosofia, o tutto ha una portata rivelativa, anche l’azione pratica”[34].
[1] Mt, 11, 25
[2] Luigi Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1972, p. 140
[3] Luigi Pareyson, op. cit., p. 43
[4] Nicola Cusano, Le congetture, in Opere Filosofiche, a cura di Graziella Federici Vescovini, Utet, Torino 1972, p. 233
[5] Luigi Pareyson, op. cit. p. 25
[6] Ibidem, p. 25
[7] Nicola Cusano, op. cit. p. 213
[8] Ibidem, p. 209
[9] Ibidem, p. 213
[10] Ibidem, p. 214
[11] Ibidem, pp. 214-215
[12] Ibidem, p. 232
[13] Ibidem, pp. 230-231
[14] Ibidem, p. 233
[15] Ibidem, p.233
[16] Ibidem, p. 234
[17] Ibidem, p. 234
[18] Luigi Pareyson, op. cit. p. 43
[19] Ibidem, p. 43
[20] Ibidem, p. 43
[21] Ibidem, pp. 43-44
[22] Ibidem, pp. 44-45
[23] Ibidem, p. 45
[24] Ibidem, p. 45
[25] Ibidem, pp. 45-46
[26] Nicola Cusano, La dotta ignoranza, in Opere Filosofiche, a cura di Graziella Federici Vescovini, Utet, Torino 1972, p. 190
[27] Luigi Pareyson, op. cit. p. 17
[28] Ibidem, p. 54
[29] Ibidem, p. 53
[30] Ibidem, p. 53
[31] Ibidem, p. 57
[32] Ibidem, p. 58
[33]Ibidem, p. 174
[34] Ibidem, p. 185