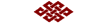Parallelamente alla pubblicazione dell’Opera Omnia, prosegue da parte di Jaca Book – a cura di Milena Carrara Pavan - l’edizione di testi di Raimon Panikkar di minore dimensione, che gettano luce su contesti specifici da lui frequentati, per lo più in dialogo con vari esponenti della cultura contemporanea. È il caso di Parliamo degli stessi mondi? Visione orientale e occidentale a confronto, dove l’interlocutore è il poeta e scrittore messicano Octavio Paz, premio Nobel per la letteratura. Il contesto che consente a quest’ultimo di dialogare con Panikkar è dato dal fatto di essere stato tra il 1962 e il 1968 ambasciatore del Messico in India, dove ebbe occasione di incontrare profondamente la cultura indiana, oltre che conoscere Panikkar e diventarne amico.
In modo non certo sistematico, ma attraverso intuizioni penetranti, vengono esplorati alcuni aspetti dell’incontro di due mondi, l’Oriente e l’Occidente, ciascuno dei quali, attraverso l’altro, comprende più profondamente se stesso.
Il testo è composto di due parti, più una terza che raccoglie lo scambio epistolare tra i due.
La prima è la trascrizione di un confronto avvenuto alla televisione messicana nel 1982.
Parlando di Oriente, i due interlocutore devono innanzitutto chiarirsi. L’Islam ad esempio non lo è in senso proprio, e poi c’è ancora una differenza tra l’India e l’Estremo Oriente, cioè la Cina, il Giappone, la Corea. L’India è molto più vicina all’Occidente di quanto non si immagini. Afferma Octavio Paz:
Io dico che l’Occidente e l’India sono due versioni della stessa civiltà; hanno la stessa origine, ma con una grande differenza: in India troviamo l’antichità dell’Occidente, l’antichità ariana o indo-ariana.
Tra i passaggi significativi, a un certo punto a Panikkar viene chiesto di commentare l’affermazione sua più celebre, in cui, riferendosi al lungo soggiorno in India, dice: “Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindū, sono tornato buddhista, senza tuttavia smettere di essere cristiano”. Così risponde Panikkar:
… credo sia necessario superare questo modo di pensare, cioè … questo esclusivismo secondo il quale se uno è una cosa non può esserne un’altra, quasi che la realtà si lasciasse costringere in questi dipartimenti e scompartimenti che si escludono mutuamente.
Ciò offre lo spunto per una digressione filosofica. L’Occidente è legato al predominio del principio di non contraddizione, mentre l’Oriente sembra più vicino al modo di percepire le cose tipico della poesia. Dice Octavio Paz:
La poesia è soprattutto immagine, e nell’immagine poetica questo e quello, il sì e il no si incontrano. Così che, quando cominciai a fare delle letture sul pensiero tradizionale dell’India e anche del cinese, mi resi conto che esisteva una indubbia relazione tra questo tipo di approccio alla realtà e l’approccio poetico. Lo avevano visto in modo ammirabile i poeti dell’Occidente, i mistici e anche certamente i poeti romantici tedeschi, inglesi, francesi e così via.
Infine si dibatte a lungo sulla questione delle caste. Osserva Octavio Paz:
Non voglio indagare sul perché in India vi siano le caste. In India ci sono le caste perché ci sono disparità e pluralità sociali. Perché assumono questa forma? Prendono questa forma perché il pensiero indiano vede nella natura fisica – nella natura che vediamo con gli occhi – un modello immutabile.
Panikkar obietta che non è tanto il fatto che l’indiano tradizionale veda nella natura un modello, ma che “si sente parte di questa stessa natura”. Octavio Paz allora a sua volta obietta che ciò può valere per altri popoli non occidentali, come i cinesi o gli indios americani, ma poi lui stesso trova una differenza significativa:
In Cina c’era omogeneità razziale e linguistica: in India invece lo Stato è debole e la società forte, ma non è una società omogenea, è una società pluralistica, una società gerarchica, una società con alti e bassi più rilevanti, per cui la razionalizzazione di questa situazione è la casta.
La seconda parte del libro trae spunto da una composizione poetica di Octavio Paz, Vrindaban, che riprende il nome di una località indiana particolarmente sacra a Kṛṣṇa. Il testo rappresenta un’esperienza dell’autore nella quale la concezione lineare del tempo tipica dell’Occidente lascia il posto a quella circolare, che è propria dell’India e in genere dei mondi tradizionali.
Ciò fornisce il pretesto a Panikkar per una delle sue più vertiginose riflessioni sul tempo circolare.
La circolarità del tempo rappresenta, in primo luogo, che nella vita di ogni essere temporale non vi sono momenti ontologici o temporalmente privilegiati. Non v’è, cioè, progresso, cioè avanzamento lineare verso una fine. (…) ogni momento è aperto in egual misura alla trascendenza e ogni momento ha la stessa carica di immanenza. (…) l’eternità non è, secondo questa vivenza, né un più oltre né un futuro assoluto, né una continuazione indefinita, né un presente perenne; l’eternità è talmente trascendente da non essere. Non c’è un «più oltre». Significa non aver compreso che cosa significhi la circolarità del tempo immaginare che, essendo il tempo circolare, siamo noi quelli che “ritorniamo” a passare per lo stesso punto del ciclo. La circolarità del tempo sta proprio a indicare che dal punto di vista temporale il «secondo» momento è assolutamente identico al «primo», che cioè un tale «secondo» momento non esiste. Se ci fosse una qualche differenza , il tempo non sarebbe ciclico. Non c’è modo per differenziare i due momenti. A rigore, essi non sono due. L’esperienza che non sono due rappresenta la liberazione, l’illuminazione, l’essere cioè usciti dal tempo.