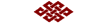Lo studio della storia del passato può dare l’illusione che gli eventi si dispongano secondo un ordine chiaramente dato, e può stupire che chi li vive non ne abbia un’adeguata comprensione: che vi si dibatta anche tragicamente, e compia errori che, col senno di poi, appaiono imperdonabili. Di illusione però si tratta, perché quell’ordine è in realtà opera degli storici, i quali non fanno che trarre le conseguenze di come le cose sono andate, delle forze che hanno finito per prevalere imponendo la loro interpretazione. Tant’è vero che generalmente la storia la scrivono i vincitori, con tutto ciò che vi è implicato.
Lo studio della storia del passato può dare l’illusione che gli eventi si dispongano secondo un ordine chiaramente dato, e può stupire che chi li vive non ne abbia un’adeguata comprensione: che vi si dibatta anche tragicamente, e compia errori che, col senno di poi, appaiono imperdonabili. Di illusione però si tratta, perché quell’ordine è in realtà opera degli storici, i quali non fanno che trarre le conseguenze di come le cose sono andate, delle forze che hanno finito per prevalere imponendo la loro interpretazione. Tant’è vero che generalmente la storia la scrivono i vincitori, con tutto ciò che vi è implicato.
Tutt’altra cosa è comprendere gli eventi mentre accadono. Si tratta di mettersi in rapporto con un ordine non meno rigoroso, ma che si contribuisce a determinare. In questo caso infatti l’interpretazione che si dà alle cose concorre a cambiarle, facendo sì che si realizzino certe possibilità anziché altre.
Il che induce a porre un problema di incalcolabile importanza. Al di là della sfera dei conflitti di potere che sono tipici dell’ambito storico-politico, è lecito pensare che quest’ultimo venga sollecitato anche da moventi di livello più profondo, che coinvolgono il senso e la destinazione della vita umana?
Le culture religiose risponderebbero senz’altro di sì: in ultima istanza gli uomini sono posti di fronte alla scelta tra il bene e il male, tra la salvezza e la perdizione, e ciò non riguarda solo gli individui ma anche le collettività. Le moderne ideologie laiche paiono dire altrettanto. C’è una direzione che conduce alla giustizia, alla concordia, e una alla sopraffazione e all’iniquità.
Senza presupporre convinzioni di questo genere profondamente radicate in noi, non potremmo neppure discutere su cosa sia bene per la collettività in cui viviamo o per l’umanità intera: tutto si ridurrebbe alla constatazione di rapporti forza, indifferenti alla sorte di ciascuno, che meccanicamente regolano i rapporti. Neppure avvertiremmo quello che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti avvertiamo: che la vita sulla Terra è in pericolo, che le immani forze suscitate possono volgersi distruttivamente su di noi e su ogni essere vivente.
Alla luce di quest’ultima considerazione si può dire che, tra le aspirazioni umane, quella alla pace è nella nostra epoca di gran lunga la più profonda. Comprende chiaramente in sé la giustizia e traduce in un linguaggio comprensibile a chiunque le istanze di salvezza tipiche delle religioni.
La capacità di un’azione di promuovere la pace, anziché il contrario, è dunque il fondamentale criterio in base a cui deve essere giudicata.
Ma chi si assume questa consapevolezza si assume insieme inevitabilmente un impegno, di cui bisogna a questo punto indicare le caratteristiche. Cosa orienta l’azione pubblica di Interdependence? Qual è il senso di un’esperienza come quella a Torino del movimento Noi siamo con voi?
Verso una nuova nonviolenza
Occorre innanzitutto tener conto del fatto che, nella tradizione del pacifismo e della nonviolenza novecenteschi, una consapevolezza del tipo di cui parliamo si è tradotta nel principio che i mezzi devono essere coerenti con i fini: se si vuole la pace, il mezzo adeguato non può mai essere la guerra.
Ciò ridefiniva una situazione tipica del mondo moderno, ma estesa retrospettivamente a tutta la storia umana, in cui appariva chiaro che le ideologie nazionaliste avevano rivestito di nobili ideali la politica di potenza dei vari stati. La lotta guidata da Gandhi per la liberazione dal dominio coloniale inglese senza fare ricorso alle armi è così diventata il paradigma di un agire politico che, nell’epoca della Guerra Fredda, pareva tenere particolarmente conto dei gravi pericoli incombenti. Dalle manifestazioni che in America fermarono la guerra in Vietnam a quelle che contribuirono al crollo del sistema sovietico, non si può negare che quel paradigma abbia influito nella storia degli ultimi decenni, contribuendo però anche a una trasformazione delle modalità della guerra.
Quest’ultima infatti si può dire che abbia subito un processo di demitizzazione: è diventata sempre meno popolare, e di conseguenza si è fatta più subdola. Oggi, dopo le ultime prove muscolari americane in Iraq e in Afghanistan, nessuno pensa più a dispiegamenti di forze in grande stile. Oggi la guerra si fa coi servizi segreti, coi gruppi terroristi, coi media, con le manovre economiche. Il che comporta che sia molto meno chiaro chi sta realmente agendo dietro fatti più o meno cruenti. I quali vengono realizzati per ottenere certi effetti, soprattutto per spostare in una direzione o nell’altra l’opinione pubblica, in modo da esercitare pressione, destabilizzare, o all’opposto rafforzare certi equilibri.
A ben vedere, tutto ciò era ben conosciuto anche in passato, ma per lo più veniva usato in funzione ausiliaria rispetto a eventi bellici chiaramente configurati. Oggi invece la guerra in quanto tale pare per lo più ridursi a questo, col complemento di bombardamenti più o meno devastanti, droni e via dicendo, e per di più facendo balenare la minaccia delle armi nucleari. Senza trascurare operazioni militari vere e priorie come la battaglia che incombe su Aleppo e quella che si profila su Mossul; dove peraltro le sofferenze inflitte ai civili, o il loro uso come scudi umani, è parte ormai delle strategie belliche. È la “guerra mondiale a pezzi” di cui parla Papa Francesco.
Daesh è sotto questo aspetto il frutto maturo di questa evoluzione. Di cosa parliamo? Di un esercito fantomatico misteriosamente apparso in un territorio che nessuno riesce a penetrare, perché vi si affollano tutti i grovigli geopolitici del pianeta? Di un canale mediatico specializzato in performance cruente a varie latitudini? Di un brand perfettamente inserito nel lucrosissimo traffico mondiale di esseri umani?
Da tutto ciò appare chiaro che l’azione per la pace non può più limitarsi a contrastare l’uso del mezzo bellico: sia perché, come si è detto, quest’ultimo si è tanto diversificato da rendersi irriconoscibile, sia perché si rendono inaccessibili i soggetti a cui si potrebbero imputare responsabilità morali. Contro chi si protesta dopo un attentato? Contro Daesh? È del tutto evidente che chi ha armato la mano a Daesh si dissimula dietro cortine di doppi e tripli giochi che sfuggono ormai a qualsiasi controllo.
Bisogna allora andare più in profondità.
Anche perché concentrare l’attenzione sui mezzi comportava già in origine problemi concettuali di non poco conto.
In primo luogo tutta la sua efficacia si basava sul presupposto di una fondamentale condivisione dei fini e dei valori. Gandhi poteva costringere gli Inglesi a lasciare l’India sapendo che essi non avrebbero potuto permettersi di commettere apertamente orrendi crimini. È sempre stato dubbio che risultati analoghi si sarebbero ottenuti con un sistema totalitario al massimo della sua efficienza, cioè un sistema che abolisce la differenza tra l’obbedienza allo Stato e la coscienza morale. Quando non ci sia una condivisione dei fini, i mezzi diventano incontrollabili.
Un secondo problema è che, per quanto importante l’esigenza che il mezzo sia coerente con il fine, non necessariamente il mezzo garantisce il fine. Ad esempio il rifiuto di agire con le armi può non essere la migliore soluzione quando ci siano vittime inermi da proteggere. Questa è la ragione per cui la Chiesa non ha mai interamente fatta propria la dottrina della nonviolenza, pur essendone il Cristianesimo una fondamentale matrice. Ha cioè mantenuto ferma la distinzione tra mezzo e fine e la priorità del fine sul mezzo. La pace deve essere il fine; il mezzo è quello che può essere, data l’imperfezione della condizione umana segnata dal peccato.
Si tratta di problemi non risolti, e per lo più rimossi. Il risultato è che nel mondo odierno un certo riferimento ideologizzato alla nonviolenza è diventato dominante, spesso prendendo il posto dei valori morali a cui i vari Gandhi e Martin Luther King si rifacevano; ma al contempo – o di conseguenza – l’azione degli stati si è fatta più spregiudicata. Addirittura forme di lotta nonviolenta possono essere usate per destabilizzare sistemi politici parallelamente all’omicidio; ma soprattutto, come si diceva, i poteri che ufficialmente governano il mondo si deresponsabilizzano rispetto a crimini compiuti da soggetti formalmente indipendenti da essi.
Si potrebbe addirittura pensare che un’attenzione unilateralmente portata sui mezzi abbia contribuito a quell’eclissi dei fini che caratterizza la società del dominio della tecnica. Il che ovviamente è ben lontano dai propositi di coloro che su quella strada hanno impegnato la loro vita.
Gandhi, Martin Luther King, Capitini e tutti gli altri non pensavano in realtà di aver scoperto un metodo, quanto di rispondere a un’ispirazione spirituale. Essi vivevano una disciplina di vita che faceva della pace una missione, non a caso in stretto rapporto con la fede religiosa.
Bisogna allora seriamente pensare di tornare a questo, ma in forma nuova.
In particolare il fatto che i mezzi siano stati sottratti alla possibilità di controllo, ovvero non si sappia più cosa è guerra anche se ne siamo pervasi, deve indirizzarci a riconsiderare i fini.
Non a caso il grande evento degli ultimi decenni è il riaffiorare della coscienza religiosa. Data a lungo per spacciata, essa torna a essere centrale in conseguenza del riemergere di una domanda di senso. Prendendo atto dell’imponenza dei mezzi che ci sovrastano, a quale fine dobbiamo considerare indirizzata l’esistenza?
D’altra parte il ritorno del religioso coincide con una ripresa in grande stile della sua manipolazione. Non occorre spendere parole al riguardo, tanto evidente è oggi l’uso della religione per azioni cruente, o comunque in vista di affermazioni di potere. C’è un lato oscuro della religione, di cui Gandhi già a suo tempo cadde vittima, che le impedisce di essere stabilmente e univocamente il più efficace regolatore delle azioni umane, quindi il custode della pace.
Da ciò scaturisce una duplice conseguenza.
Da un lato l’impegno per la pace, in quanto si fa carico della più profonda aspirazione umana, non può che attingere al deposito della coscienza religiosa. Quanti affermano che è la religione a essere all’origine della violenza, non sanno quel che dicono. Dall’altro quell’impegno comporta una lotta senza quartiere con il lato oscuro che la religione fa talora emergere. Lo scopo è la distinzione: finché il male non è riconosciuto come tale, non ci si può difendere.
L’impegno per la pace si mostra dunque oggi come un compito di natura eminentemente spirituale. Ciò è mostrato con chiarezza dal modo in cui Papa Francesco ha fatto fronte alle gravi insidie connesse ai sanguinosi eventi di questa estate.
Guerra religiosa?
Dopo l’attentato di Rouen, egli si è affrettato a dire che quella in corso è senz’altro una guerra, ma non una guerra religiosa, perché tutte le religioni cercano la pace. La risposta da parte islamica non si è fatta attendere, e ha preso forma nell’ormai famosa domenica in cui i Musulmani si sono recati nelle principali chiese di Francia e di Italia, per testimoniare in forma ben visibile la loro inequivocabile condanna degli assassini di Padre Jacques Hamel, ribadita poi dal rifiuto di concedere loro esequie islamiche.
Si tratta di un evento, nelle sue varie articolazioni, di capitale importanza, su cui vale la pena di riflettere.
Innanzitutto bisogna prendere atto che la presa di posizione del Papa non è stata interamente condivisa in ambito cattolico.
C’è chi afferma che innegabilmente una guerra religiosa è in atto, e che i terroristi non sono che la punta avanzata del progetto islamico di egemonia mondiale. Rifiutarsi di vederlo contribuisce al suo successo, tenendo soprattutto conto che la debolezza dell’Europa discende in primo luogo dall’aver negato le sue radici spirituali.
Bisogna francamente ammettere che questa posizione ha dei punti di forza.
Innanzitutto non può essere trascurato il fatto che una guerra religiosa è stata dichiarata, e non vengono risparmiati atti intesi a ribadirla.
Non basta dire che chi agisce in questo modo non rappresenta l’Islam, o addirittura vi è del tutto estraneo. Piaccia o meno, l’Islam è ciò a cui egli si richiama, e sarebbe illegittimo negarlo. Più corretto è pensare all’interpretazione di una minoranza, senza poter però escludere a priori che diventi un giorno maggioranza.
Una guerra religiosa, in cui si chiama a combattere un nemico che è tale rispetto al senso ultimo della vita umana, è anzi un mezzo efficacissimo per ottenere il consenso e ribaltare i rapporti tra maggioranza e minoranza. Il che avviene quando quest’ultima mette la maggioranza in condizione di non potersi opporre apertamente: sia perché minacciata col terrore, sia perché ostaggio dell’appello a valori e sentimenti condivisi. Nel nostro caso, più ancora che le comuni dichiarazioni di fede, pesano vissuti antioccidentali diffusamente radicati, eredità del colonialismo e di elementi culturali insiti nell’Occidente stesso.
Rispetto a ciò, negare il contenuto religioso della guerra in corso, rassicurando sempre e comunque i Musulmani circa la loro estraneità rispetto a quel che accade, non rischia di deresponsabilizzarli rispetto a una questione così decisiva? Non è forse meglio che chi davvero considera Daesh un grave pericolo per la fede esca allo scoperto e lo combatta senza più esitazioni?
D’altra parte è anche vero che l’Occidente, e l’Europa in particolare, vivono un grave problema di identità. Avendo rifiutato le radici cristiane, hanno dato luogo a un tipo di civiltà tanto ricca e potente sul piano materiale quanto spiritualmente povera, e perciò incapace di difendersi dall’odio che è venuta suscitando.
È ben vero che la scelta dell’accoglienza e del dialogo discende in ultimo da quelle radici, ma l’inconsapevolezza di ciò espone a pericoli: come si può accogliere e dialogare se non si sa chi si è, mentre gli altri paiono saperlo così bene? Non sarà invece meglio prendere atto che è in corso un tentativo di conquista, e dare avvio a una resistenza, che deve essere innanzitutto culturale?
In questa prospettiva sarebbe importante che il contenuto religioso della guerra in atto non venisse negato, perché solo facendo i conti con l’altrui identità, senza rimuoverne gli aspetti minacciosi, si può riscoprire la propria. Il che a sua volta è comunque indispensabile per reggere il confronto con gli altri mondi culturali.
L’Occidente, nell’epoca della globalizzazione, non può pretendere di essere al di sopra delle identità, imponendo una sorta di imperialismo relativistico: deve accettare di avere una identità propria, e non temere di confrontarsi con l’altrui sulla base di valori inequivocabili.
Mentre è in atto un certo tipo di conflitto nel mondo islamico, un altro è in corso in Occidente. Essendo quest’ultimo all’origine della globalizzazione, deve dissolversi in essa, confidando che anche gli altri finiranno per fare altrettanto, oppure invece riaffermare certi suoi tratti, venendo meno i quali lo stesso confronto interculturale sarebbe pregiudicato?
Come si diceva, la posizione di chi è in contrasto con il Papa ha dei punti di forza. Ma anche quella del Papa ne ha.
Innanzitutto le guerre religiose non sono mai state veramente religiose. Da quando la guerra in quanto tale esiste, cioè dal tempo degli antichi imperi, essa ha sempre avuto come scopo la conquista o il consolidamento di un potere. L’aspetto religioso è significativo in quanto le religioni sono anche forme dell’identità collettiva, pur costituendo ciò un gravissimo problema.
Da un lato infatti esse rivestono un ruolo sovraordinato rispetto all’esercizio del potere, essendo in grado di legittimarlo o di contestarlo; dall’altro ne vengono inevitabilmente strumentalizzate. Nel caso della guerra religiosa, va da sé che vissuti particolarmente intensi come quelli riferiti alla trascendenza sono incanalati in vista di tutt’altri scopi.
Venendo ai giorni nostri, è abbastanza chiaro che Daesh non esisterebbe se interessi ben precisi non avessero contribuito a crearlo. Più in generale, se, come sostiene il Papa, ciò che è in corso è una guerra mondiale vera e propria, vuol dire che appartiene a un tipo di conflitto che caratterizza i momenti storici in cui si verifica una crisi negli equilibri planetari.
Per fare un esempio tratto dal passato, nei cent’anni che separano la fine delle guerre napoleoniche dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’Europa godette di un lungo periodo di relativa pace. Mentre si completava il processo della costituzione del sistema dei moderni stati nazionali, le varie entità che lo costituivano rinunciarono a dilaniarsi per la supremazia, anche perché una di esse – l’Inghilterra – aveva ottenuto, in quanto dominatrice dei mari, un ruolo di supremo regolatore dei rapporti. L’impossibilità di continuare a svolgere quel ruolo, unitamente all’emergere della potenza tedesca, determinò però infine la crisi dell’equilibrio e l’apertura di una nuova fase bellica, ben più distruttiva di quelle del passato, dato ormai il potenziale che l’industrializzazione aveva reso disponibile, e data anche l’estensione mondiale dei rapporti. Una fase che si sarebbe conclusa con l’affermazione di una nuova superpotenza, erede di quella precedente: gli Stati Uniti d’America.
Ebbene, non è fuori luogo pensare che oggi accada qualcosa di analogo. Non può sfuggire che gli Stati Uniti si trovano sempre più in difficoltà a esercitare il loro ruolo, mentre gli assetti e la distribuzione del potere mondiale si vanno diversificando, con lo spostamento del baricentro dei rapporti in Asia, dando luogo a una nuova fase conflittuale. La difficoltà a farla esplodere apertamente, perché metterebbe fine alla vita sulla terra, e anche per il groviglio di interessi tipico della globalizzazione, spiega ampiamente le modalità con cui la guerra in corso si sviluppa.
La Prima Guerra Mondiale era stata l’apogeo della guerra tra nazioni, cioè di quel conflitto endemico attraverso cui ha preso forma in Europa il sistema degli stati moderni, che attraverso il colonialismo ha esteso il suo dominio sull’intero pianeta. La sua conclusione ha però introdotto una duplice novità: da un lato ha fatto emergere, già in funzione tendenzialmente egemone, un Occidente che non è più Europa – gli Stati Uniti d’America, per l’appunto; dall’altro, con la rivoluzione in Russia, ha dato inizio a un nuovo tipo di conflitto: quello ideologico.
La Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda sono state infatti combattute, più che in nome di nazioni, di grandi scelte ideali: Comunismo, Fascismo e Liberaldemocrazia hanno diviso l’umanità in campi contrapposti, mobilitando risorse di ogni tipo con una forza paragonabile a quella delle religioni, e d’altra parte consentendo ai popoli non occidentali di entrare nell’agone in cui si disputano le sorti mondiali.
Per valutare gli eventi in corso bisogna dunque tener conto dei passaggi precedenti.
Da un lato le moderne ideologie dell’Occidente hanno chiamato i popoli non occidentali a emanciparsi da stati di subalternità determinati dall’Occidente stesso, nel contesto storico del colonialismo. Dall’altro si è fatta strada in essi la convinzione che l’emancipazione non sia possibile entro quei quadri ideologici, proprio perché culturalmente dipendenti dall’Occidente.
È questo il contesto entro cui si sono imposti i fondamentalismi religiosi, soprattutto quello islamico. Quest’ultimo è stato ed è tuttora materialmente sostenuto dagli Stati Uniti in funzione antisovietica e adesso antirussa, anche se strategicamente tende a porsi come erede del Comunismo, cioè come guida nella liberazione degli oppressi dal sistema economico e politico stabilito dall’Occidente.
Quindi un’ulteriore ragione per esser cauti rispetto al concetto di guerra religiosa discende da ciò: che i radicalismi religiosi attuali sono trasformazioni delle precedenti ideologie secondo le esigenze di società con percorsi culturali diversi rispetto all’Occidente, del tutto funzionali ai compiti della modernizzazione e della competizione internazionale in corso.
Il che non significa che, ricollocandosi nel solco di antiche tradizioni, essi non ne siano anche effettivamente parte, quale possibile reinterpretazione entro un nuovo contesto storico. Per capirci, lo stesso Daesh non può, piaccia o meno, essere considerato estraneo all’Islam. Saranno i Musulmani a decretarne l’esclusione, ma la questione non è semplice e non si tratta solo di dichiarazioni.
La religione tra ideologia e spiritualità
Il problema è che le religioni sono sempre state un fenomeno complesso, nient’affatto scisso dalla dimensione sociale e anzi infinitamente capace di interpretarla e plasmarla. Si potrebbe dire sotto questo aspetto che la funzione ideologica, almeno a partire dagli antichi imperi, si è sempre mescolata a quella propriamente spirituale, anche se l’evento originario e fondante di una fede è generalmente legato a un’esperienza di radicale distinzione tra gli ambiti.
Non è difficile ad esempio vedere che le origini del Buddhismo sono nella scelta monastica, cioè nella rinuncia al ruolo sociale dell’élite brahmanica e in una almeno implicita contestazione del sistema delle caste; che l’Ebraismo si costituisce nell’uscita dall’Egitto, inteso come simbolo della sovrapposizione tra gli ambiti; che il Cristianesimo nasce da una radicale e traumatica separazione tra la vocazione profetico-messianica dell’Ebraismo e la sua forma etnico-politica. Si potrebbe aggiungere che la stessa Modernità è l’esito della contestazione del quadro ideologico della Cristianità da parte di elementi originariamente riconducibili alla spiritualità cristiana (o ebraico-cristiana); anche se poi il fatto che tali elementi siano stati sostenuti dalla forza materiale dei moderni stati nazionali, oltre che della emergente economia capitalistica, ha determinato la formazione di un nuovo quadro ideologico, che è quello entro cui ci troviamo da più di due secoli. Un quadro che, nelle diverse varianti tra loro spesso conflittuali, definisce la civiltà scaturita dal moderno Occidente come intrinsecamente superiore a qualsiasi altra del passato.
Per quanto tale quadro sia oggi messo in discussione dal riaffiorare delle radici religiose, si tratta di un fenomeno i cui esiti sono ancora sconosciuti, perché l’esprimere le resistenze dei popoli allo sradicamento della globalizzazione nulla ancora dice della capacità di interpretare la novità della nuova condizione. Di per sé i fondamentalismi sono infatti una reazione a certi tratti culturali della modernizzazione, che però, accogliendone le strutture portanti – politiche, economiche e tecnologiche -, si risolve nell’apertura di vie d’accesso adatte alle particolari conformazioni culturali di certi popoli.
Sotto questo aspetto c’è poco da eccepire rispetto alla famosa tesi di Samuel Huntigton relativa allo scontro delle civiltà. Il problema non è nello scontro, che purtroppo è nei fatti, e neppure nella tendenza dei vari continenti culturali a reidentificarsi facendo ricorso alle loro tradizionali matrici, che sono in fondo religiose. Il problema è un altro.
Dato per scontato che nella fase attuale della storia mondiale i popoli non occidentali traggano immensa forza dal ricollocare vaste moltitudini entro il solco di grandi civiltà del passato, c’è una novità che invece proprio l’Occidente mette in luce.
È ben vero che quest’ultimo vive una particolare difficoltà dovuta alla rimozione delle radici sue proprie, ma al tempo stesso sperimenta una condizione che altri rapidamente scopriranno. Non si pensi solo alla secolarizzazione e alla perdita dei valori tradizionali – insomma al nichilismo; ma a un diverso rapporto con l’identità.
L’identità interdipendente
Bisogna cominciare a prendere seriamente in considerazione che, nonostante l’onda lunga della scristianizzazione e il recente imperversare di neoateismi forsennati, non è del tutto vero che il clima culturale dell’Europa e del Nordamerica sia caratterizzato da un completo abbandono della dimensione spirituale. Il nostro tempo potrebbe anzi essere considerato particolarmente vivo sotto questo aspetto, nonostante e forse proprio in conseguenza della debolezza ideologica che le religioni hanno nella nostra società.
Il discorso ovviamente sarebbe lungo, ma non si può negare che, mentre la scristianizzazione continua a livello di massa, le élite culturali nel loro complesso hanno per lo più smesso di fomentare l’ostilità verso la religione in quanto tale, e si trovano anzi a vivere una condizione di ricerca.
Sarebbe facile osservare quanto grande sia la confusione in cui tale ricerca avviene, e certo anche il pericolo che la spiritualità divenga oggetto di consumo; ma un risultato è in ogni caso indiscutibile: si sta dischiudendo un diverso rapporto con la propria identità.
L’esperienza stessa della globalizzazione scoraggia un approccio che un tempo in Occidente pareva inevitabile, secondo cui la verità della propria fede implica necessariamente la falsità dell’altrui. Il fatto di doversi rapportare a un pensiero dominante che semplicemente nega la trascendenza induce a pensare invece le varie fedi come vie diverse, storicamente e culturalmente determinate, che conducono a una stessa meta.
Il che a sua volta introduce un almeno embrionale sentimento di fraternità tra i credenti di diversa fede, in quanto la validità della propria via non esclude e anzi presuppone quella altrui.
Una consapevolezza dell’interdipendenza dei diversi cammini religiosi è la più sorprendente novità del nostro tempo, di cui si fanno portatori i grandi leader spirituali: come lo stesso Papa Francesco, non a caso talora accusato di non difendere abbastanza l’identità cristiana; il quale invece la sta testimoniando in accordo con ciò che la coscienza spirituale universale oggi va maturando. La sua grande popolarità al di fuori dei confini istituzionali della Chiesa non si deve, come taluni vogliono credere, a cedimenti alla logica del mondo, bensì piuttosto all’intuizione che l’annuncio evangelico debba uscire dai codici che gli sono storicamente propri e interagire con altri, vissuti non più come ostili.
È invece il fondamentalismo, inteso in senso ampio come appello ai fondamenti della propria fede in funzione identitaria, a essere in contrasto col senso dell’identità oggi emergente, che non esclude ma anzi include l’altro. E, per quanto possa non essere avvertito in contesti in vario modo fragili, dove la domanda di un’identità esclusiva pare ancora prevalente, tale contrasto è destinato a minare le basi della fede. Un’identità religiosa assunta in modo troppo rigido, rispetto a quanto la coscienza spirituale odierna può ammettere, mostra infatti chiaramente di essere una costruzione fittizia, che rischia di trascinare nel baratro la fede a cui si richiama.
Dal che scaturiscono alcune conseguenze nient’affatto ovvie.
In primo luogo il fondamentalismo, per quanto apparentemente opposto al nichilismo, gli è legato più strettamente di quanto non si immagini. Ciascuno è causa e conseguenza dell’altro. Una costruzione identitaria artificiosamente edificata nasce da un già esistente vuoto di valori e in realtà lo alimenta. Una visione disincantata della vita trova infatti conferma nella percezione dell’inconsistenza di credenze imposte.
Ne consegue che il dialogo interreligioso non è solo imprescindibile per la pace, ma per la fede stessa. Si potrebbe dire che, contro le apparenze, le religioni in cui sono più attivi i movimenti radicali sono più a rischio delle altre: perché il fondamentalismo uccide quel che vorrebbe ravvivare, sostituendovi un involucro vuoto e infine odioso.
Ciò rimanda a quel nesso, di cui si diceva, di aspetti ideologici e aspetti spirituali presente in ogni religione. Per quanto i primi siano ineliminabili, in quanto connessi con la forma dell’organizzazione sociale e della coscienza collettiva, quando prendono il sopravvento soffocano le sorgenti vive della fede. Bisogna allora, per scongiurare l’inaridimento, che essi vengano posti in discussione. Per quanto ciò possa dar luogo a situazioni difficili, è la condizione affinché la vita religiosa si conservi. Il che induce a valutare la vitalità o meno di una tradizione secondo criteri diversi da quelli più abituali.
Quel che è vivo nelle religioni e quel che non lo è
Paradossalmente, nell’epoca in cui la scristianizzazione dell’Occidente sembra giungere al suo apice, l’esperienza spirituale cristiana è quanto mai viva.
Non solo le persecuzioni attuali stanno producendo nuova semenza per la Chiesa, ma in generale il clima di ostilità e rifiuto verso il Cristianesimo in quanto tale, generato dalle ideologie moderne, lo sta riavvicinando alla condizione originaria da cui scaturisce, per cui “la luce è venuta nel mondo ma le tenebre non l’hanno accolta”. Sotto questo aspetto le persecuzioni attuali non sono che il prolungamento di quelle così poco riconosciute del Novecento, le cui vittime sono ancora più numerose di quelle dei primi secoli.
Nessuna religione si è del resto così profondamente confrontata col problema del male come quella cristiana: non solo come deviazione da un ordine divino e cosmico a cui si tratta di tornare; bensì anche come corruzione così intimamente penetrata nel cuore umano da richiedere un attraversamento della morte come condizione della salvezza. Chi vede con dolore il nichilismo così radicalmente penetrare l’Occidente e allungare la sua ombra sul mondo intero, anziché smarrirsi è dunque autorizzato a trovare conferma alla propria fede, e a coltivare la speranza nel misterioso disegno che si sta compiendo.
Vedendo le cose in questa luce non è il numero delle conversioni a offrire testimonianza - ciò potrebbe addirittura essere fuorviante -, bensì la capacità, anche di pochi, di attraversare la morte – in senso letterale o metaforico.
Altrettanto paradossalmente il grande successo dell’Islam non è affatto una prova certa della sua vitalità spirituale.
Troppo facile è vedere come venga incontro a esigenze largamente diffuse di un ordinamento morale della società dopo la crisi delle ideologie laiche. Il problema è però capire fino in fondo qual è stata la ragione del loro fallimento.
La comprensione islamica parrebbe al riguardo ineccepibile: si tratta della presunzione che l’uomo possa fare a meno di Dio. Su questa base i Musulmani hanno combattuto il Comunismo, almeno dai tempi dell’Afghanistan, e si sono posti come alternativa culturale all’Occidente. Ogni Musulmano, per quanto umile sia la condizione, sa che la sua vita è votata a un principio incomparabilmente superiore rispetto al materialismo di cui la moderna civiltà occidentale pare essersi fatta propagatrice. Essa deve anzi apparirgli come un enigma: come può chi discende dai seguaci di Gesù esser giunto a negare ogni principio religioso?
Eppure le cose non sono così semplici. Proprio perché il riferimento a Dio si presenta come il più sicuro fondamento di un’organizzazione sociale secondo giustizia, troppo facile è che gli uomini se ne approprino. Quello che fa oggi Daesh non è dunque impugnabile senza affrontare un nodo di fondo.
Il problema è che, agli occhi dei credenti di altre fedi, sull’Islam in quanto tale grava un sospetto che solo i Musulmani potranno dissolvere: il sospetto di essere fin dalle origini una religione in cui l’aspetto spirituale è indistinto da quello ideologico e in fondo soverchiato da esso.
Non coincide forse la rivelazione del Corano con l’unificazione delle tribù arabe, e non dà forse luogo in tempi molto rapidi a un’espansione quasi senza paragoni nella storia? Non sarà che il suo porsi attuale come erede delle ideologie laiche dell’Occidente è consentito da una sua natura originariamente ideologica? E non avranno allora ragione quanti temono la sua aspirazione alla conquista? Lo stesso insistente richiamo a Dio non può essere semplicemente letto come palese legittimazione di un autoritarismo sociale?
Si dice spesso che una grave difficoltà nel rapporto con i Musulmani è che l’Islam non conosce la laicità. La questione è senz’altro importante, ma a condizione che la laicità sia intesa al di là dei termini in cui la si vorrebbe circoscrivere, cioè quelli della cultura illuministica. L’Illuminismo è comprensibile entro un contesto fondamentalmente cristiano, seppure in contrasto con esso: chiedere ai Musulmani di accoglierlo significa chiedergli di rinunciare a se stessi.
In termini pratici la richiesta decisiva sembra essere, soprattutto da parte di chi in Occidente è fautore dell’accoglienza, la reciprocità: cioè la garanzia, nei Paesi dove i Musulmani sono maggioranza, della pienezza della libertà religiosa. Si può anche però capovolgere la questione, e chiedere ai Musulmani come concepiscano il loro ruolo in una società in cui sono minoranza, rinunciando a coltivare il sogno di diventare un giorno maggioranza.
Come intendono porsi? Forse, si direbbe in termini cristiani, come lievito e sale della terra? Come fautori e tramiti di un ritorno alla fede in Dio, sapendo rinunciare alla pretesa che essa assuma necessariamente la forma islamica? E sapranno riconoscere davvero il valore di verità delle altre religioni, non solo in generiche dichiarazioni ma nell’intimo sentire di ciascun credente?
La questione è decisiva, perché ne dipende un problema assai scabroso, tant’è che per lo più viene taciuto. Data la possibilità di entrare nell’Islam, c’è anche quella di uscirne, senza che la condizione che ne deriva sia definita unicamente in termini di apostasia, coi pericoli che ne conseguono? La risposta è affermativa solo se alle altre religioni è riconosciuto pienamente un valore di verità; altrimenti la questione resta avvolta da un’oscurità purtroppo gravida di intolleranza.
Si potrà obiettare che ciò non è affatto scontato neppure per i Cristiani. Questi ultimi sono però indotti ad accettare il pluralismo religioso da un dato di fatto: piaccia o meno, l’involucro ideologico della Cristianità si trova alle nostre spalle, mentre quello della società islamica ci si può ancora illudere che si trovi nel futuro.
Il punto è che trent’anni fa Giovanni Paolo II convocò ad Assisi quel famoso incontro interreligioso che non è pensabile se non presupponendo che il valore di verità di ogni religione sia stato intimamente accolto. Fu certamente un atto profetico, non ancora sorretto, almeno ufficialmente, da una teologia adeguata, che però certamente ha tracciato un solco nel cuore dei Cristiani. Quale eco ha avuto nel mondo islamico, i cui rappresentanti erano ben presenti?
Non senza difficoltà e contraddizioni, compresi rigurgiti fondamentalisti (giova ricordare che il termine “fondamentalismo” fu in origine coniato per intendere un fenomeno nell’ambito del Protestantesimo), i Cristiani stanno imparando a distinguere la conversione dal proselitismo: cioè ad accettare che la Grazia di Gesù Cristo operi in tutti gli uomini a prescindere dal fatto che si considerino formalmente cristiani. Per vie misteriose, che solo Dio conosce, lo Spirito soffia nelle altre religioni così come anche nel mondo secolarizzato, portando alla salvezza indipendentemente dalle forme culturali in cui ciascuno è immesso.
In altre prospettive, pare ancora più semplice. Da anni il Dalai Lama invita chi incontra il Dharma a non diventare buddhista, bensì, se l’origine è cristiana, a diventare un miglior Cristiano.
Ma l’Islam? Saprà fare altrettanto?
Porre la questione significa scommettere che sia possibile - che avverrà, o stia già avvenendo; e impegnarsi in ogni modo nell’aiuto.
Sicuramente il giorno in cui i Musulmani si sono recati alla Messa, hanno compiuto un atto di grande valore spirituale. Non è stato facile, e da una parte e dall’altra ci sono state incomprensioni. È normale che sia così, perché lo Spirito sorprende sempre. Ogni tradizione è chiamata a trascendersi, per restare fedele alla propria autenticità. Se vuol essere vino nuovo, anche gli otri vanno cambiati.
Il mondo non ha bisogno di Musulmani moderati, ma di Musulmani che radicalmente assumano la loro vocazione spirituale, nelle forme nuove e insospettate che questo tempo richiede. Saranno loro a sconfiggere Daesh, mostrando un volto dell’Islam di cui Daesh è la mostruosa deformazione. Un volto vivo, non una maschera mortuaria.
Quando Papa Francesco dice che ogni religione vuole la pace, sottintende ogni religione viva. La Vita, che è Spirito, trascorre sui volti continuamente cangianti di ciascuno, rendendoli più simili tra loro di quanto la fissità delle maschere farebbe pensare.
Non a caso l’ultimo messaggio di Daesh individua in Francesco il fondamentale nemico. Le ragioni dichiarate sono insidiose: proteggerebbe i gay e sarebbe alleato dei Musulmani moderati – quindi apostati. Ma la ragione vera è un’altra: Daesh teme ciò che davvero lo metterebbe in crisi – cioè una risposta spirituale.
Ci sono buone ragioni per non ammettere che quella in corso sia una guerra religiosa. Ma questo non vuol dire che non sia in atto un grande scontro spirituale.