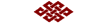I buddhisti alla ripresa
A cura di Bhante Dharmapala
Tempo di riapertura delle attività, tra cui quelle religiose. Si pensa naturalmente alle chiese, non solo cattoliche ma di tutte le confessioni cristiane che ormai costellano la nostra società; e subito dopo alle moschee. Non può però sfuggire che c’è almeno un terzo soggetto la cui presenza è tutt’altro che trascurabile tra noi: le grandi correnti spirituali dell’Oriente, tra cui quel che in genere è chiamato buddhismo e che i buddhisti chiamano propriamente Dharma. Si tratta di una presenza che non si avverte con il peso con cui si avverte quella islamica; una presenza più discreta e solo in minima parte organizzata, ma piuttosto ampiamente diffusa in un immaginario collettivo ormai molto radicato. Per dare una misura a ciò che è ben poco quantificabile, i dati di qualche anno fa dicevano che un terzo degli abitanti dell’Europa crede nella cosiddetta reincarnazione. Il che non significa ovviamente che un terzo degli europei sia buddhista – o hinduista -, ma dà la percezione del grande impatto che visioni della realtà abitualmente considerate come non occidentali hanno sulla nostra società. Il che può essere la premessa per cammini autenticamente spirituali, per quanto spesso in una fase ancora solo iniziale.
Quel che in genere rende il Dharma particolarmente attraente per la società contemporanea è che sfugge alla contrapposizione tra la visione tradizionalmente religiosa e quella laica e tendenzialmente antireligiosa oggi per lo più dominante. Propone infatti vie spirituali che normalmente non richiedono alcun atto di fede né pratica rituale, ma si possono configurare come percorsi di ricerca personali. La meta, più che la salvezza dal peccato tipica del cristianesimo, è l’Illuminazione, o il Risveglio: cioè una più profonda comprensione della realtà e del senso della vita da cui la vita stessa esce trasformata.
L’idea della reincarnazione – sarebbe più corretto dire della rinascita – ne porta poi con sé un’altra, quella del karma: cioè la convinzione che quel che ci è dato vivere corrisponda a condizioni che abbiamo concorso a determinare, e che a loro volta determinano il quadro in cui questa nostra vita si svolge; ma che ogni atto che compiamo concorra a cambiare il quadro, in meglio o in peggio. In un contesto culturale molto secolarizzato, dove i fondamenti dell’etica si fanno incerti, un’idea di questo genere - che sia nella nostra libertà porre cause che determineranno effetti congruenti – non può non essere feconda di sviluppi ancora in gran parte da scoprire.
Premesso ciò, si aggiunga che l’insegnamento del Buddha si diffonde tra noi attraverso una certa varietà di canali. Tralasciando l’infinita proliferazione di scuole di meditazione in genere, tecniche psico-fisiche o arti marziali, mi soffermo sulle forme attraverso cui giungono tra noi le fondamentali tradizioni asiatiche, che si propagano in Occidente con modalità più o meno analoghe a quelle tramandate in Asia lungo i secoli. Sarà quindi opportuna una breve presentazione del quadro della diffusione, con particolare riferimento alla situazione italiana.
La prima tradizione, a cui personalmente appartengo, dopo aver preso parte per un ventennio a quella tibetana, è la meno diffusa in Occidente e particolarmente in Italia, se non tra la popolazione immigrata (ci sono soprattutto centomila cittadini dello Sri Lanka, nella stragrande maggioranza buddhisti). Si tratta però della più antica, custode di un insegnamento, contenuto nel cosiddetto Canone Pali – il Pali è la lingua che potrebbe essere stata parlata dallo stesso Buddha -, da cui nessun’altra può prescindere. Parliamo della tradizione Theravada, la “scuola degli anziani”, formatasi in India nel periodo immediatamente successivo alla vita del Buddha e oggi maggioritaria in Sri Lanka – dove il Canone Pali venne messo per iscritto - e in gran parte dell’area indocinese: Birmania, Thailandia, Laos e Cambogia.
L’insegnamento che viene sviluppato, che si esprime soprattutto nella vita monastica, si concentra particolarmente nella pratica meditativa, che attraverso la consapevolezza di ogni atto rende possibile l’apertura della mente a una più profonda comprensione; e ciò in collegamento con una visione in cui ogni fenomeno o evento non esiste se non in rapporto a cause e condizioni che lo determinano, e in cui la realtà è contrassegnata da tre fondamentali caratteri: dukkha, anicca e anatta. Cioè ogni cosa è per sua natura insoddisfacente, impermanente e insostanziale. Fino a quando non lo si comprende si rimane imprigionati nel mondo della sofferenza, mentre la loro piena comprensione consente di uscirne. La ricerca di salvezza, tradizionalmente connessa col culto religioso, si trasforma qui in un cammino soprattutto interiore: un cammino basato su una fondamentale scelta di rinuncia a ogni atteggiamento appropriativo e a un’etica dell’amore e della compassione verso ogni essere.
Le altre tradizioni sono tutte successive e si connettono a una svolta avvenuta in India intorno all’inizio dell’era cristiana. Alcuni testi particolarmente suggestivi, composti per lo più in Sanscrito, la lingua sacra e colta dell’India, sottolineano certi tratti del precedente insegnamento, affermando che ne costituiscano il senso più profondo. In particolare viene ripreso e sviluppato il terzo carattere della realtà, l’anatta, che si amplia fino alla visione della shunyata, ossia la Vacuità. Ogni essere è vuoto, cioè privo di esistenza indipendente; il che non significa che non esista, ma piuttosto che è interdipendente. Di conseguenza viene particolarmente enfatizzato l’aspetto della compassione. Il cammino personale diventa inseparabile dalla liberazione di tutti gli esseri, al cui servizio ci si vota. Inoltre la meta del cammino non è qualcosa da raggiungere, bensì una condizione in cui già si è, di cui si tratta di diventare consapevoli.
Parliamo di ciò che in generale costituisce il Mahayana, cioè il Grande Veicolo, che a sua volta si differenzia in varie scuole. Ciascuna di esse, dal punto di vista storico, rappresenta un diverso modo attraverso cui il Dharma si ridefinisce in rapporto col substrato religioso e sapienziale delle diverse società asiatiche, a cominciare da quella indiana. La sua diffusione infatti non prevede una sostituzione, bensì una complessa interazione. Il Dharma assume tratti tipici del precedente substrato, e d’altra parte quest’ultimo ha occasione, attraverso il confronto col Dharma, di ridefinire se stesso. Ad esempio ciò che comunemente chiamiamo hinduismo, e abitualmente consideriamo la matrice da cui il buddhismo sorge, in realtà è in una certa misura successivo, e può considerarsi la risposta della società brahmanica (quella sì precedente) al monachesimo buddhista, che fu culturalmente e spiritualmente egemone in India per circa un millennio. Qualcosa di analogo avviene in Cina per ciò che chiamiamo confucianesimo e taoismo.
Detto ciò, tra l’ampia varietà di tradizioni diffusesi nell’arco di due millenni in Asia, due soprattutto hanno assunto grande notorietà in Occidente: quella Zen e quella tibetana. Per diversa ragione hanno profondamente interagito con la cultura occidentale, tant’è vero che nell’immaginario più comune il buddhismo si identifica con l’una o con l’altra forma.
Nel primo caso, parlando di ciò che sorge originariamente in Cina come Chan e poi in Giappone diventa Zen, abbiamo un esempio assai creativo di adattamento del Dharma alla cultura dell’Estremo Oriente.
La mentalità cinese e giapponese, ben diversa dall’intellettualismo indiano, è pratica e intuitiva, legata alla natura e alla sua ciclicità. Nulla di strano dunque che l’insegnamento del Buddha venga inteso come la via che riporta a un’esperienza originaria che si trova al di là di ogni costruzione concettuale. Ne deriva una certa svalutazione delle scritture e della trasmissione discorsiva, interamente a favore della pratica meditativa. In effetti sia “Chan” sia “Zen” sono adattamenti della parola sanscrita Dhyana, che significa meditazione. E infatti questo indirizzo fa scaturire l’Illuminazione dall’abbandono delle categorie attraverso cui la realtà è normalmente interpretata. Ne sono mezzo la meditazione stessa, che mette a tacere il lavorio della mente radicandola nella pura consapevolezza del qui ed ora, e un particolare ruolo del maestro, che mira soprattutto a spiazzare i discepoli, inducendoli a uscire dai consueti schemi mentali. L’attrazione che questo indirizzo esercita sulla mentalità occidentale moderna sta nel fatto che si presenta particolarmente spoglio di elementi religiosi, proponendo un cammino interamente finalizzato a un’esperienza di profondo cambiamento personale.
Un diverso discorso e sotto qualche aspetto opposto va fatto per la tradizione tibetana, attraverso cui l’impronta culturale indiana, con tutti gli elementi religiosi e sapienziali che sono tipici anche delle tradizioni hindu, si comunica alle popolazioni dell’Himalaya e delle immense distese dell’Asia centrale, realizzando una grande sintesi culturale che ottiene, grazie alla protezione degli imperatori mongoli, un’influenza anche sulla Cina. Nel Novecento l’occupazione del Tibet da parte della Cina rivoluzionaria e la diaspora dei monaci contribuisce a diffonderla nel mondo, unitamente alla vasta notorietà della figura del Dalai Lama, a lungo considerato il più popolare tra i leader religiosi mondiali. La pratica di questa tradizione è particolarmente complessa, comprendendo una grande varietà di simboli e riti di diversa origine nonché l’intero repertorio delle scritture, ma il suo senso profondo è condurre alla comprensione della vacuità e dell’interdipendenza di ogni realtà, che consente una trasformazione personale aprendo soprattutto il cuore alla compassione. Solo apparentemente poco adatta alla moderna cultura occidentale, il suo fascino sta nel connettere gli strati più arcaici del simbolismo religioso umano con aspirazioni profondamente radicate nell’umanità contemporanea.
Per quanto infine meno nota al grande pubblico, la presenza in Italia più organizzata e diffusa è quella di un movimento laico di origine giapponese, la Soka Gakkai (Società per la creazione di valore), formatosi nel Novecento in collegamento con un filone spirituale che risale a un monaco del Duecento, Nichiren Daishonin; il quale a sua volta si collega a un testo Mahayana dell’India diventato particolarmente importante per il Dharma dell’Estremo Oriente, cioè il Sutra del Loto. Un testo che esprime la presenza in ogni tempo della condizione del Buddha, cioè l’Illuminazione. La quale, più che dover essere raggiunta, va quindi fatta emergere attraverso la fede nel Sutra stesso e nella sua pratica, e tanto più in un contesto epocale, come quello in cui viveva Nichiren ma anche quello attuale, che è di decadenza del Dharma e non consente più alle antiche pratiche di essere efficaci. La pratica adatta a questa epoca consiste dunque nella recitazione del daimoku, che non è altro se non il titolo del Sutra del Loto, che ne racchiude l’essenza esprimendo la legge mistica che governa ogni cosa. In Giapponese suona: Nam Myoho Renge Kyo, che può anche essere tradotto in: “Mi dedico alla mistica legge di causa ed effetto attraverso l’insegnamento del Buddha”. Si tratta di una recitazione attraverso cui si attinge alla forza profonda della vita e che consente di trasformare la sofferenza portando alla luce la natura di Buddha presente in ciascuno. L’indiscutibile successo di questo indirizzo scaturisce senz’altro dalla particolare capacità di interpretare la condizione di una società come quella attuale, dalla semplicità della pratica proposta e dal saper fornire un forte contesto relazionale di supporto alla pratica stessa.
Sulla base di tutto ciò si può facilmente intendere che la via buddhista è soprattutto un cammino personale e tendenzialmente privilegia la pratica meditativa, o la recitazione che ne prende il posto. Vi si affianca un insegnamento che si avvicina maggiormente a ciò che in Occidente chiamiamo filosofia, piuttosto che alla religione in senso stretto. Solo nella tradizione tibetana troviamo un aspetto rituale particolarmente sviluppato e nella Soka Gakkai e in genere alle correnti che si collegano al Sutra del Loto un elemento che si può definire di fede. La dimensione comunitaria, il Sangha, non è tradizionalmente assente, ma in Occidente, con l’eccezione rappresentata dalla Soka Gakkai, prende il sopravvento la ricerca individuale, sebbene comunque connessa con la figura di un maestro.
Questo tipo di atteggiamento comporta che l’evento della pandemia sia stato accolto in modo almeno in parte diverso rispetto ad altre tradizioni, nelle quali la dimensione comunitaria è particolarmente importante e ci si è trovati a non poter disporre delle sedi di culto proprio nel momento in cui la preghiera sarebbe stata più importante. Il che è stato motivo di sofferenza nella sofferenza e la partecipazione telematica ai riti non ha mai potuto sostituire quella diretta. Ciò è particolarmente vero per la pratica cristiana, la quale, avendo al centro l’Eucarestia, ha particolare bisogno di un rapporto reale e non virtuale con il rito.
In ambito buddhista la pratica meditativa non ha dunque generalmente incontrato un ostacolo insormontabile nel distanziamento sociale imposto, e talvolta anzi un ambiente particolarmente favorevole. È stato un po’ come se all’intera società fosse stata imposta una sosta meditativa. Anche gli insegnamenti potevano senza difficoltà essere trasmessi telematicamente. In taluni casi si è addirittura riscontrato che il mezzo tecnologico permetteva una partecipazione più ampia e costante di quanto accadesse in genere negli incontri diretti. Una parziale eccezione va fatta per la tradizione tibetana, dove l’aspetto rituale è più sviluppato e un maggiore rilievo assume la presenza viva del maestro, e ancor più per la Soka Gakkai, il cui sistema di partecipazione e diffusione si base sulle riunioni in case private, diventate evidentemente inagibili. In genere va comunque precisato che il Dharma induce una percezione della realtà non incompatibile con la smaterializzazione tipica del mezzo telematico. Ricordo che si parla di anatta, cioè non sostanzialità, o shunyata, cioè vacuità.
L’eccezionalità della condizione in cui ci si trovava diventava poi a sua volta occasione preziosa di meditazione e di insegnamento. Essendo la pratica particolarmente orientata all’osservazione interiore, quella condizione, incluso il rapporto con il pericolo e con la morte – che rende ben presente l’impermanenza di ogni cosa -, era particolarmente adatta a far emergere consapevolezze più profonde.
Si può quindi pensare che questo periodo sia stato per la pratica buddhista notevolmente fecondo. Al punto che, più che lasciarselo alle spalle, sarà importante conservare quanto si è acquisito. Anche i mezzi tecnologici adottati è presumibile che non vengano del tutto tralasciati. In vari casi, pur riprendendo possesso delle consuete sedi di pratica, almeno parzialmente si pensa di mantenere i collegamenti a distanza, in modo da facilitare la partecipazione di chi è più lontano.
Ma soprattutto si cercherà di mantenere e approfondire le consapevolezze maturate. Il fatto stesso che la pandemia non sia affatto esaurita, e il futuro tutt’altro che prevedibile, deve essere preziosa fonte di insegnamento. Nessun riferimento a circostanze esterne, né religiose né tecnologiche o sociali, può essere risolutivo per venire a capo dei problemi connessi alla condizione umana. Solo nella consapevolezza interiore è possibile trovare le connessioni di senso con il destino personale e con quello di tutto ciò che vive. Non che ciò non comporti implicazioni etiche, particolarmente legate alla percezione dell’interdipendenza e al senso che ne consegue di universale compassione. Implicazioni che però purtroppo solo in parte sono ancora sviluppate in Occidente.
Da molti anni alcuni tra i maggiori leader religiosi buddhisti spingono affinché, accanto al buddhismo della meditazione e in stretta relazione con esso, ci sia un buddhismo impegnato, cioè coinvolto nelle grandi questioni sociali del nostro tempo. Nella convinzione che saprebbe portare in esse uno spirito particolarmente vivo di fraternità e condivisione tra gli esseri umani e con l’ambiente naturale che li accoglie.
Personalmente nel contesto della pandemia ho sentito particolarmente forte l’urgenza di contribuire a promuovere, nell’ambito del coordinamento interreligioso piemontese Noi siamo con voi, un aiuto interreligioso a chi è senza dimora, particolarmente quindi esposto in questo periodo. Aiuto che si svilupperà nel prossimo periodo anche in rapporto ad altre categorie di persone che le conseguenze economiche della pandemia hanno esposto a condizioni di particolar indigenza.