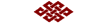- La premessa panikkariana: esiste una filosofia indiana?
 Una riflessione sul pensiero panikkariano, potrebbe prendere inizio con una domanda volutamente provocatoria: “Panikkar è un filosofo?” Nel tentativo di rispondere, vorremmo dare dimostrazione di come, nel cercare di chiarire i termini di tale interrogativo, si chiariscano diversi aspetti della sua poliedrica personalità e della sua ricca e pluridecennale attività intellettuale.
Una riflessione sul pensiero panikkariano, potrebbe prendere inizio con una domanda volutamente provocatoria: “Panikkar è un filosofo?” Nel tentativo di rispondere, vorremmo dare dimostrazione di come, nel cercare di chiarire i termini di tale interrogativo, si chiariscano diversi aspetti della sua poliedrica personalità e della sua ricca e pluridecennale attività intellettuale.
In primo luogo Panikkar ha oggettivamente i titoli accademici per dirsi filosofo. Nel 1946 ha conseguito un dottorato con il neotomista Xavier Zubiri elaborando una tesi che ha per titolo “El concepto de naturaleza. Analisi historico y metafisico de un concepto”. Tali ricerca filosofica ebbe anche dei riconoscimenti importanti, e vinse, per esempio, il premio Menéndes y Pelayo. Al riguardo, meriterebbe un approfondimento mirato l’analisi di tale dissertazione, e soprattutto il rapporto tra Zubiri e Panikkar, pista d’indagine, questa, piuttosto trascurata fino ad oggi[1]. A prescindere, comunque, dai titoli universitari del pensatore indo-catalano, la risposta alla domanda postaci - se egli sia o meno un filosofo -, dipende anche da quale speculazione filosofica si prenda in esame: se con essa, cioè, si faccia riferimento alla sola indagine filosofica occidentale o anche a quelle dell’India. In entrambi i casi, tuttavia, lo possiamo premettere, Panikkar si è dimostrato un vero filosofo, sebbene, per contestualizzare adeguatamente la questione, sia necessario in via preliminare analizzare le differenze che distinguono la filosofia occidentale da quella orientale.
In un suo saggio dedicato espressamente a tale tema: L’esperienza filosofica dell’India, Panikkar stesso ha svolto uno studio particolareggiato intorno ai tratti distintivi che differenziano il pensiero indiano da quello dell’Occidente[2]. Del volume, che merita indubbiamente un approfondimento puntuale, essendo uno dei pochi testi in commercio che prendono in esame il suddetto tema, bisogna in primo luogo analizzare il titolo del saggio, ed in particolare il termine “esperienza” in esso richiamato. Quest’ultimo, infatti, evocante l’empeiria classica, intesa come conoscenza esperienziale o sapienza, risulta fondamentale per comprendere la specificità della filosofia indiana[3]. Ovviamente, però, l’analisi delle differenze speculative tra Oriente ed Occidente da lui messe in evidenza, conducono giocoforza non soltanto a chiarire cosa sia la filosofia per Panikkar, ma anche, almeno in parte, quale sia la filosofia di Panikkar. Sulla scia delle sue critiche comparative, quindi, nella parte finale del contributo andremo a prendere in esame due concetti che risultano fondamentali nell’architettura complessiva della sintesi filosofica panikkariana: il “cosmoteandrismo” e l’“a-dualismo”.
In generale, il volume su cui concentriamo la nostra attenzione, L’esperienza filosofica dell’India, è un saggio che svolge una presentazione sommaria ed alquanto inusuale dell’intera parabola speculativa indiana. Panikkar, infatti, che ritiene superato il concetto classico di darśana (visione sistematica della realtà), non muove dall’articolazione tradizionale delle sue varie scuole, ma sceglie altresì di presentare il pensiero indiano attraverso i suoi concetti fondamentali, o meglio attraverso i suoi termini chiave. Da questo punto di vista, il saggio risulta avere una complessità di fondo che, come ammette l’autore stesso, richiede per la sua comprensione piena delle competenze previe. Al di là di ciò, il metodo da lui scelto per presentare la riflessione indiana risulta valido. Di indubbia efficacia, ad ogni modo, è la domanda programmatica che il testo si pone in via preliminare: se, cioè, si possa parlare di una “filosofia indiana” in rapporto a quella occidentale, ed in quali termini.
- Per una introduzione al pensiero speculativo indiano
Panikkar dà per scontata, nelle pagine del suo volume, una conoscenza generale della storia del pensiero indiano, che però, almeno sommariamente, è necessario riassumere. Essa si divide in quattro grandi periodi:
- Periodo vedico (1500-VI sec. a.C.)
- Periodo dei sistemi filosofici (VI sec. a.C.-VI sec. d.C.)
- Periodo scolastico (VI-XVII sec.)
- Periodo del neoinduismo (dal 1800 in poi)
Anche sulle scuole o darśana, come per la sua periodicizzazione, sebbene Panikkar abbia optato per una presentazione illustrativa che non mette in risalto né l’una né l’altra, occorre stendere alcune considerazioni integrative. Ciò, se non altro, rende la sua stessa introduzione al pensiero indiano maggiormente accessibile e più vicina a quelle tradizionali. Esse sono tradizionalmente sei con un abbinamento binario: Nyāya e Vaiśeṣika; Sāṅkhya e Yoga; e Mīmāṃsā e Vedānta. Vi sono tuttavia anche altre enumerazioni, sulle quali, però, il sacerdote indo-catalano, che parlava di una «mania classificatoria dell’Occidente», non avrebbe probabilmente amato soffermarsi[4].
Il sistema Nyāya è in genere ricordato come il primo dei sei sistemi ortodossi (āstika) del pensiero indiano, (che esclude soltanto gli antagonisti della cultura brahmanica: il materialismo dei Lokāyata, il jainismo ed il buddhismo). Esso ha come sūtra radice il Nyāya Sūtra, testo compilato da Akïapâda Gautama nel II secolo a.C. Il suo contributo è sostanzialmente metodologico, nel senso che solo in un secondo momento è diventato un sistema filosofico. A prescindere da ciò, la suddetta scuola è essenzialmente un sistema logico, paragonabile alla logica aristotelica, che è poi stato adottato dalle generalità delle altre scuole induiste. Una differenza sostanziale dalla filosofia occidentale, tuttavia, è che essa non articola una logica fine a se stessa, ma bensì mirata ad ottenere una valida conoscenza il cui unico scopo è quello di poter giungere alla liberazione dalla sofferenza esistenziale. Il suo sistema gemello, come si accennava, è quello del Vaiśeṣika, il quale si occupa di classificare i dati dell'esperienza e di ridurli ad alcune categorie fondamentali. Esso propone una teoria che indaga la natura degli atomi, della loro combinazione e degli elementi che ne derivano. I testi canonici sono sostanzialmente i Vaiśeṣika-sūtra, attribuiti ad un bramano chiamato Kaṇāda che li avrebbe redatti verso il I o II secolo della nostra era. Secondo il Vaiśeṣika, tutto ciò che si percepisce è sostanzialmente reale. Per esso, infatti, le cose esistono indipendentemente dal fatto che noi le percepiamo. Il mondo è pertanto eterno, ed è il risultato di una combinazione di atomi in continuo movimento. Dio, secondo questo darśana, non è creatore, ma è comunque la causa efficiente dell’universo e il regolatore del karma. Il destino dell’anima, quando avviene la liberazione, è appunto quello di tornare alla sua essenziale immobilità, inattività e inconsapevolezza, pienamente distaccata dalla mutevolezza del mondo terreno.
Passando alla seconda scuola binaria, occorre precisare che il termine Sāṅkhya significa letteralmente “numerazione”, in quanto deriva dal sostantivo saṅkhyā che indica appunto la parola “numero”. Fondatore di tale scuola si ritiene essere Kapila. Secondo questo sistema filosofico, il reale scaturisce dalla relazione fra due princìpi onnipervadenti ed eterni: quello pluralistico dei puruṣa e quello evoluzionistico della prakṛti, la materia. L’anima individuale, il corpo sottile, che, in quanto essenza è già presente nella quiete originaria della prakṛti, ha la possibilità di evolvere fino al conclusivo isolamento dalla materia, svincolandosi definitivamente dal ciclo delle rinascite ed accedendo alla beatitudine mistica. Da esso - e suo complementare -, discende il sistema Yoga, che ne è essenzialmente un’applicazione pratico-ascetica. Suo testo radice, universalmente conosciuto, è lo Yoga Sūtra (Aforismi sullo Yoga), redatto da Patañjali, testo che raccoglie appunto i suoi 185 aforismi.
Il sistema Mīmāṃsā, e con essa passiamo al terzo darśana binario, è una scuola di pensiero il cui significato letterale è quello di “riflessione profonda”, indagine, esegesi. Come suo sinonimo si usa anche il termine Pūrvamīmāṃsā (“Riflessione anteriore”), per distinguerla appunto dalla Uttaramīmāṃsā (“Riflessione posteriore”), ovverosia il Vedānta, che ne è il contro altare opposto. Il testo base di questa scuola è il Pūrvamīmāṃsā Sūtra (Gli Aforismi dell’Indagine anteriore) attribuito a Jaimini (ca. 300/200 a.C.). È questa un’opera che dà avvio ad una speculazione profonda intorno alle regole teologico-sacrificali. Essa, infatti, si allaccia direttamente ai Veda ed in particolare ai testi che trattano del rito. I primi mīmāmsāsūtra risultano essere stati redatti a cavallo dell’era cristiana, ovverosia tra il 200 a.C. e il 200 d.C. In generale, comunque, la dottrina che fa da sfondo e domina questo darśana, è quella del karma, inteso non tanto come azione morale, ma bensì in senso rituale, ovverosia come atto liturgico. La convinzione di fondo, infatti, è che l’uomo e l’intero universo siano retti dal sacrificio. Il sistema Vedānta – la sua controparte antitetica - è la scuola di pensiero più universalmente diffusa in India, ed è quella più tradizionalmente considerata ortodossa. Essa si fonda sulla rilettura delle Upaniṣad svolta da Bādarāyaṇa (III-V secolo d.C.). Suo testo radice è appunto il Vedāntasūtra (o Brahmasūtra). Questo darśana, è non a caso definito anche Uttaramīmāṃsā, proprio perché rispetto alla Pūrvamīmāṃsā si riferisce all’autorità dei Veda secondo però un’angolazione opposta: non più quella rituale, ma quella introspettiva. La Mīmāṃsā mette al centro il rito sacrificale (yajña) perché svolge un’analisi sui mantra rituali ed i Brāhmaṇa, che riassumano appunto la porzione “anteriore” dei Veda. L’Uttaramīmāṃsā, invece, prende in considerazione le Upaniṣad, ovverosia la porzione “posteriore” dei Veda. Il Vedānta, in ogni caso, è frazionato in numerose scuole che hanno un orientamento metafisico alquanto diverso. In particolare le sue correnti si frazionano intorno a tematiche quali la realtà o l’irrealtà del cosmo, e riguardo al rapporto ontologico che sussiste fra il Sé individuale (jīva o ātman) e l’Assoluto (Brahman).
È proprio a questa scuola di pensiero e alle sue sfumature interne che fa riferimento Panikkar. Le sue riflessioni, infatti, prendono esattamente in esame il monismo o non-dualismo di questa scuola, il cui termine sanscrito è quello di advaita. Massimo rappresentate di questo darśana è Śaṅkara, il cui indirizzo di pensiero è anche definito Kevalādvaita-vāda. Nel suo insegnamento, l’unica Realtà è quella assoluta, mentre quella fenomenica, in continuo divenire, è mera apparenza (māyā). Il motivo sostanziale per cui la sola vera realtà è quella non-duale, quindi, poggia sulla nullificazione del fenomeno. Da ciò, inoltre, discende anche che la Realtà assoluta (Brahman) e la pura Realtà o essenza non fenomenica (ātman) dell’essere individuato jīvātmā (anima individuale), sono la stessa e medesima realtà. Il percorso, pertanto, che arriva a riconoscere tale identità, si compie necessariamente mediante un costante e continuo discernimento (viveka) tra ciò che è assoluto e ciò che e relativo, e rinunciando a tutti i vincoli causali e determinanti del contingente.
Presentati, sia pure in estrema sintesi, questi darśana, la cui conoscenza, come si diceva, il saggio panikkariano dà per scontata, diventa maggiormente agevole seguire le sue speculazioni intorno alle differenze che distinguono il pensiero indico da quello occidentale. In generale, comunque, l’autore indo-catalano non è affatto critico della filosofia occidentale, come invece qualcuno potrebbe attendersi. Egli, al contrario, critica invece duramente la sua dicotomia post-rinascimentale tra filosofia e teologia[5]. L’idea che il pensiero indiano sia sostanzialmente teologia e non filosofia, infatti, è il luogo comune che ha sempre allontanato gli studiosi occidentali dal suo approfondimento sistematico. All’opposto, secondo Panikkar, una filosofia ateologica sarebbe incapace di guidare e di comprendere la condizione umana. Su questa medesima linea, era altresì convinto che una teologia filosofica perderebbe ogni credibilità. Una delle più profonde convinzioni panikkariane, da questo punto di vista, consiste nella persuasione che il pensiero indico avrebbe potuto aiutare l’Occidente a superare questa divisione limitante in cui è caduta la sua speculazione filosofica[6]. Egli, per esempio, rileggeva il suddetto conflitto anche attraverso due categorie indiane: quella del vyavahārika e quella della paramārthika; ovverosia la distinzione tra ciò che attiene a questo mondo e ciò che attiene all’altro. Panikkar riteneva anzi che il chiarire quale effettivamente sia il rapporto tra questi due livelli, rappresentasse indistintamente il problema di tutte le scuole filosofiche[7]. A prescindere da ciò, se la teologia si fonda sulla fede e la filosofia sulla ragione, la domanda fondamentale che si poneva Panikkar era: «Dobbiamo chiamare teologia l’attività “filosofica” del subcontinente indico? O si tratta di un altro tipo di filosofia?»[8].
È evidente che la risposta ad una tale domanda, dipende preliminarmente da una previa definizione teorica di filosofia. Ciò, tuttavia, non è affatto semplice perché, come nota l’autore stesso, esiste un’oggettiva multivocità della filosofia[9].
Per potare un esempio, se volessimo chiarire quali sono le differenze tra pensiero indico e pensiero occidentale attraverso il linguaggio della scolastica, afferma Panikkar, la filosofia indica si dovrebbe definire per il suo oggetto materiale, per la realtà che vuol conoscere, mentre quella occidentale dal suo oggetto formale, ovverosia per la conoscenza razionale della realtà. Nel medesimo tempo, però, egli nota anche che vi è una possibilità d’incontro in quanto l’“oggetto materiale” è il medesimo[10]. Precisando meglio il concetto, il pensatore indo-catalano riconosce che si potrebbe in verità distinguere le due filosofie per l’ obiettivo che si pongono. A differenza della speculazione occidentale, infatti, il risultato ultimo a cui mira la filosofia indica è sempre e comunque mokṣa, ovverosia la liberazione spirituale, sebbene Panikkar precisa anche che «il carattere salvifico della filosofia non era sconosciuto in Occidente»[11]. Ad ogni modo, a suo avviso, in India non è riscontrabile una vera distinzione tra religione, filosofia e teologia, proprio perché, come scrive, la filosofia indica «è essa stessa religione»[12]. In sostanza, dunque, quello sollevato dal pensiero indiano va a coincidere con il classico problema tra fede e ragione, che, sostiene l’autore, è un falso problema, e comunque mal posto[13]. Il sacerdote indo-catalano, infatti, ritiene che tale distinzione si perda quando viene preso in esame il concetto di verità.
In virtù di tale tensione comparativa, diviene quindi alquanto spontaneo associare il pensiero panikkariano all’interno della filosofia comparativistica e collocarlo al suo interno. Tuttavia, è egli stesso a precisare che questo recente indirizzo filosofico incontra delle difficoltà, se non altro quella legata alla sua nascita, essendo nato quando l’Occidente ha incontrato altre culture, o meglio quando ha trasferito sé stesso in altri orizzonti culturali. È esattamente questo il motivo per il quale anziché filosofia comparata egli preferisce parlare di multiprospettivismo[14].
Uno dei capisaldi del pensiero cristiano di Panikkar, del resto, è che ‹‹L’incarnazione è anche inculturazione››[15]. Il vizio di fondo consueto, in altre parole, denuncia l’indo-catalano, quello di usare il pensiero occidentale come unità di misura unico. Egli, da questo punto di vista, riscontra una pregiudiziale insufficienza metodologica di base[16]. Proprio per superare questa limitazione, egli introduce alcune categorie concettuali, quali, per esempio, l’esigenza di un “dialogo dialogico”[17], o quella di un’“ermeneutica diatopica”[18].
In generale, comunque, secondo quanto dice il nostro autore, occorre cautela ogni volta che si dà alla parola greca filo-sofia una validità fuori dal suo ambito linguistico proprio. Panikkar, del resto, riteneva che ci fossero valori interculturali, cioè validi in diverse culture, ma non trans-culturali, ovverosia al di sopra di tutte le culture senza appartenere necessariamente a una di esse[19]. Su questa linea di pensiero, ed applicandola alla filosofia, egli riteneva appunto che non esista una trans-filosofia, e se quella occidentale pretende talvolta di esserlo, ciò è solo un’eredità dell’eurocentrismo.
Sviluppando questo orizzonte riflessivo, egli giunge ad un altro interrogativo fondante: quello di chiedersi se filosofia sia «un termine tecnico che appartiene a una sola cultura o una parola il cui significato può venir condiviso da altri universi linguistici?»[20]. Al riguardo, precisa in prima istanza che dire filosofia occidentale è una oggettiva tautologia[21]. Egli passa così a porsi il problema se filosofia sia un nome proprio o un nome comune[22]. Va detto, a questo proposito, che Panikkar quando usa la parola filosofia, la usa nel suo significato più ampio, ovverosia quello che comprende al suo interno la metafisica, la teosofia, la teologia, ecc. Sotto questo aspetto, cioè, filosofia nel suo linguaggio sta ad indicare una macro categoria. Il sacerdote di Varanasi, giunge infine ad affrontare direttamente quella che si può in fondo considerare la questione nodale. Egli, infatti, si chiede esplicitamente: «Possiamo parlare di filosofia nell’India classica? Non possiamo eludere la risposta. Se per filosofia intendiamo l’interpretazione accademica occidentale predominante, l’India classica ha conosciuto qualcosa di simile, ma non le ha prestato molta attenzione»[23]. Panikkar, al riguardo, sviluppando quanto aveva precisato circa l’inadeguatezza del comparativismo filosofico, sosteneva, e ciò è indubbiamente illuminante, che la titolazione “indian phylosophy” riportata in molti saggi è impropria[24]. Anzi, egli arrivò persino a sottolineare che sono parimenti inadeguati gli sforzi tesi a dimostrare che anche il pensiero indiano, come quello occidentale, ha posizioni positiviste, analitiche e razionaliste[25]. La sua risposta, in definitiva, è che sono possibili filosfemi simili, ma che tuttavia non esiste una trans-culturalità, neppure in filosofia. È questo, in fondo, anche il motivo per il quale il teologo ispano-indiano non cercava tanto di comprendere che cosa sia la filosofia nei due contesti, ma piuttosto cosa spinge l’uomo a fare filosofia[26].
Nella visione panikkariana, pertanto, sussistono – irriducibilmente -, distinzioni essenziali tra la speculazione indiana e quella occidentale. Egli affermava, per esempio, che già il modo di pensare è differente, perché l’Oriente si interessa di più a ciò che è comune anziché a ciò che è diverso. A questo proposito, precisava che l’’India è sotto il fascino dell’Uno, ed è poco interessata alla classificazione del molteplice, non attribuendo ad esso quella realtà che invece gli attribuisce l’occidentale[27]. Un’altra diversificazione da lui messa in risalto, si riassume nel fatto che l’occidente avrebbe un pensiero rappresentativo, mentre quello indiano prevalentemente presentativo[28]. Altre differenziazioni menzionate in L’esperienza filosofica dell’India, riguardano la maniera di vivere il linguaggio. Se esso, infatti, coincide in Occidente con una modalità di comunicazione, in India corrisponde piuttosto una forma di partecipazione a un medesimo mondo simbolico[29]. Infine, secondo Panikkar, sebbene per certi versi questa sia la prima diversità da menzionare, è la cosmovisione di fondo o weltanschauung a non essere sovrapponibile[30].
Il concetto di filosofia comparata, in definitiva, almeno nella lettura datane dal sacerdote indo-catalano, incontra varie improprietà ed inadeguatezze. Nondimeno, l’autore riscontra anche dei punti comuni, e, per quanto attiene il confronto tra pensiero indico e pensiero occidentale, riconosce che entrambi hanno una componente essenzialmente cognitiva; si occupano tutte e due della verità; ed hanno, ciascuna a suo modo, una funzione liberatrice.
3.La presentazione dei filosofemi indici
Il libro di Panikkar, pertanto, senza fare una Storia della filosofia indiana - e nemmeno un’Introduzione al pensiero indiano -, e dopo aver sollevato una serie di critiche alla filosofia comparata, introduce quei filosofemi che consentono comunque, a suo dire, di impostare un certo raffronto tra pensiero orientale e pensiero occidentale. In altre parole, egli, pur affermando che non è possibile una filosofia trans-culturale - giacché il termine stesso filosofia è occidentale -, e che, parimenti, non è ultimamente legittima una filosofia comparativa vera e propria, sostiene nondimeno che sono comunque possibili dei filosofemi, ovverosia delle attività principali dello spirito che esprimono degli equivalenti omeomorfi in Occidente come in Oriente.
I suddetti filosofemi - attraverso i quali la riflessione di Panikkar cerca di presentare in modo sintetico le convergenze del pensiero indico con quello occidentale - sono sostanzialmente tre: l’azione, la volontà e la conoscenza. Le categorie menzionate, nel linguaggio specifico dell’India, corrispondono ai tre grandi mārga, o via dei liberazione, dello yoga classico: karma, bhakti e jñāna[31].
Introducendo quindi nel saggio il primo filosofema, l’autore spiega che in realtà «karman o il rituale non significa un’azione meramente rituale. Significa quella prassi umana totale mediante cui noi guadagniamo la meta dell’esistenza»[32]. Già in prefazione, del resto, Panikkar aveva precisato quali siano i luoghi comuni classici, più o meno legittimi, che contraddistinguono le due culture: quello di un Occidente emblematizzato dalla teoria o gnosis, e quello di un Oriente rappresentato dalla prassi o karma[33]. Con il suo tipico talento neologistico, egli individuava anche un termine di sintesi: quello di “karma-gnosis”. A sua giustificazione, ed è indubbiamente un richiamo autorevole, citava anche la Bhagavad Gītā IV, 33, dove si trova scritto che ‹‹Tutte le azioni, senza eccezione, culminano in conoscenza››[34]. L’intellettuale ispano-indiano, spiegava pertanto che il suddetto connubio ‹‹suggerisce che la prassi è già sapere o che il sapere è potere»[35], e, precisando ulteriormente, concludeva che «karman non è solo il fare (qualcosa), ma il farsi, cioè la realizzazione»[36]. Tale invenzione linguistica, in definitiva, nell’economia complessiva del pensiero panikkariano, rappresentava anche un’occasione per rivalutare l’importanza della prassi, peraltro eccessivamente trascurata, a suo dire, dal pensiero occidentale.
Il secondo filosofema approfondito dal pensatore indo-catalano, è quello della bhakti. Scriveva al riguardo che «Upāsanā o bhakti non significa solo meditazione o devozione. Fa riferimento, ancora una volta, a quell’attività umana totale, incentrata sul cuore, che soddisfa non solo le aspirazioni dell’uomo ma conduce pure alla perfezione stessa della realtà»[37]. Per Panikkar, questo termine, che può tradursi con amore, è dunque un «equivalente omeomorfico di filosofia»[38]. Approfondendolo, inoltre, puntualizzava anche che «la devozione rappresenta la consacrazione di se stesso e dell’intero universo»[39]
Il terzo filosofema è quello di jñāna. Precisandolo, scriveva che «Jñâna-kaṇḍa non si orienta a soddisfare la mera curiosità intellettuale, ma a quella assimilazione della verità, ovvero della realtà, che solo può essere portata a termine mediante una gnosis trasformante e salvifica»[40]. Puntualizzava, ad esempio, che «Jñāna può significare ogni tipo di conoscenza, ma in ultima istanza rappresenta la forma più elevata di essere»[41]. La riflessione panikkariana, forse proprio perché l’induismo, a torto o a ragione, è spesso associato all’eresia religiosa dello gnosticismo, si sofferma particolarmente su questo filosofema dedicandogli diverse pagine. Egli, a prescindere da questa nostra supposizione, ne analizzava in particolare la connotazione ontologica, sottolineando che «Conoscere non è solo divenire la cosa conosciuta ma pure divenire se stesso nella misura in cui, per così dire, ci riempiamo di essere: attualizziamo la nostra potenzialità, ci trasformiamo in ciò che, in definitiva, siamo»[42]. Spiegava, infatti, che Jñāna, sostanzialmente, «è un’assunzione di ciò che si conosce e un identificarsi con esso»[43]. Egli concludeva quindi le sue speculazioni evidenziando la stretta correlazione che passa tra questa forma di conoscenza ontologica e l’ascesi. Annotava, per esempio, che in tale orizzonte «Siamo lontani dalla ragione “pura” e “pratica”. Il prerequisito per Jñāna (e, ovviamente, non solo nel Vedānta) esige la rinuncia (vairāgya) a tutto ciò che non è reale, il discernimento tra ciò che è transitorio e ciò che è non-transitorio (nitya-anitya-vastu-viveka), l’aspirazione alla salvezza (mumukṣutva), autocontrollo e altre virtù come la meditazione, etc. Meditazione è qui l’atto supremo di essere»[44].
- Due luoghi filosofici caratterizzanti il pensiero panikkariano
Dopo aver sia pur brevemente illustrato in che cosa si riassuma il pensiero indiano secondo Panikkar, e che cosa lo caratterizzi rispetto a quello occidentale, risulta ora opportuno stendere alcune considerazioni sui luoghi filosofici caratterizzanti il suo proprio pensiero filosofico. Esso, va puntualizzato in via preliminare, è espressione di una oscillazione e di una costante tensione armonizzante tra i due mondi culturali a cui, anche geneticamente, era legato. Si potrebbe affermare, a questo riguardo, che al di là della molteplicità di temi che lo hanno interessato, quali ad esempio l’ecologia, l’intercultura o la nonviolenza, risulta evidente come il centro della sua speculazione sia sempre stato la metafisica. Una seconda caratteristica di fondo è riconducibile alla presa d’atto che - al di là delle ascendenze prossime e remote che hanno influito sulla sua speculazione -, Panikkar non si è mai schierato con nessuna filosofia e con nessun filosofo occidentale particolare, così come non ha mai rimandato ad alcuna corrente teologica specifica. Da questo punto di vista, egli risulta essere un autore oggettivamente indipendente, il cui pensiero, sostanzialmente, si riassume in uno sforzo ermeneutico e sintetico teso a raccogliere e rielaborare istanze provenienti sia dallo spirito cristiano occidentale che da quello indù indiano.
Non è semplice, proprio in ragione di ciò, isolare le tematiche specifiche che caratterizzano la sua indagine filosofica. Tra di esse, tuttavia, almeno due risultano essere predominanti: l’adualismo ed il cosmoteandrismo.
Del primo concetto Panikkar si è occupato in vari libri[45]. Lo sviluppo di tale categoria, del resto, era una conseguenza pressoché inevitabile del suo confronto serrato con il nondualismo vedantico o advaita. Il suo amico Henri Le Saux, per esempio, fondatore dell’esperienza monastica di Śāntivānām, ne aveva fatto la chiave stessa della propria ricerca mistica. Ciò non poteva non influenzarlo, ed in molti suoi saggi, approfondendo appunto le medesime convinzioni dell’amico e monaco bretone, riteneva che la categoria dell’advaita potesse finanche aiutare la teologia trinitaria cristiana a maturare una più profonda conoscenza dei propri misteri[46].
Ponendo il problema su un piano prettamente filosofico, egli spiegava inoltre che l’adualismo è un principio di fondo per mediare tra i due orizzonti oppositivi del panteismo e della dualità: «La relazione tra i contrari non è dialettica ma dialogica: né monismo né dualismo»[47]. Egli, aggiungendosi alla numerosa schiera dei commentatori vedantici delle Upaniṣad, riteneva appunto che advaita andasse tradotta non con non-dualità, ma con a-dualità, sfumando così tutte le sue possibili implicazioni monistiche[48]. Il monismo vedantico, del resto, eliminando la relazionalità, toglieva ogni possibilità teorica all’amore, che è invece la prima verità del cristianesimo. Panikkar, dando sviluppo all’a-dualismo di contro al non-dualismo, ha inteso quindi superare quel solipsismo monadico che aveva fatto scrivere all’altro amico e co-fondatore di Śāntivānām, Monchanin, che “l’India rende l’amore un assurdo”. Cambiando, e per certi versi ribaltando le questioni in campo, il sacerdote indo-catalano ha per l’appunto molto insistito sull’amore, sulla sua capacità di superare il dualismo tra teoria e prassi, e sulla sua associazione - anche in India -, ad un philein che coincide con l’amore disinteressato (asakta)[49]. Del resto, non a caso, il volume panikkariano da noi preso in esame si apre, subito dopo l’intestazione, con una citazione tratta del Ṛg-Veda che richiama al mistero dell’amore come principio primo[50].
Per quanto riguarda l’altra categoria fondamentale della sua speculazione filosofica, il cosmoteandrismo, Panikkar illustrava in prima istanza la relazionalità necessaria che lega ontologicamente Dio, il mondo e l’uomo[51]. Da questo punto di vista, il concetto di cosmoteandrismo, così come quello precedente di a-dualismo, hanno alle spalle la categoria previa della Relazione. Non a caso, e non senza ragione, alcuni studiosi ritengono che il principio dell’“et”, ovverosia la relazione, sia il tema capitale della riflessione filosofica e teologica panikkariana. Della stessa dottrina trinitaria, del resto, il cosmoteandrismo risulta essere espressione e sintesi. Va detto, al riguardo, che egli ha appositamente riletto, proprio attraverso i corollari dell’adualismo, la struttura ontologica del principale dogma cristiano. Semplificando, cioè, potremmo dire che nella sua lettura tra le Persone trinitarie - così come tra Dio, il mondo e l’uomo - sussiste un rapporto di a-dualità.
In sostanza, Panikkar, con la sua speculazione tra pensiero indiano e pensiero cristiano occidentale, ha cercato di ricucire una rilevante distanza culturale, ma senza mai scadere in sincretismi comparativi e salvando sempre le rispettive particolarità specifiche. Il raffronto da lui attuato, ha così messo in evidenza cosa la filosofia indica può dare al pensatore occidentale e viceversa, e lo ha fatto senza schierarsi o adottando sintesi precostituite, ma rielaborando con grande originalità prospettive speculative di opposto orientamento religioso, quali appunto sono la metafisica monistica del Vedānta e quella trinitaria del cristianesimo. Da un certo punto di vista, pur contestando la legittimità teorica della filosofia comparativa, egli, attraverso la prospettiva dell’equivalente omeomorfico, ha concretamente avvicinato la metafisica cristiana con i darśana indù. Soprattutto, però, Panikkar ha dato dimostrazione di come la filosofia, sia in Occidente che in India, sia una parte importante della ricerca religiosa che porta all’assoluto e alla realizzazione spirituale.
Il testo riproduce un intervento al convegno Raimon Panikkar, uomo di Dio, di pace e di dialogo, Assisi, Monastero benedettino di San Giuseppe, 4-6 novembre 2011. Pubblicato in Raimon Panikkar, filosofo e teologo del dialogo, a cura di Emilio Baccarini, Claudio Giuseppe Torrero, Paolo Trianni, Aracne, Roma 2013
[1] Una ricostruzione delle fonti sia occidentali che orientali si può consultare in V. PÉREZ PRIETO, Raimon Panikkar. Oltre la frammentazione del sapere e della vita, Mimesis, Milano-Udine 2011, 91-109.
[2] R. PANIKKAR, L’esperienza filosofica dell’India, Cittadella Editrice, Assisi 2000.
[3] Cf ib., 16.
[4] Ib., 19.
[5] Cf ib., 22.
[6] Cf ib., 23.
[7] Cf ib., 191.
[8] Ib., 24.
[9] Cf ib., 26.
[10] Cf ib., 31.
[11] Ib., 26.
[12] Ib., 31.
[13] Cf ib., 34.
[14] Cf ib., 40.
[15] ID., Cristofania, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1994, 42.
[16] Cf ID., L’esperienza filosofica dell’India, cit., 41.
[17] Cf ib., 46.
[18] Cf ib., 48.
[19] Cf ib., 109.
[20] Ib., 110.
[21] Cf ib., 120.
[22] Cf ib., 111.
[23] Ib., 185.
[24] Cf ib., 113.
[25] Cf ib., 115.
[26] Cf ib., 134.
[27] Cf ib., 60-61.
[28] Panikkar illustrava la differenza tra rappresentazione e presentazione, spiegando che «il modo dominante del pensare occidentale è quello rappresentativo. Il pensare ci ri-presenta le cose, in certo qual modo ci ri-fa la realtà nella nostra mente. [..] La forma dominante, o forse migliore, tipica del pensare indico è la presentazione. Il pensare ci presenta, ci mette, per così dire, la realtà in grembo, ci presenta le cose stesse, non più collocandole davanti la nostra mente» (ib., 64)
[29] Cf ib., 77.
[30] Cf ib., 96.
[31] Cf ib., 137.
[32] Ib., 138.
[33] Cf ib., 10.
[34] Ib., 141.
[35] Ib., 14.
[36] Ib., 141.
[37] Ib., 138.
[38] Ib.,148.
[39] Ib., 146.
[40] Ib., 138.
[41] Ib., 153.
[42] Ivi.
[43] Ivi.
[44] Ivi.
[45] Tra i vari passi si ricorda, in Pluralismo e interculturalità, il capitoletto dedicato da Panikkar all’A-dualismo, con la spiegazione di massima che ‹‹La realtà non è né una né molteplice›› (cf ID., Pluralismo e interculturalità, Jaca Book, Milano 2009, 28.
[46] Scriveva il teologo indo-catalano: «L’advaita, che ci aiuta a esprimere adeguatamente la “relazione” Dio-Mondo, fornisce di nuovo il suo aiuto prezioso per delucidare il problema intratrinitario. Se il Padre e il Figlio non sono due, tanto meno sono uno: lo Spirito li unisce e li distingue nel medesimo tempo. Egli è il vincolo di unità; il noi in mezzo, o meglio, nell’intimo» (ID., Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-uomo-cosmo, Jaca Book, Milano 2010, 110).
[47] ID., L’esperienza filosofica dell’India, cit., 12.
[48] Cf ib., 107. Spiegando questo immanenza attraverso la non-dualità, Panikkar precisava appunto che «il messaggio centrale delle Upaniṣad, interpretato nella sua pienezza (sensus plenior), non è il monismo, né il dualismo e nemmeno il teismo che è evidenziato in alcune di esse, ma l’advaita, vale a dire il carattere non-duale del Reale, l’impossibilità di aggiungere Dio al Mondo o viceversa, l’impossibilità di collocare in dvandva, in coppia, Dio e il Mondo Per le Upaniṣad l’“Assoluto” non è solo trascendete, ma trascendente e immanente allo stesso tempo, tutto in uno » (ID., Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-uomo-cosmo, cit., 90).
[49] Cf ID., L’esperienza filosofica dell’India, cit., 151.
[50] Panikkar cita appunto il seguente passo vedico: «In principio è scaturito l’amore, il primo germe della mente» (Ṛg-Veda X, 129ab). Egli stesso, quasi a ribadirne la centralità, ricorda che lo stesso versetto lo si trova in Atharva Veda XIX, 52 e Atharva Veda IX, 2.
[51] A sintesi della sua prospettiva filosofica, potremmo citare il seguente passo: «La visione cosmoteandrica non gravita intorno a un singolo punto, né Dio, né l’Uomo, né il Mondo, e in questo senso non ha centro. I tre coesistono; essi sono in interrelazione e possono essere gerarchicamente integrati o coordinati, ma non possono essere isolati, poiché questo li annienterebbe» (ID., Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-uomo-cosmo, cit., 261).