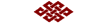Ero negli anni sessanta troppo giovane per partecipare agli eventi, che pure mi attraevano irresistibilmente; così all’inizio dei settanta, appena adolescente, mi ci gettai a capofitto. Il Sessantotto italiano durò peraltro dieci anni ed ebbi tutto il tempo di crescere nel suo grembo.
Ero negli anni sessanta troppo giovane per partecipare agli eventi, che pure mi attraevano irresistibilmente; così all’inizio dei settanta, appena adolescente, mi ci gettai a capofitto. Il Sessantotto italiano durò peraltro dieci anni ed ebbi tutto il tempo di crescere nel suo grembo.
Quando finì, a vent’anni avevo già vissuto il compimento di un grande ciclo, e al tempo stesso ero ancora troppo giovane per rimanerne vincolato. O forse l’inquietudine, da cui in quegli anni mi ero fatto guidare, mi sospingeva ancora altrove.
Iniziai, non da solo, un cammino che mi conduce ad oggi. Un tempo enorme pare trascorso, eppure quegli anni sono ancora lì pulsanti.
Tra quanti del Sessantotto hanno una percezione viva, o per averlo vissuto o per esserne davvero stati interpellati, ci si divide in due schieramenti.
Da una parte coloro che tuttora vivono dentro il mito in cui, come me, sono cresciuti, che ha determinato il loro accesso alla realtà. Per costoro quel che è venuto dopo è una sorta di lungo esilio, in cui il mito si fa lontano senza per questo perdere il suo carattere fondante.
Quel che nei fatti è accaduto si diversifica a seconda dei temperamenti e delle circostanze. Ci sono quelli che si sono semplicemente mantenuti fedeli, senza sapere a cosa ciò li conducesse. Poi quelli che, per un eccesso e un fraintendimento nella fedeltà, sono entrati in spirali distruttive: dal terrorismo alla droga. Infine quelli che del mito si sono serviti per carriere e arrampicate sociali.
In tutti questi casi, anche se gli esiti sono ben diversi, il mito resta tale: cioè un orizzonte di senso in cui si interpreta la realtà. Non si può esserne consapevoli perché si è al suo interno.
Il secondo schieramento comprende invece coloro da cui il mito è stato posto in discussione. Tra costoro ci sono quanti per una diversa prospettiva culturale ne hanno sempre diffidato, ma anche alcuni che vi hanno creduto, e che a un certo punto ne hanno preso le distanze.
Cosa si vede entro lo sguardo di costoro?
Si vede che il senso che a una mente lucida gli eventi mostrano non è quello che si attribuisce loro essendone coinvolti. Le grandi passioni non sono testimonianza inequivocabile di libertà: possono venire suscitate da precise strategie, i cui obiettivi sono spesso ben diversi da quel che viene esplicitamente dichiarato.
Consideriamo che la coscienza di chi visse il Sessantotto fosse di partecipare a un grandioso processo di emancipazione, senza pari forse nella storia umana. A essere posta in discussione era l’organizzazione della moderna società industriale, i suoi ordinamenti culturali ed educativi, e ancora più profondamente strutture che regolano la vita umana fin dalle società più antiche, come la famiglia e le norme sessuali. In quegli anni si visse l’ebbrezza di una svolta antropologica, da cui sarebbe uscita un’umanità restituita a una sorta di originaria innocenza.
Proviamo però a pensare che i processi stessi di modernizzazione richiedessero che ci si sbarazzasse di istituti ormai obsoleti, in modo da isolare gli individui e farne una massa informe di consumatori, che non riconoscono più alcuna legge se non quella dell’impulso immediato. Cosa di meglio che un grande movimento di emancipazione, che con la sua potenza d’urto liberasse il campo da tutto ciò – disciplina, educazione, famiglia, religione – che poteva essere d’intralcio?
Tra i due schieramenti – quello di chi vive dentro il mito e quello di chi lo critica – la comunicazione è quasi impossibile.
I primi vivono se stessi come una minoranza consapevole che si teme destinata alla sconfitta per l’inerzia e l’ottusità dei più, ovvero per le resistenze profonde che il cambiamento suscita. I secondi hanno ragioni ben più valide per attribuire a sé la consapevolezza, però si vivono impotenti a contrastare un corso di cui senza saperlo i primi sono battistrada. Pur appellandosi a un senso comune atavico, sanno che può essere sviato.
Chi, come me, è passato dal primo al secondo schieramento, può testimoniare della sua dignità, più difficile da riconoscere perché il primo ha comunque una forte presa sull’immaginario. Chi si identifica con un mito ha infatti sempre un vantaggio comunicativo su chi ne smaschera gli inganni: consente di continuare a sognare, il che talvolta è più importante che vedere le cose come stanno.
Tant’è vero che anche nel secondo schieramento, senza per lo più avvertirlo, si presuppone a propria volta un mito, sia pur di segno opposto: quello delle radici, o della tradizione. Se la situazione è insoddisfacente, è perché ci si è allontanati da quel che da tempo immemorabile costituisce il fondamento della convivenza.
Da una parte la rottura col passato e la proiezione in un futuro utopico. Dall’altra l’idealizzazione del passato. E allora?
Nella visione buddhista è inevitabile che la nostra mente funzioni per opposizioni. Ne abbiamo bisogno per orientarci nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo sapere ad esempio cosa è valido e cosa non lo è per poter agire.
Accade però che gli opposti, qualora siano assunti come un rigido criterio di distinzione, producano una percezione della realtà limitata, quindi in ultimo non vera. Bisognerebbe adottare la Via di Mezzo, che non è un banale compromesso, ma la consapevolezza che quegli opposti, considerati isolatamente, non colgono la realtà nella sua ricchezza e ci tengono separati da essa. Occorre abbandonarli per potervi accedere. O reintegrarli in un quadro più ampio.
Nel nostro caso, a chi continua ad avvertire il Sessantotto come la grande esperienza liberatoria che ha scosso gli equilibri costituiti, potrebbe sfuggire una corretta comprensione delle condizioni che l’hanno prodotto e di quelle che ha contribuito a determinare.
Non avendo una visione lucida, il suo agire potrebbe ottenere risultati ben diversi da quelli che vorrebbe. Come ancora non molto tempo fa si producevano inferni pensando di realizzare il paradiso in terra, così certi ideali umanitari potrebbero oggi colludere con interessi di tutt’altro tipo.
Soprattutto non vede che effettivamente il Sessantotto ha lasciato, dal punto di vista sociale, culturale ed educativo, un panorama di rovine. La contestazione delle tradizionali forme di riproduzione della vita umana ha davvero contribuito al loro disgregarsi, senza peraltro fare emergere valide alternative. Il risultato è uno sgretolamento del tessuto sociale, che rende gli individui facile preda di poteri economici sempre più incontrollati.
Chi oggi rilancia l’ideologia dei diritti individuali in direzioni un tempo inimmaginabili si fa alfiere di un nichilismo di cui è irresponsabile sottovalutare il pericolo. Sotto questo aspetto chi vi resiste esprime una risposta sana, che andrebbe in ogni modo valorizzata.
C’è però anche dell’altro.
Quale che sia il giudizio sui cambiamenti storico-sociali, anche avendo completamente rigettato l’idea di progresso, nessuno ha il potere di fermarli. Si può pensare che l’economia e la tecnica andrebbero poste sotto controllo, che si dovrebbe impedire loro di stravolgere continuamente gli assetti della vita umana, ma nuovamente non possiamo stabilire se, come e quando ciò avverrà. In ogni caso il cambiamento è condizione naturale della vita, e quello che viene prodotto dai grandi apparati sociali non fa che amplificarlo. Dovremmo quindi prenderne atto, e vedere quale risposta efficace può essere elaborata. Una risposta che, prima che intervenire sulle condizioni esterne, dovrebbe modificare la coscienza.
In questa prospettiva può essere plausibile pensare che, proprio quando il cambiamento si fa più intenso, quando l’umanità si vede proiettata verso scenari sempre più lontani dal passato, si debba mantenere il legame con le radici, che paiono connetterci con quel che l’uomo è da sempre, al di là del cambiamento. Il ritorno alla fede religiosa è sotto questo aspetto ritorno alla tradizione: cioè al filo valoriale e sapienziale che connette le generazioni, proteggendole da ciò che le può disperdere.
D’altra parte le tradizioni stesse non sono immuni dal cambiamento. E non solo perché possono smarrire il loro nucleo più profondo, ma anche perché possono ritrovarlo. Una tradizione è anzi viva nella misura in cui sa rinnovarsi; laddove il rinnovamento non è semplice cambiamento, ma un modo più efficace, nelle condizioni culturali date, per riconnettersi all’origine.
Può darsi sotto questo aspetto che nel mito del Sessantotto ci sia una verità, che anche i più disincantati dovrebbe riconoscere.
Dopo la metà del Novecento il cambiamento era già tale che tutte le forme tramandate si mostravano inadatte a contenerlo. Ne scaturì la più grande rivolta generazionale della storia. Che fu senz’altro pilotata da poteri ben maggiori di quelli contro cui si abbatteva, e in questo davvero contribuì all’evoluzione del sistema anziché sopprimerlo. È lecito però negare che nel suo nucleo più profondo ci fosse un’aspirazione autentica? Tanto da scuotere i fondamenti di tutta la civilizzazione umana?
Bisognerebbe francamente riconoscere la dignità di filoni culturali ingiustamente emarginati.
Se ci rifiutiamo attribuire alla Modernità un valore a priori positivo, accettandone invece la problematicità, sono stati più che altro i pensatori tradizionalisti a gettar luce su di essa. È difficile del resto comprendere qualcosa se non si ha un diverso riferimento con cui confrontarla.
Quel che però forse a tali pensatori sfugge è che la Tradizione è a sua volta una realtà complessa, con una stratificazione e dei conflitti, e con innegabili sofferenze. Almeno dall’emergere delle grandi civiltà statali, la dimensione spirituale si trova spesso confusa con quella di apparati coercitivi che se ne appropriano con altri scopi. Tutte le grandi religioni storiche palesemente si confrontano col problema. E non si comprende forse la Modernità se non come sforzo di sciogliere quel nodo.
È ben vero poi che i nuovi rapporti di potere sono non meno gravosi. Non si può però negare che nella moderna società occidentale vi sia un principio di libertà sconosciuto altrove. Un principio che tutte le ideologie moderne – con l’ambiguità delle ideologie - hanno in vario modo affermato, e a cui la cultura che accompagnava il Sessantotto ha attribuito una portata antropologica. La liberazione non doveva essere solo da questo o quell’ordinamento, ma da strutture sedimentate nell’uomo stesso.
Il Sessantotto non fu del resto del tutto antitradizionale. Si rifiutava quel che appariva consuetudine svuotata, ma si cercava, come per coloro che andavano in India, strati culturali più profondi a cui attingere.
Non esiterei insomma a dire che la rivolta ebbe anche un senso spirituale. Espresso in modo confuso, come quasi tutto: e per questo gli effetti distruttivi sono di gran lunga sovrastanti. È stato però il movimento che, con una diffusione planetaria mai vista prima, ha segnalato a tutti l’urgenza del rinnovamento. Sotto questo aspetto ne siamo più che mai interpellati.
Nel panorama inquietante dei nostri giorni, in cui la terra pare ribollire per una modernizzazione a cui nessuna zona è più in grado di sottrarsi, siamo ben lontani dall’aver chiaro quale senso spirituale vi si celi. Appare urgente, per scampare al diluvio dei beni materiali che ci sommerge, occuparsi dell’uomo. Il che significa investire in azione educativa, cioè finalmente rimettere in circolo quel bene più prezioso da cui da tempo si è sprovvisti. Ma non sarà possibile senza saper al contempo dire cosa l’uomo sia.
Venuta meno la fiducia che la cultura laica, di cui la Modernità era orgogliosa, sappia dirlo, piaccia o meno diamo per scontato tutti che spetti alle religioni. Ma queste ultime sono interpellate a loro volta a trovare dentro di sé una risposta che non sia scontata.
L’autore è un monaco buddhista