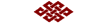Premessa di quanto voglio dire è la profonda convinzione che tra religione e libertà vi sia un legame profondo e indissolubile. L’obiezione che potrebbe venire immediatamente, vale a dire che ciò è continuamente smentito nella storia anche attuale, può essere a sua volta confutata affermando che tale legame è indissolubile fintantoché la religione rimane tale e non decade a ideologia: il che avviene in fenomeni come i fondamentalismi attuali, o è avvenuto ogni qual vota che una religione ha assunto il carattere prevalente di forma della coscienza sociale subordinata a esigenze di potere.
Premessa di quanto voglio dire è la profonda convinzione che tra religione e libertà vi sia un legame profondo e indissolubile. L’obiezione che potrebbe venire immediatamente, vale a dire che ciò è continuamente smentito nella storia anche attuale, può essere a sua volta confutata affermando che tale legame è indissolubile fintantoché la religione rimane tale e non decade a ideologia: il che avviene in fenomeni come i fondamentalismi attuali, o è avvenuto ogni qual vota che una religione ha assunto il carattere prevalente di forma della coscienza sociale subordinata a esigenze di potere.
La questione è delicata, perché forse in ogni tempo la religione, che non può rinunciare a essere forma della coscienza collettiva riducendosi a fenomeno privato, è costretta a difendersi da qualcosa che costantemente la minaccia, e assume forme di volta in volta diverse, che talora la negano talora la distorcono per tutt’altri scopi. Nella tradizione teologica occidentale, ma non solo, ciò si intreccia con un problema che nella cultura odierna è per lo più rimosso: il problema del male; parlare di libertà può forse essere d’aiuto.
Voglio dunque proporre di pensare che in se stessa la religione sia l’ambito che contiene l’esperienza di libertà più completa che possa darsi: cioè l’incontro, al di là delle convenzioni del mondo e delle proiezioni dell’io, con la dimensione più profonda del nostro essere, col centro invisibile intorno a cui muovono i nostri passi, da cui siamo inesorabilmente attratti e senza raggiungere il quale non troviamo pace. In questa luce, l’esperienza religiosa è esperienza di libertà dall’ansia esistenziale. Una libertà che è continuamente ostacolata da processi psicologici e sociali che rinviano implacabilmente l’uomo e il mondo alle catene di quell’ansia. Le strutture di potere che non riconoscono il primato di quell’esigenza umana, che non si pongono in ultima istanza al suo servizio, tendono a produrre limitazioni anche gravissime della libertà degli individui e delle collettività.
In questa luce si può pensare che le diverse forme che caratterizzano i rapporti tra esperienza religiosa e potere siano gli elementi che più profondamente caratterizzano le civiltà. Il fatto che il nostro tempo ci consenta un raffronto spesso ravvicinato è sotto questo aspetto un’opportunità preziosa. Vorrei proporre dunque un confronto con la tradizione culturale e spirituale da cui l’Occidente si trova da molto tempo attratto: quella che meglio consente alla coscienza occidentale quella comprensione di sé che tanto le è indispensabile. Mi riferisco alla tradizione dell’India, con specifico, ma non esclusivo riferimento al Buddhismo. Ritengo che un simile percorso abbia, almeno implicitamente, notevole interesse per il Cristianesimo, e forse anche per altre religioni.
C’è innanzitutto qualcosa che l’antica civiltà dell’India ha donato all’esperienza religiosa dell’umanità: cioè una particolare configurazione di tale esperienza rispetto al contesto della vita sociale. Mi riferisco a un modo di vivere la fede che richiede lo svincolamento dalle comuni esigenze della vita sociale, ovvero l’abbandono del mondo: stiamo parlando del monachesimo. Senza negare esperienze preesistenti, è stato sicuramente l’insegnamento del Buddha a creare per la prima volta nella storia un’istituzione religiosa che non si caratterizza per un particolare ruolo nella società, come la casta brahmanica, ma per una rinuncia alla società stessa. In questo modo, l’esperienza religiosa si sottraeva a legami e implicazioni che potevano deformarne il senso, e, affermando la libertà dalle convenzione su cui quei legami si fondavano, l’istituzione monastica si faceva custode di una libertà spirituale a cui ogni uomo può legittimamente aspirare.
Nei confronti del potere l’istituzione monastica non chiedeva nulla, se non di essere rispettata e protetta nella sua autonomia, sapendo di custodire un bene prezioso per cui ciascun essere umano: ciò che si intendeva con via della liberazione, ovvero della realizzazione profonda della libertà.
È significativo come il rapporto tra il Sangha monastico buddhista e il potere si sia configurato col sovrano che per la prima volta, nel terzo secolo avanti Cristo, unificò gran parte dell’India: Aśoka. Convertitosi all’insegnamento buddhista, egli si fece protettore del Sangha, che acquistò un ruolo preminente nel subcontinente indiano destinato a durare un millennio, ma non lo fece in modo esclusivo e anzi protesse ogni culto vietando a ciascuno di diffamare quello altrui. In questo modo ebbe inizio la storia dell’India che tanto ha affascinato gli occidentali, in cui ogni fede può trovarsi a casa propria.
Sarebbe significativo un confronto con quanto avvenne alcuni secoli dopo in Occidente, quando venne affermandosi la religione che profondamente lo avrebbe caratterizzato: il Cristianesimo.
Da un lato, nella sua esperienza originaria si afferma una radicale alterità dalla sfera del potere: il mio Regno non è di questo mondo, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio; un’alterità che prende forma in un’esperienza terribile e sublime che si incide nel cuore della vicenda umana, l’esperienza della Croce, che per alcuni secoli si rinnova nelle persecuzioni di cui i seguaci di Gesù sono fatti oggetto. D’altra parte bisogna dire che, quando nel tramonto del mondo antico le persecuzioni vengono a cessare, a opera di un sovrano, Costantino, che si assume il compito di proteggere la nuova religione, avviene che, a differenza di quanto accaduto in India, tale protezione è tendenzialmente fin da subito esclusiva, il che comporta un problema mai completamente risolto nella storia della Cristianità: ovvero il costante pericolo della perdita di quel nucleo irrinunciabile della fede che è la libertà. Tant’è vero che la storia dell’Occidente è stata da quel momento segnata non dalla coesistenza delle religioni, bensì dal loro scontro: cristiani contro pagani, poi musulmani contro cristiani, poi protestanti contro cattolici, infine atei contro cristiani.
Si potrebbe obiettare che neppure l’India è rimasta indenne dal paradigma dello scontro delle religioni, ma ciò comincia a esser vero quando a penetrare in India è un tipo di esperienza religiosa all’India originariamente estranea: l’Islam; ed è tanto più vero quando il colonialismo inglese si impadronisce del subcontinente indiano sfruttando, e quindi riacutizzando, la divisione tra musulmani e hindū. Si può dire che a quel punto l’India diventi il luogo in cui due diversi modi di intendere la religione, o meglio il rapporto tra religione e potere, si confrontano: due modi che si intrecciano nel processo storico che conduce l’India ad acquistare la sua indipendenza politica.
Da un lato vi sono coloro che ritengono che l’India, per diventare indipendente, debba acquisire un senso dell’identità nazionale sul modello europeo, e tale identità essi la trovano nella tradizione religiosa hindū, con esclusione quindi della componente musulmana. Da costoro discendono i fondamentalisti attuali, i quali sono propriamente nazionalisti che fanno del’Hinduismo, trasformato in ideologia, un fattore di identità sociale. Oggi essi si accaniscono contro i cristiani, non solo in quanto eredi del colonialismo inglese, ma soprattutto vedendo in essi un fattore di destabilizzazione sociale: fa parte infatti della loro ideologia la difesa intransigente del sistema delle caste e il Cristianesimo, a cui particolarmente si rivolgono i fuori casta, appare ciò che mina le fondamenta di quel sistema.
La seconda tendenza, che fu operante nel processo che condusse all’indipendenza dell’India, è quella che si manifestò soprattutto nella figura del Mahatma Gandhi, in cui si rinnovò l’originaria vocazione dell’India a un’accoglienza di ogni tradizione religiosa, includendovi Islam e Cristianesimo. È significativo che questa seconda tendenza abbia prevalso, così come il fatto che nella bandiera del’India vi sia la ruota di Aśoka, che è anche simbolo buddhista; ma il prezzo è stato ed è tuttora caro: Gandhi non è riuscito a evitare una feroce guerra civile e la separazione del Pakistan; è stato a sua volta assassinato da un estremista hindū; la storia del’India indipendente fino ai giorni nostri, per quanto inserita nel solco tracciato da Gandhi, è stata ed è continuamente segnata da fenomeni anche cruenti di intolleranza.
Oggi l’India, che, senza essere uscita dalla miseria in larga parte indotta dal colonialismo, è potenza emergente sul piano economico e politico, si trova di fronte alla tentazione di affermare la propria identità come alternativa ad altre, tradendo però con ciò il senso profondo che in tale identità è custodito. La possibilità di uscire da questa tentazione pare suggerita da un’altra grande figura che le circostanze della storia le hanno fatto incontrare: Sua Santità il XIV Dalai Lama del Tibet.
L’occupazione cinese del Tibet, la fuga del Dalai Lama e il suo accoglimento in Tibet rappresentano una vicenda in cui i fili della storia si riannodano. Non solo il Buddhismo, che, dall’epoca dell’invasione islamica era scomparso dall’India, fa ritorno nella sua terra d’origine, ma il Tibet stesso riveste un’enorme importanza spirituale e culturale per aver a suo tempo accolto la tradizione Mahayana dell’India immediatamente prima della sua scomparsa dall’India stessa. Inoltre il sistema monastico del Tibet che il Dalai Lama rappresenta ha custodito per vari secoli, di fronte all’autorità imperiale di Pechino, quell’autonomia dell’esperienza religiosa che la tradizione cinese è per sua natura poco incline a riconoscere. In un certo senso il radicalismo con cui il maoismo si è scagliato contro il Tibet ha portato alle estreme conseguenze, in un contesto di ateismo militante, quella tendenza al controllo della sfera spirituale che è tipica da sempre della storia cinese. Sotto questo aspetto, la difficoltà da parte di Pechino ad affrontare positivamente la questione tibetana, soprattutto dopo la rinuncia da parte del Dalai Lama a rivendicare l’indipendenza dalla Cina, rappresenta in realtà la difficoltà ad affrontare una questione che mai s’è posta nella storia cinese: per l’appunto la questione della libertà religiosa.
In questa luce il Dalai Lama, rinunciando a farsi portavoce del nazionalismo tibetano, si pone quale riferimento della libertà religiosa, e custode di quel senso profondo della libertà che solo l’esperienza di fede contiene, in rapporto a tre grandi universi culturali e geopolitici: l’India, la Cina e l’Occidente. Questa è la ragione di un’importanza senza paragoni che la sua figura riveste nel mondo odierno.
In India egli rappresenta la vocazione originaria e universale della civiltà indiana, da cui tutti avrebbero da apprendere e a cui tanto più è lecito chiedere di non rinchiudersi in una identità esclusiva, che tradisce il senso di quella vocazione. In Cina rappresenta l’esigenza di un senso di libertà mai davvero storicamente elaborato, che la presenza del monachesimo buddhista, soprattutto tibetano, da secoli custodisce. In Occidente, con l’esaurimento del ciclo storico del rifiuto del Cristianesimo, egli può aiutare a ritrovare un senso religioso in parte compromesso, e aiutare lo stesso Cristianesimo a riscoprire la sua vocazione, al di là di certi equivoci storici.
Può darsi che in particolare la Chiesa oggi, avendo dovuto sciogliere a caro prezzo i suoi legami con gli indirizzi dominanti della storia occidentale, essendone cioè stata emarginata, si trovi a vivere una condizione particolarmente felice dal punto di vista spirituale, per quanto gravosa per le persecuzioni di cui è fatta oggetto in varie parti del mondo. La condizione di chi può riscoprire il senso originario dell’affermazione evangelica il mio Regno non è di questo mondo, e proprio per questo farsi testimone di un senso di libertà e dignità umana che forse nessun simbolo come la Croce così intensamente custodisce.