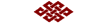Il 6 luglio di ottant’anni fa nasceva il XIV Dalai Lama.
Il 6 luglio di ottant’anni fa nasceva il XIV Dalai Lama.
Per vari anni è stato considerato il leader religioso più popolare al mondo. Varie circostanze avevano reso la sua figura diffusamente amata.
Il suo esilio dal Tibet occupato dai Cinesi e l’instancabile tentativo di ottenere la solidarietà internazionale intorno al genocidio del suo popolo hanno costituito una delle narrazioni più intensamente coinvolgenti del Novecento.
Pochi tra gli intellettuali occidentali osavano sostenere la lettura proposta dal regime di Pechino, per cui le forze della modernità e del progresso avrebbero spazzato via un anacronistico regime teocratico e oscurantista. Presso le élite occidentali l’ideologia del progresso stava ormai cadendo in discredito, e la vicenda del Tibet contribuiva a renderla detestabile. Al suo posto veniva affermandosi un nuovo atteggiamento culturale, attento alle ferite che la moderna società industriale infligge all’ambiente naturale e alle tradizioni ancestrali dei popoli. Di tutto ciò il Paese delle nevi, da cui dipendono gli approvvigionamenti idrici di buona parte dell’Asia, e che custodisce un’antica e preziosa civiltà, diventava l’emblema. Nessuno come il Dalai Lama, nei suoi ininterrotti viaggi intorno al mondo, era simbolo vivente del nuovo atteggiamento.
Non si può negare che quella narrazione, amplificata dai media e soprattutto dal cinema, sia stata coltivata per ragioni politiche. In un contesto storico molto ampio, che abbraccia la Guerra Fredda e l’ordine mondiale che le ha fatto seguito, essa è stata usata in funzione anticomunista e poi come mezzo di contenimento ideologico del nuovo grande antagonista dell’Occidente e degli Stati Uniti in particolare: la Cina. Il che ha determinato il successo mondiale del Dalai Lama, diventato icona planetaria dei diritti umani, ma anche il fallimento di ciò che più gli stava a cuore: il tentativo di trovare con la Cina un accordo che salvaguardasse il Tibet. Paradossalmente proprio il suo successo finiva per confermare la lettura da cui la dirigenza cinese non si è mai smossa, che vedeva nella causa del Tibet un insidioso strumento della politica occidentale per minare l’integrità della Cina.
Il risultato è ben noto. In Tibet la popolazione autoctona conosce un’emarginazione sempre più disperante a fronte di una modernizzazione rapidissima, sostenuta dai crescenti e ormai maggioritari insediamenti di popolazione cinese. D’altra parte lo stesso ruolo internazionale del Dalai Lama si trova a essere ridimensionato in un mutato contesto geopolitico.
Oggi la Cina, ben lungi dal manifestare segni di debolezza interna, si trova al centro dell’ordine economico-sociale emergente, rappresentato soprattutto dal cosiddetto BRICS, tendenzialmente alternativo all’Occidente.
È probabile che gran parte del travaglio dei nostri giorni sia riconducibile a una ristrutturazione dell’assetto dei poteri mondiali, e fin troppo facile sarebbe pensare che l’indiscusso predominio occidentale sul mondo è destinato a venire sostituito da una situazione più complessa e articolata. Ma il futuro non sarà determinato solo dalle dinamiche demografiche, economiche e militari, bensì anche da come i vari soggetti sapranno ridefinire la propria identità. E sotto questo aspetto ripensare oggi al Dalai Lama potrebbe condurci a capire qualcosa di importante di noi.
Potrebbe essere non più eludibile il confronto con ciò di cui egli è stato percepito come il massimo esponente a livello mondiale, quale fosse, nonostante l’improprietà, il Papa di una Chiesa alternativa, che a molti occidentali riusciva più attraente di quella conosciuta. Intendiamo il confronto col Buddhismo; soprattutto per il ruolo che è venuto esercitando in Occidente, probabilmente maggiore di quanto non si pensi. E non certo per la presenza di gruppi organizzati, che sono in fondo ben poca cosa; ma per via di correnti che attraversano gli spazi sociali mutandone impercettibilmente la configurazione.
Avrebbe del resto potuto il Dalai Lama ottenere tutto quel riconoscimento, se non si fosse collegato a un movimento culturale profondo, in cui l’Occidente, attraverso vie in gran parte invisibili, recepiva soprattutto dall’Oriente modelli di pensiero che ne mettevano in discussione gli indirizzi finora dominanti?