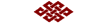C’è tristezza tra coloro che per anni generosamente hanno sostenuto la causa tibetana. Nulla avviene nel Paese delle Nevi se non l’inesorabile consumarsi di ciò che nessuna mobilitazione è stata in grado di fermare. I Tibetani sono ormai stranieri in casa propria: una minoranza emarginata che ben poco può cambiare del corso degli eventi. Neppure l’ultima disperata protesta, con le persone che si davano fuoco per richiamare ancora l’attenzione del mondo, ha potuto sortire alcun effetto.
C’è tristezza tra coloro che per anni generosamente hanno sostenuto la causa tibetana. Nulla avviene nel Paese delle Nevi se non l’inesorabile consumarsi di ciò che nessuna mobilitazione è stata in grado di fermare. I Tibetani sono ormai stranieri in casa propria: una minoranza emarginata che ben poco può cambiare del corso degli eventi. Neppure l’ultima disperata protesta, con le persone che si davano fuoco per richiamare ancora l’attenzione del mondo, ha potuto sortire alcun effetto.
D’altra parte ben pochi potrebbero augurarsi, nei climi attuali, una primavera tibetana. Dopo che quelle arabe hanno aperto la strada a guerre devastanti, con esiti ancora imprevedibili e di giorno in giorno più inquietanti, nessuno oserebbe immaginare le conseguenze di una destabilizzazione della Cina. È così che quest’anno il 10 marzo, anniversario dell’insurrezione di Lhasa, trascorre nel silenzio.
Un silenzio, si potrà dire, eloquente: a condizione però di saperlo interpretare.
C’è tristezza, si diceva; ma i Tibetani stessi vedrebbero in quel che accade un senso spirituale.
In termini buddhisti, le vicende di un popolo sono espressione di un karma collettivo, che opera al di là delle intenzioni e dei progetti. Porre il proprio impegno per lenire gli effetti di una catastrofe storica, come quella di cui il Tibet è vittima, potrebbe sotto questo aspetto non essere risolutivo; pur ponendo i semi di un diverso karma futuro.
Ciò naturalmente non si accorda col modo di pensare dominante in Occidente, compreso quello dei sostenitori del Tibet; in quanto è frutto di una cultura secolarizzata, che ha in gran parte rimosso le sue radici spirituali. Da alcuni secoli siamo avvezzi a concepire le vicende umane svincolate da una sfera trascendente, con la conseguenza che il successo e l’insuccesso diventano l’orizzonte ultimo. Il che ci rende fragili, perché dipendenti dalle circostanze, e incapaci di vedere in esse un disegno più ampio.
L’idea dell’uomo adulto, come uomo che ha il suo fondamento in se stesso, sarebbe un’idea forte solo se il Sé, si direbbe in India, fosse ben distinto dall’Io. In nessun modo infatti l’Io è davvero padrone di se stesso. Se si finge tale, inevitabilmente entra in una prospettiva tragica.
Se dunque la storia non è frutto dei nostri progetti, ma tutt’al più essi partecipano a formare una trama il cui senso è al di là della nostra comprensione e previsione, ciò non significa che essa ci lasci indifferenti. Una visione spirituale non abolisce il dolore ma lo trasforma, purificandolo dalla semplice delusione. Il nostro personale fallimento, infrangendo gli schermi attraverso cui l’Io si autorappresenta, ci mette in rapporto con una più ampia dimensione, il che ci rende tra l’altro capaci di cogliere la sofferenza altrui.
Per questo la storia dei vincitori è meno importante, sul piano spirituale, di quella dei vinti: perché autorappresentazione, quindi proiezione di un Io, tanto più chiuso in sé quanto più ha saputo imporre se stesso agli altri. La storia dei vinti contiene invece almeno il seme dell’apertura alla trascendenza.
Se la Chiesa si alimenta del sangue dei martiri, e non certo dell’appoggio dei potenti, ciò vale anche per ogni altra istituzione religiosa. Non è il Tibet favoloso, depositario di una mitica integrità sapienziale, quello che davvero ci ammaestra. E neppure il Tibet icona mondiale della libertà. È piuttosto il suo martirio a toccarci in profondità; attraverso cui la sua sapienza si traduce in carne e sangue, mostrando da quali sorgenti la libertà scaturisca.
Se un lungo inverno è sceso sul Paese delle Nevi, possa custodire il seme di una nuova vita. Che la potente Cina riesca a dimenticare le sue paure, e consentirsi infine di ascoltare ciò che, dentro di sé, con forza si fa strada. Potrebbe un giorno ritrovare il Tibet, ritrovando così anche se stessa.
Però anche noi Occidentali dobbiamo meditare quello che dal Tibet abbiamo ricevuto. Non solo suggestioni, destinate a decadere, e neppure ideali, che un mutato scenario finisce per spegnere. C’è ben altro, e ancora forse non ne siamo consapevoli.